
Due anni fa Vox pubblicava un articolo intitolato Lavoro nel movimento ambientalista e non mi interessa se fai la raccolta differenziata. L’autrice, Mary Annaïse Heglar, scriveva che non appena le capitava di menzionare il suo lavoro in una conversazione, le persone iniziavano a confessarle i propri o gli altrui “peccati ambientali”, mostrando di avere poca consapevolezza della gravità della crisi climatica. Il modo in cui i mass media affrontano il tema ci spinge infatti a credere che se solo fossimo in grado di fare piccole scelte sostenibili nel quotidiano, come mangiare vegano o smetterla di usare plastica monouso, riusciremmo a salvare il Pianeta. Questo tipo di narrativa sull’emergenza climatica riduce l’ambientalismo da lotta politica a una semplice scelta individuale, dividendo così il mondo in virtuosi e no. A sbagliare è sempre il consumatore. Ogni sua scelta quotidiana si inserisce infatti in un sistema talmente complesso che, anche quando fatta con le migliori intenzioni, finirà comunque per generare un impatto negativo sull’ambiente. Heglar a questo proposito parla di un meccanismo di victim blaming che conduce alla “apatia climatica”: continuando a sentirci accusati per l’insostenibilità ambientale di ogni nostra azione, saremo portati a convincerci sempre di più che ogni sforzo è inutile.

La narrazione mediatica dell’emergenza climatica finisce per concentrare l’attenzione sulla nostra impronta ambientale individuale, tralasciando spesso le responsabilità del capitalismo in quanto sistema di produzione basato sullo sfruttamento delle risorse più convenienti. Il Carbon Major Report 2017 ha evidenziato però come cento aziende, per lo più nel settore dei combustibili fossili, siano responsabili da sole del 71% delle emissioni inquinanti a livello globale. Questo studio dimostra che i responsabili del collasso ecologico sono un gruppo molto limitato di persone e che la “colpa climatica” non è distribuita in modo equo tra tutti gli esseri umani. A questo proposito l’Oxfam report del 2015, pubblicato in occasione degli accordi di Parigi sul clima, ha mostrato che il 10% più ricco della popolazione del Pianeta produce il 50% delle emissioni inquinanti mentre il 50% più povero produce solo il 10% delle emissioni inquinanti. Tuttavia sono i Paesi più poveri a subire in misura maggiore le conseguenze del collasso climatico globale, con una sequenzialità per cui disuguaglianze climatiche ed economiche coincidono. Non solo a livello globale il nord del mondo è responsabile più del sud per l’emergenza climatica, ma anche nei Paesi avanzati la responsabilità delle grandi aziende energetiche non può essere mitigata dalla retorica dei piccoli gesti quotidiani. Bisogna quindi considerare che esiste una responsabilità di classe per la crisi climatica. Da questa considerazione è partito Matt Huber per uno studio intitolato Ecological politics for the working class in cui si analizzano i vari tipi di ambientalismo che si sono succeduti nel corso degli ultimi decenni con l’obiettivo di metterne in luce il principale limite, cioè quello di non essere movimenti di massa, ma anzi di escludere e colpevolizzare la classe lavoratrice. I lavoratori e le lavoratrici delle classi sociali medio-basse rappresentano infatti la fascia più numerosa di consumatori, e spesso sono l’esempio di stili di vita che poggiano su benefit inquinanti e abitudini poco ecologiche.
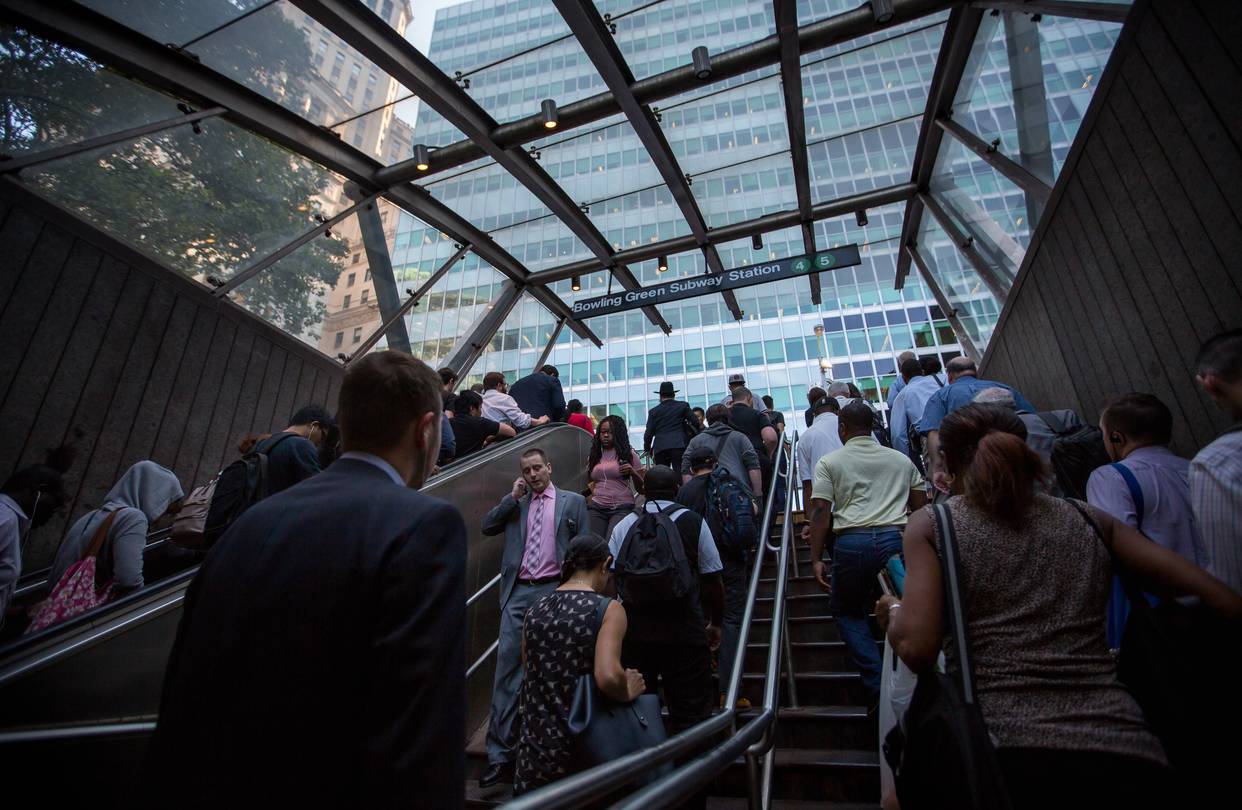
Huber si focalizza in particolare su due tipi di ambientalismo, che partono entrambi dalla premessa per cui lo stile di vita dei consumatori sia la principale criticità. Il primo tipo viene definito lifestyle environmentalism e afferma che si potranno raggiungere risultati ottimali tramite scelte individuali. Questo tipo di ambientalismo non è quindi un vero e proprio movimento politico, in quanto la lotta contro la crisi climatica avviene individualmente e non all’interno di una comunità organizzata. Il lifestyle environmentalism è facilmente utilizzabile dai grandi gruppi produttivi per nascondere le loro responsabilità e riaffermare il proprio dominio. Lo vediamo oggi con il fenomeno del greenwashing con cui le grandi aziende, presentando i loro prodotti come sostenibili da un punto di vista ambientale, cavalcano la diffusa convinzione che esista un modo di consumare green.

L’altro tipo di ambientalismo analizzato dallo studio di Huber è il livelihood environmentalism che si concentra sul ricercare esempi di pratiche ecologiche nelle comunità marginalizzate, per esempio tra i popoli indigeni. In questo modo si finisce per avvolgere in un’aura di romanticismo stili di vita antimoderni e demonizzare ancora di più lo stile di vita del consumatore medio. Negli anni Settanta questi due tipi di ambientalismo, concentrati sulla quotidianità e sulla responsabilità dei singoli individui, porteranno a quella che Erik Von Wright definisce una “fuga dal capitalismo” alla ricerca di micro universi alternativi ed elitari, allontanando definitivamente la lotta ambientale dall’ambito della massa. Il problema del lifestyle environmentalism e del livelihood environmentalism secondo Huber rimane quindi che la crisi climatica non è un problema relativo al tipo di persone coinvolte nella lotta ambientale. La necessità di un movimento di massa è emersa solo con l’idea di “giustizia climatica” nata all’interno del movimento per i diritti civili. L’idea che debba essere data “giustizia” alle vittime dell’emergenza climatica rende protagoniste del movimento ambientalista le nuove generazioni insieme alle comunità marginalizzate e alle classi sociali meno abbienti, legando la lotta ambientalista a quella di classe.

Riconoscere la natura sistemica dell’emergenza climatica non significa arrendersi come individui. Le scelte di vita sostenibili sono utili per creare maggiore sensibilità nelle aziende da cui acquistiamo e per la nostra salute. Come evidenzia infatti il professor Grammenos Mastrojeni nel libro Effetti farfalla, il nostro stile di vita individuale può innescare degli effetti farfalla e quindi produrre conseguenze positive per il Pianeta. Inoltre le decisioni più giuste per il clima sono anche quelle più positive per il nostro benessere psicofisico, a riconferma di come in natura il benessere di ogni specie sia collegato a quello dell’ecosistema che abita.

Tuttavia, nessuna trasformazione sistemica può basarsi solo sulla scala individuale. Heglar nel suo articolo spiegava bene che “la cosa peggiore che puoi fare per il clima è non fare nulla. Bisogna allargare la nostra idea di azioni personali comprendendo tra queste anche la lotta politica”. L’impegno ambientalista deve essere quindi un impegno politico intersezionale che metta in luce le responsabilità dell’intero sistema produttivo e della classe dirigente che ne sostiene le ingiustizie ambientali, sociali ed economiche. Marx diceva che “il capitale non considera la salute e la durata di vita dei lavoratori, a meno che la società non lo costringa a farlo”. Attualmente il movimento per la giustizia climatica è guidato dalle nuovi generazioni ed è contemporaneamente impegnato su più fronti, che vanno dell’antirazzismo alla lotta per la libera affermazione del genere. Un ecosistema migliore in cui vivere non può essere ristabilito senza una decolonizzazione e messa in discussione del sistema capitalista ormai diffuso a livello globale, con l’eliminazione di tutte le disuguaglianze sociali ed economiche, per raggiungere un futuro “giusto” dal punto di vista climatico e culturale. Alla domanda “che cosa posso fare per il clima?” bisognerebbe quindi prima di tutto rispondere che occorre informarsi, sensibilizzare gli altri, organizzarsi in un movimento politico ed agire tramite tutti gli strumenti della lotta politica, dal voto alla pressione tramite scioperi e proteste. Ma mai muovendosi da soli.
