L’ingegnere statunitense Henry Petroski, ricordato come il padre di un approccio al design definito “success through failure”, sosteneva che nella realtà non esistono – e non possono esistere – prodotti propriamente finiti. Nel corso dei suoi studi, infatti, si era convinto che tutte le cose che ci circondano, anche quelle che hanno attraversato un lungo processo di trasformazione, e che quindi dovrebbero aver raggiunto una forma ormai definitiva, siano in realtà parte di un percorso molto più lungo e ampio, che non si conclude con la loro realizzazione materiale, ma rimane aperto alle esigenze dell’essere umano, e all’eventualità che queste ultime, nel tempo, possano evolversi e cambiare. Dalle matite, alle sedie, ai ponti, alle città, per quanto piccola o grande sia la scala, il compito di un buon progetto, secondo Petroski, è quello di mirare a uno stato di perfezione soltanto temporaneo, che potrebbe essere messo in discussione da nuovi bisogni futuri. Sembra una dichiarazione scontata, che niente esiste in senso assoluto, che tutto può essere adeguato a nuove necessità, eppure, in mancanza di forme alternative, ciò che non evolve viene percepito come standard, scontato, immutabile. L’idea di vedere ogni prodotto apparentemente finito non come una conquista definitiva, ma come un semplice passaggio intermedio, è invece fondamentale, perché permette di utilizzare il tempo per migliorare o ripensare la conformazione delle cose che utilizziamo, degli spazi in cui viviamo, individuandone i punti deboli e le richieste ignorate.
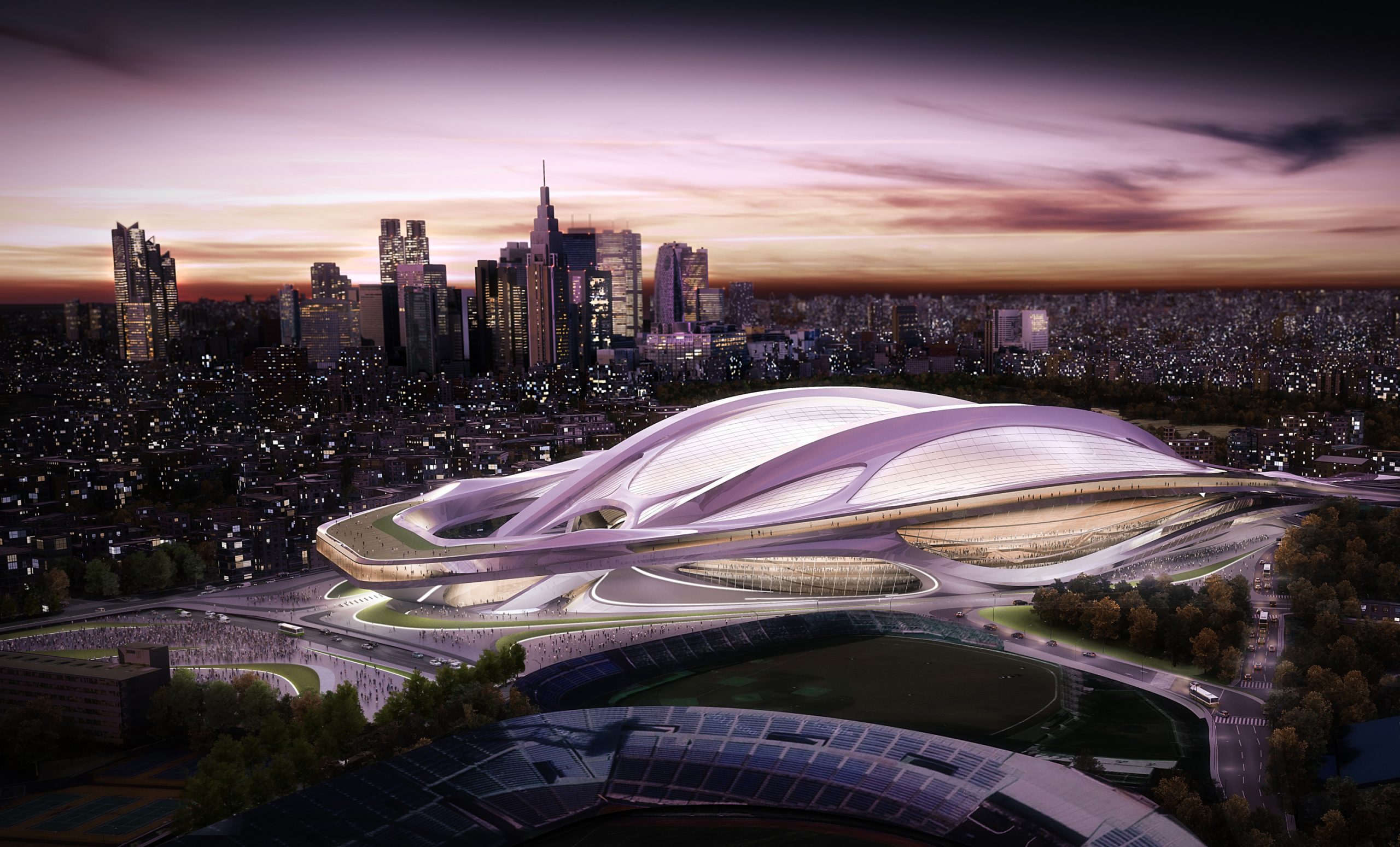
Negli anni recenti, per esempio, abbiamo visto vacillare in modo sempre più evidente lo stato di “perfezione provvisoria” – se non reale, perlomeno percepita – che attribuivamo alle nostre città, soprattutto perché esse non riescono a rispondere adeguatamente a una delle urgenze più pressanti del nostro presente: quella legata alla crescita delle disuguaglianze. La mancata risposta degli spazi urbani a questa esigenza, che risulta sempre più sentita da ampi strati della popolazione mondiale, ha contribuito a cambiare la nostra stessa percezione dei grandi centri, un tempo considerati porta d’accesso a una maggiore qualità di vita e a nuove opportunità, e che oggi vengono invece considerati come strutture che finiscono per replicare – quando non per acuire – le iniquità prodotte dal nostro sistema socioeconomico. Ed effettivamente, l’esperienza conferma come ciò accada su più livelli: dall’insostenibilità dei ritmi di lavoro, che aumentano ulteriormente nella frenesia del contesto cittadino; ai livelli di retribuzione, troppo spesso non commisurati al maggior costo della vita; passando per gli spazi tutt’altro che adatti ai bisogni delle minoranze – soprattutto delle donne o delle persone con disabilità –, o per le difficoltà legate al divario digitale, ancora una volta decisamente più tangibili negli spazi urbani, in cui le attività umane sono accompagnate molto più frequentemente dall’utilizzo di dispositivi elettronici.
Affinché un’esigenza stringente come l’appianamento delle disuguaglianze, di qualsiasi tipo esse siano, non rimanga inascoltata, è dunque necessario che ripensiamo il nostro modo di concepire le città – anche in vista di una ulteriore crescita della loro popolazione. Si tratta infatti, come avrebbe suggerito Petroski, di considerare i centri urbani come parte di una progettualità più ampia, pronta ad accogliere le richieste a cui ancora non ha saputo dare seguito, e che potrebbero essere risolte grazie alla prossima evoluzione degli spazi in cui siamo abituati a muoverci. La trasformazione delle nostre città in smart cities, in questo senso, permetterebbe di agire su molte delle disparità che osserviamo oggi, accelerando la loro estinzione.

La stessa definizione di smart city, “un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti con l’uso di soluzioni digitali a beneficio dei suoi abitanti e delle imprese”, fa riferimento a un concetto che nell’antichità rappresentava il cuore pulsante della città ideale in senso greco: quello per cui ogni tecnologia, risorsa o spunto innovativo deve andare “a beneficio” del cittadino, ed essere quindi modellato in funzione dei suoi fini e del suo benessere. Questo principio da cui le città ricavano la loro “intelligenza” agisce in modo diretto sulle disuguaglianze, perché permette di utilizzare le tecnologie innovative e i nuovi servizi offerti per adattare la loro conformazione a bisogni diversificati, e non a un modello precostituito da applicare indistintamente, costringendo le persone a rientrarvici.
Le smart city, infatti, sono dotate di display, sensori e dispositivi di raccolta dati – adibiti al controllo del traffico, della sicurezza nelle aree pubbliche o dei livelli di inquinamento – che se utilizzati non per controllare, ma per supportare le attività degli abitanti, consentirebbero di realizzare su larga scala degli esperimenti come quello del quartiere femminista di Frauen Werk Stadt (Città delle donne lavoratrici), costruito a Vienna tra il 1995 e il 1997 e composto da 350 alloggi di edilizia popolare. Questo complesso venne realizzato in seguito a un preciso lavoro di osservazione delle statistiche e di ascolto delle cittadine, che permise di mettere in primo piano le loro necessità già in fase di progetto: un asilo nido interno al quartiere, una planimetria che desse accesso a tutti i servizi fondamentali in quindici minuti a piedi, dei cortili comuni e un’altezza degli edifici studiata in modo da garantire sempre la giusta illuminazione, evitando così di creare possibili situazioni di pericolo. Un più ampio lavoro sulla raccolta dati, che le nuove tecnologie hanno già dimostrato di poter sostenere – anche se non sempre con esiti positivi – potrebbe dunque registrare davvero e in maniera precisa le esigenze di ogni fascia della popolazione urbana, e monitorarle periodicamente per verificare eventuali cambiamenti, in modo tale da “personalizzare” l’accesso agli edifici, il rapporto con le strade, o la fruizione del sistema di mobilità, affinché nessuna esperienza venga marginalizzata.

Le smart city, inoltre, possono agire in maniera indiretta sulle disuguaglianze, soprattutto per quanto riguarda il divario digitale. L’italia è un esempio paradigmatico da questo punto di vista, dal momento che il suo ritardo sul piano della digitalizzazione rispetto al resto dei Paesi europei è determinato principalmente dal divario territoriale tra nord e sud. Stando all’indice DESI (Digital Economy and Society Index) registrato quest’anno il nostro Paese si colloca infatti alla diciottesima posizione fra i 27 Stati membri dell’UE, e questo risultato è dovuto al fatto che oltre la metà dei cittadini italiani non dispone di competenze digitali di base. Quella che emerge dai dati, però, non è una mappa omogenea, ma una situazione del tutto sbilanciata in favore del nord del Paese: basti pensare che, su una scala da 0 a 100, l’indice relativo alle competenze digitali della Lombardia è di 72, mentre quello della Basilicata è di 27,8.
Oggi, trovarsi esclusi dall’accesso a infrastrutture e strumenti digitali non significa soltanto perderne gli eventuali vantaggi, ma rischiare di subire un grosso danno socio-economico, rimanendo inevitabilmente ai margini di un mondo che evolve sempre più verso l’informatizzazione, applicandola sempre più spesso e sempre più massicciamente a tutti gli ambiti delle nostre vite. Per questo una graduale transizione verso gli ambienti smart, che proceda in parallelo sia a nord che nel sud del Paese, colmando le lacune delle regioni che ne hanno maggior bisogno – come quella dell’accesso alla connettività ultraveloce, che risulta ancora distribuita in modo molto diseguale anche nelle stesse regioni del nord – consentirebbe di implementare progressivamente la dotazione di strumenti tecnologici e infrastrutturali, riequilibrando così le asimmetrie e le profonde differenze territoriali che ancora segnano il nostro Paese. Questo processo contribuirebbe inoltre a valorizzare ulteriormente le aree meridionali, che accanto a dati negativi sulla digitalizzazione, di recente hanno visto però crescere anche alcuni fenomeni incoraggianti, registrando il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (del 10%, contro l’8,4% medio nazionale) e la nascita di oltre 15mila imprese innovative.

L’accesso alle nuove funzionalità tecnologiche, se accompagnato da adeguati percorsi di formazione, finirebbe per incidere anche sul livello delle competenze digitali, portando inevitabilmente a una redistribuzione del capitale formativo e culturale. Lo testimoniano, per esempio, iniziative come il Fondo per la Repubblica Digitale, nato in Italia nel 2021 per favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie professionali nel periodo post-pandemico. Le valutazioni svolte alla fine dei percorsi di formazione, incentrati principalmente sulle competenze digitali e l’approccio alle nuove tecnologie, hanno infatti rilevato degli effetti positivi e duraturi sulla vita professionale degli iscritti, sia in termini di salario, sia per la probabilità di essere occupati; ma anche una generale diminuzione della vulnerabilità sociale nel caso di chi aveva partecipato ai programmi partendo dalle nozioni basilari. Vivere in città dotate di tecnologie simili, che per essere abitate hanno bisogno di un approccio attivo dal punto di vista digitale, probabilmente avrebbe effetti positivi a lungo termine anche sul piano sociale ed economico, portando tutti i cittadini ad acquisire le stesse abilità, e così ad avere accesso alle stesse opportunità lavorative, e plausibilmente alla stessa retribuzione.
Il modo, sia diretto che indiretto, in cui le smart city potrebbero contribuire ad appianare le disuguaglianze che ancora permeano le nostre città convalida l’idea tutt’altro che scontata per cui la qualità della nostra vita, così come il benessere collettivo, sono fortemente determinati dal luogo in cui viviamo. Muoversi, lavorare e trascorrere il proprio tempo libero in spazi che veicolano valori positivi come quello dell’equità – socioeconomica, di genere, o legata alla redistribuzione della formazione e delle opportunità – permette infatti di non assolutizzare un’unica esperienza, quella considerata più “conforme” agli standard sociali, appiattendo la vita di tutti i cittadini su un percorso standardizzato, magari nemmeno adatto alle loro reali esigenze. Al contrario, porterebbe un’intera comunità a lavorare congiuntamente sul proprio stato di benessere e sul proprio ritmo di sviluppo, consentendo a ciascuno di contribuire nel modo più efficace.
Lo stesso percorso – etico, sociale e politico – dell’umanità è infatti una sorta di progetto che procede per conquiste successive e nel bene e nel male mai definitive. Per questo, dare alla nostra progettualità esistenziale la direzione che vogliamo significa anche costruire uno spazio adatto alla sua realizzazione, che sia nella forma di una città più equa, oppure, per estensione, in quella di un ecosistema digitale virtuoso, in grado di migliorare la nostra vita.
Questo articolo è realizzato da THE VISION in collaborazione con Telepass, tech company all’avanguardia nella rivoluzione della mobilità in un’ottica sempre più innovativa e sostenibile. Grazie a un’unica app che tiene insieme un esclusivo metodo di pagamento e una pluralità di servizi legati alla smart mobility, come le strisce blu, il carburante o la ricarica dell’auto elettrica, l’uso di monopattini, bici e scooter in sharing, l’acquisto di biglietti per treni, pullman e voli, dello skipass per sciare, Telepass trasforma ogni spostamento, anche quelli in montagna, in un’esperienza senza confini.
Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom