Una delle cose che mi ha sempre affascinata e incuriosita della vita, apparendo per me come un vero e proprio enigma, è l’imperscrutabile incastro di eventi, sensazioni, storie, chimica, preconcetti, sogni e pensieri che porta a quell’alchimia che ci fa scegliere di iniziare o meno una relazione con un’altra persona. Questo fenomeno non ha assolutamente a che fare col “merito”, anche se la nostra cultura ce lo fa credere, in particolare a noi donne. Se vieni scelta te lo meriti, se vieni scelta è perché vali, se vieni scelta è perché hai qualcosa in più delle altre, come fossimo bambole appoggiate sullo scaffale di un negozio in attesa che qualcuno valuti le nostre caratteristiche, come se noi non potessimo scegliere a nostra volta, agire questa decisione. In realtà basta una rapida occhiata per capire che questa “scelta” – il fatto che qualche essere umano dotato di pene te se piji, insomma – non è assolutamente dettata (e per fortuna direi) dai nostri meriti o dal nostro valore intrinseco, dal nostro cv, dalla tonicità del nostro culo, o dalle nostre “doti” e capacità – idea che affonda le sue radici nei tempi dei matrimoni combinati: come mi disse un’amica indiana “Le nostre famiglie qui ci fanno laureare non perché così intraprenderemo davvero la professione per cui stiamo studiando, ma perché una donna che ha studiato si posiziona meglio” – ma al massimo, ancora oggi, certo, in Italia sicuramente, soprattutto in questi tempi di crisi, in alcuni casi è dettata dal tuo patrimonio familiare – ma anche in quel caso non è “merito” nostro.

La cosa più affascinante di questo processo è che non ha minimamente a che fare con l’amore, anche se spesso viene scambiato per tale, grazie a quel pasticcio culturale che ci è stato dato in eredità. Ha a che fare soprattutto con le nostre proiezioni, idealizzazioni, fantasie, e non ultimo con le pressioni sociali che più o meno consapevolmente subiamo, insomma è un gioco d’azzardo, che ci sforziamo di credere abbia invece una logica, che dipenda da noi. Non restateci male dunque se qualche malalingua dice che “non sa cosa ci trova in voi” il vostro compagno o la vostra compagna, perché è come se si cercasse di capire il valore di una sinfonia di Mahler con la bilancia della macelleria, è proprio un’equivalenza impossibile. È chiaro infatti che nessuno, per quanto vicino, capirà mai, nel profondo, da cosa è partito un legame, perché i due artigiani che lo hanno iniziato a intrecciare hanno scelto certi materiali, certi colori, un determinato ordito, e soprattutto perché hanno continuato a stringerlo. Tutto questo mi è tornato in mente guardando Love, il film dello scrittore e regista norvegese Dag Johan Haugerud, disponibile su MUBI. Non una storia d’amore nel senso più tradizionale del termine, ma una riflessione dolce, lancinante e profonda sul modo in cui oggi ci avviciniamo agli altri, sul desiderio, sulla vergogna, sulle aspettative, sul corpo, sulla malattia, e su quel bisogno primitivo e modernissimo insieme che abbiamo di sentirci amati, di cura e di accudimento, di vicinanza.

Siamo a Oslo, una città silenziosa, quasi rarefatta, ma al tempo stesso viva nei suoi ritmi lenti, piena di finestre illuminate, di voci sottili, una città dalla formazione geologica “poetica”. E qui vive Marianne, urologa, donna che sta andando verso i quaranta, attenta e riflessiva, di una dolcezza contenuta e precisa, eppure al tempo stesso molto razionale, cinica, quasi distaccata. Marianne non è una protagonista in senso classico, ma è l’orecchio teso di tutto il film. Una donna che ascolta, e attraverso il suo ascolto sembra ascoltare anche la città stessa. Proprio come la statua che si trova nel municipio, la ragazza di Oslo, anche se Heidi, la migliore amica di Marianne, ci tiene a sottolineare che sia una donna, la donna di Oslo, sottolineando molto bene l’awareness dell’autore rispetto ai temi caldi della sensibilità femminista, che passano anche per l’essere stanche di essere eterne ragazze, dal rivendicare il peso di un’età matura, di una libertà responsabile. La donna di Oslo, insomma, è l’immagine cardine di tutto il film, che riappare anche in chiusura, incarnata dalla cantante che darà voce alla canzone composta grazie a Heidi per celebrare la città. Una mano sulla testa come a segnare un orizzonte, una direzione, una statura, e una all’orecchio, per ascoltare le voci, i sogni, i bisogni degli abitanti della città.
Inizia così un viaggio in varie storie di donne e di uomini che si intrecciano, in dialoghi attutiti, gesti disarmanti, di una tenerezza sottile e quasi dolorosa, che sembrano sussurrati, in stanze dove si parla di sesso, d’amore e di sogni con la stessa naturalezza con cui si chiede “Vuoi un bicchiere d’acqua?”. Con spontaneità, e totale autenticità, come se i personaggi fossero costantemente nudi, totalmente presenti nella relazione con l’altro, nel qui ed ora. E questo ha una carica erotica capace di togliere il respiro. Come una cesura che interrompe il normale flusso del reale, una di quelle pause che fanno la musica più delle note. Ci sono vari femminili e vari maschili, ciascuno con le proprie fragilità e caratteristiche, ma tutti disposti ad avvicinarsi all’altro, nonostante i luoghi comuni sulla società e la cultura nordica, che a ben vedere sembra essere molto più desiderante e sveglia di quella attuale mediterranea.
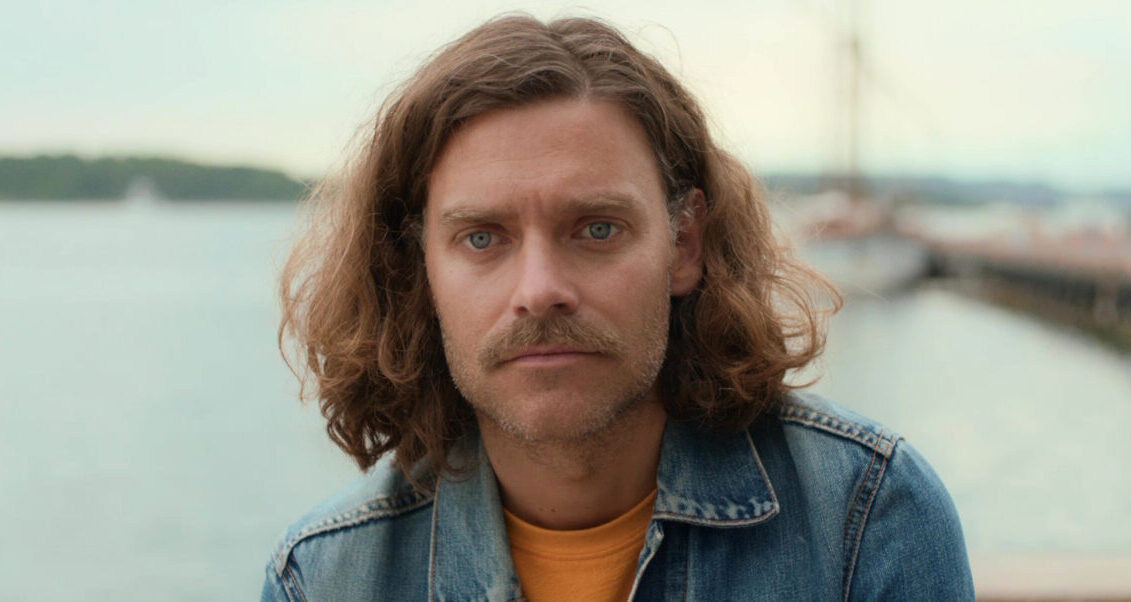
C’è Tor, l’infermiere, che mostra come il prendersi cura, l’aiutare e l’interessarsi ai bisgno dell’altro possa essere un atto profondamente erotico, e che riesce a restituire dignità anche ai corpi che soffrono di incontinenza o di disfunzione erettile, sensibile, attento. Perché non c’è nulla di più intimo della fiducia. C’è “il geologo”, Ole, che “scrive molto di rocce, legge molto di rocce, si siede molto sulla sua poltrona”, e che sa “sentire il canto delle rocce” – frase che nel film suona come una dichiarazione d’amore al sapere sensibile, fisico, tangibile, capace di parlare al corpo prima che alla mente, che è semplice fisiologia, “un incontro tra il sapere e la percezione fisica”. Anche questo, forse soprattutto questo, è amore. E sicuramente anche questo è erotismo. C’è il carpentiere, che nella sua semplicità, e nel suo essere ben lontano dalla riflessione femminista, sembra per certi aspetti più libero di Heidi, e non capisce perché un desiderio così grande, limpido e spontaneo come quello fisico, l’impulso ad avvicinarsi all’altro, debba per forza essere colpevolizzato, debba per forza essere visstuo come “sporco”, nascosto, come sottolinea l’esperienza di Bjørn, lo psicologo omosessuale di cui si prende cura Tor, che è una specie di angelo custode.
In Love tutto è erotico. Parlare davvero, mostrare la propria rispettiva grafia – “visto che non succede più” –, dormire insieme “come antidolorifico per entrambi”. Anche aiutare qualcuno con la spesa. Il film ci ricorda che qualsiasi cosa può essere “bella”, come dice Tor. Che l’erotismo è ovunque, e che non si misura né si pianifica, né si dovrebbe giudicare a priori o a posteriori, basterebbe esserci, sempre, con tutti noi stessi. L’attenzione – diceva la grande filosofa e mistica Simone Weil, il cui pensiero sembra informare nel profondo la visione del regista – è la prima forma d’amore. Sempre Bjørn: “Non credo di avere più niente che possa eccitare qualcuno”. E lo dice con una tenerezza che spacca il cuore. Perché non parla solo di sesso, ma del timore più grande che abbiamo: quello di non poter essere desiderati, visti, riconosciuti, amati. È qui che entra in gioco quella parte di noi che si sente rotta, sempre troppo tesa, impaurita, inadeguata. “Solo sesso?” dice Marianne. E il carpentiere con cui fa l’amore al porto le risponde, “dici poco”.

Il film attraversa il tema del poliamore con una delicatezza davvero fuori dal comune, sempre in maniera tangenziale, delicata, onesta. Senza didattica. Senza slogan. Portando alla luce con poche parole essenziali le domande che ciascuno di noi si è scoperto almeno una volta nella vita a porsi. “Mi sembra quasi puerile amare solo una persona”, dice un’altra grande mistica, Etty Hillesum, nei suoi Diari che Marianne sta leggendo. E non lo dice per provocazione, ma come se esprimesse una verità semplice, una tautologia, e ciascuno di noi nel profondo del suo cuore sa che è così vero. Lo sa di sicuro ogni madre. E la sua mistica attraversa tutta la narrazione del film, la vita dei protagonisti, lo sguardo che Haugerud ci invita a rivolgere agli altri esseri umani. “Dovresti proprio leggere questo libro,” dice a Ole, e un po’ è come se lo stesse consigliando a tutti noi spettatori. È anche interessante che all’inizio i personaggi maschili non vengono chiamati per nome, ma attraverso la loro professione, e poi mano a mano che la storia avanza, iniziano ad apparire i nomi propri, sempre più spesso.

Le relazioni diventano così parte della creazione, della nostra capacità di costruire un senso a partire dai nostri bisogni, e non dai modelli imposti. C’è un uomo sposato con figli su Tinder, che si sente in colpa perché “le donne non sposate si aspettano sempre di più”, un di più che gli uomini sentono di poter dare loro, e allora un amico gli suggerisce di fare come fa lui, di immaginare che siano tutte puttane, travestite da donne libere. Ma in realtà ha solo paura. Paura di essere visto davvero. Paura di perdere il controllo. Paura di dover spiegare chi è, anche alla sua stessa moglie, paura di non essere accettato e di non accettarsi. E c’è lei, Marianne, che guarda tutto questo e ascolta, che sembra non arrabbiarsi mai. Che osserva paziente, rassegnata, se stessa e gli altri, senza giudicare, forse perché non si aspetta più nulla e proprio per questo è libera. C’è anche l’amica, Heidi, che un tempo parlava di libertà sessuale e poi accusa Marianne della sua libertà sessuale, mostrando in realtà la sua insicurezza, e se da un lato quello sembra un giudizio e un attacco improvviso dall’altro è anche il messaggio onesto di un’amica che non ha paura di dire ciò che pensa, e che mostra a Marianne una dinamica di sé che non sarebbe stata pronta ad accettare, e il riconoscerla, la cambia. Heidi si sente messa in pericolo, noiosa, banale, perché è diversa, perché è sposata, perché sta bene con una sola persona, e perché quando una donna si libera, spesso diventa uno specchio che può fare male a tutte le altre. E infine c’è la malattia. La prostatectomia, la paura, l’ansia maschile, la vulnerabilità. “Non abbiamo la capacità di affrontare il dolore che segue un’operazione. Ci vantiamo solo di averti curato. Ma guarire è un’altra cosa”, ammette Marianne a Ole, spoglia del camice bianco da medico, della sua autorità, libera anche da quel ruolo, semplice, vestita dell’amore che trapela dagli occhi di lui. Questa frase potrebbe essere il cuore di Love. Curare – o meglio asportare ciò che fa male, meccanicamente, chirurgicamente – è facile. Guarire, invece, richiede tempo, presenza, attenzione, è un cambio di forma, come da crisalide a farfalla. Richiede che qualcuno ti guardi mentre dormi e non si spaventi se tremi. L’esserci. Ed è questo l’amore, in tutte le tante forme che può assumere, e che spesso paradossalmente nei nostri rapporti non si affaccia nemmeno da lontano.

C’è un momento in cui suonano le campane della chiesa, e sembra un rito pagano e moderno insieme. E poi c’è la colonna sonora di Peder Capjon Kjellsby, ipnotica, inquieta, sospesa, che in alcuni momenti sembra uscita da un contesto indie, in altri da un film di Miyazaki, incarnando alla perfezione la sospensione della luce del nord, della scandinavia, i suoi cieli limpidi, le sue architetture austere, rarefatte, così come quei momenti di assoluta lucidità emotiva, di epifania. Ogni scelta sonora del film arriva dritta al cuore. “Devi avere più fiducia nella gente”, dice Tor a Bjørn. E non è buonismo, è la semplice verità di chi ha capito che l’unico modo per restare vivi, oggi, è avere il coraggio di lasciarsi guardare. Anche quando si ha paura. Anche quando non si sa più bene chi si è, o non lo si è mai saputo.

Nel finale, Tor, Marianne e Heidi escono tutti insieme dal traghetto, per andare a lavorare, felici. La citazione al finale della trilogia dei tre colori chiusa dal film rosso di Kieslowski è chiarissima. E infatti anche Love è l’ultimo film di una trilogia tematica sui rapporti umani cominciata con Sex e Dreams. Come nel film Rosso, anche qui non sappiamo cosa succederà. Ma sappiamo che qualcosa di grande è successo, qualcosa che ha a che fare con l’amore. Che due esseri umani si sono visti, si sono parlati, si sono toccati, si sono raggiunti, anche se per breve tempo. Love non è un film su una storia d’amore. Love è un film sull’amore assoluto, totale. Su tutte le sue forme. Su tutte le sue crepe. Su tutti i suoi corpi. E su quel mistero, profondamente umano, che ci fa ancora desiderare di entrare in relazione l’uno con l’altro, nonostante tutto.
“Love” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.
Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom