Spesso mi chiedo se sia nata prima la sinistra italiana o la crisi della sinistra italiana. Le analisi d’altronde si sprecano da decenni, e di solito l’inizio della caduta viene associato ad alcuni passaggi storici come la morte di Enrico Berlinguer, il crollo del Muro di Berlino e la fine del PCI. Questi sono eventi che sicuramente hanno segnato la fine di un percorso, nessuno lo nega. Sono, o dovrebbero, essere riconducibili però alla fine del comunismo, non della sinistra tout-court. In Europa i pochi Paesi con la sinistra al potere hanno una matrice socialista al governo. Ed è proprio da questo termine, “socialista”, che bisogna partire per capire come in Italia “socialista” e “comunista” fossero un tempo addirittura sinonimi, per poi prendere direzioni opposte e rendere il primo quasi un’offesa. Forse, se dopo la Prima Repubblica la sinistra è collassata su se stessa non è per la fine dell’utopia comunista, ma perché il PSI – il partito di Pertini, Matteotti e Turati – è finito in una tomba ad Hammamet e non ne è più uscito.

Prima della nascita del PCI, i socialisti si dividevano in riformisti – coloro che vedevano nelle riforme lo strumento per cambiare la società – e in massimalisti, ovvero i politici che consideravano necessaria la rivoluzione, quella di matrice sovietica. Dal 15 al 21 gennaio del 1921 si tenne al Teatro Goldoni di Livorno il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, e arrivò l’inevitabile frattura. Figure di spicco tra i massimalisti, come Bordiga, Gramsci e Togliatti, abbandonarono la sala e si spostarono al teatro San Marco per fondare il Partito Comunista d’Italia. Turati, Pertini e Matteotti rimasero invece al Goldoni, ma l’anno seguente diedero vita a un’altra scissione tra i socialisti, fondando il Partito Socialista Unitario. L’ennesima divisione avvenne pochi giorni prima di un evento che la sinistra, impegnata nella propria guerra fratricida, aveva sottovalutato: la Marcia su Roma.

Da quel momento socialisti e comunisti hanno smesso di essere “la stessa cosa”. I primi hanno continuato a scomporsi e ricomporsi, i secondi hanno seguito un percorso durato decenni che li ha portati dal giogo di Mosca all’ombrello della Nato. Solo in poche occasioni queste due fazioni non si sono detestate tra loro. Principalmente durante la Resistenza, la Liberazione, la nascita della Repubblica e della Costituzione. Per il bene del Paese le due sinistre collaborarono, e nel 1947 azzardarono addirittura un’alleanza elettorale che però non andò a buon fine. I socialisti hanno sempre rimproverato ai comunisti l’eccessiva dipendenza da Mosca. Dopo la rivoluzione ungherese del 1956, i rimproveri poi si sono trasformati in metaforiche coltellate. I comunisti, a loro volta, hanno sferrato attacchi contro i socialisti per la scelta di entrare nei governi democristiani degli anni Sessanta, scelta che ha comportato ulteriori scissioni anche nel PSI e un crollo nelle preferenze elettorali. Entrambi, socialisti e comunisti, in cuor loro sapevano che era necessario un cambiamento e che gli anni Settanta avrebbero rappresentato un punto di svolta, sotto due nomi e due volti: Bettino Craxi ed Enrico Berlinguer.

Io, da ragazzino, quando andavo a scuola, nemmeno sapevo che Craxi fosse un politico di sinistra. Leggevo riferimenti al Pentapartito, ai favori che fece a Silvio Berlusconi, alla Milano da bere, a Tangentopoli. Nella mia testa era un democristiano, e di conseguenza l’Italia per cinquant’anni era stata esclusivamente sotto la guida scudocrociata. Crescendo, ho studiato il “Vangelo socialista” di Craxi: l’avvicinamento alle politiche liberali, la netta presa di posizione distanziandosi dal marxismo e dal leninismo, il garofano rosso al posto della falce e del martello, l’apertura totale al libero mercato. Anche Berlinguer si smarcò progressivamente dall’Unione Sovietica – ma non dai principi originari del marxismo – e tentò addirittura un avvicinamento alla DC con il compromesso storico. Eppure, le differenze erano sostanziali. Berlinguer accettava la Nato ma non la sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, voleva un comunismo europeo ma non un abbraccio al capitalismo occidentale. Craxi, invece, accorpò nel termine liberale diverse anime, comprese le più lontane dalla galassia di sinistra. Dopo Mani Pulite, il lancio delle monetine e gli scandali che fecero crollare la Prima Repubblica e il PSI, non è un caso che parecchi esponenti del partito socialista siano poi finiti sotto l’ala berlusconiana. Come se fosse un approdo naturale. Oggi, stride quasi immaginare Cicchitto, Brunetta e Baget Bozzo come politici socialisti, eppure lo erano.
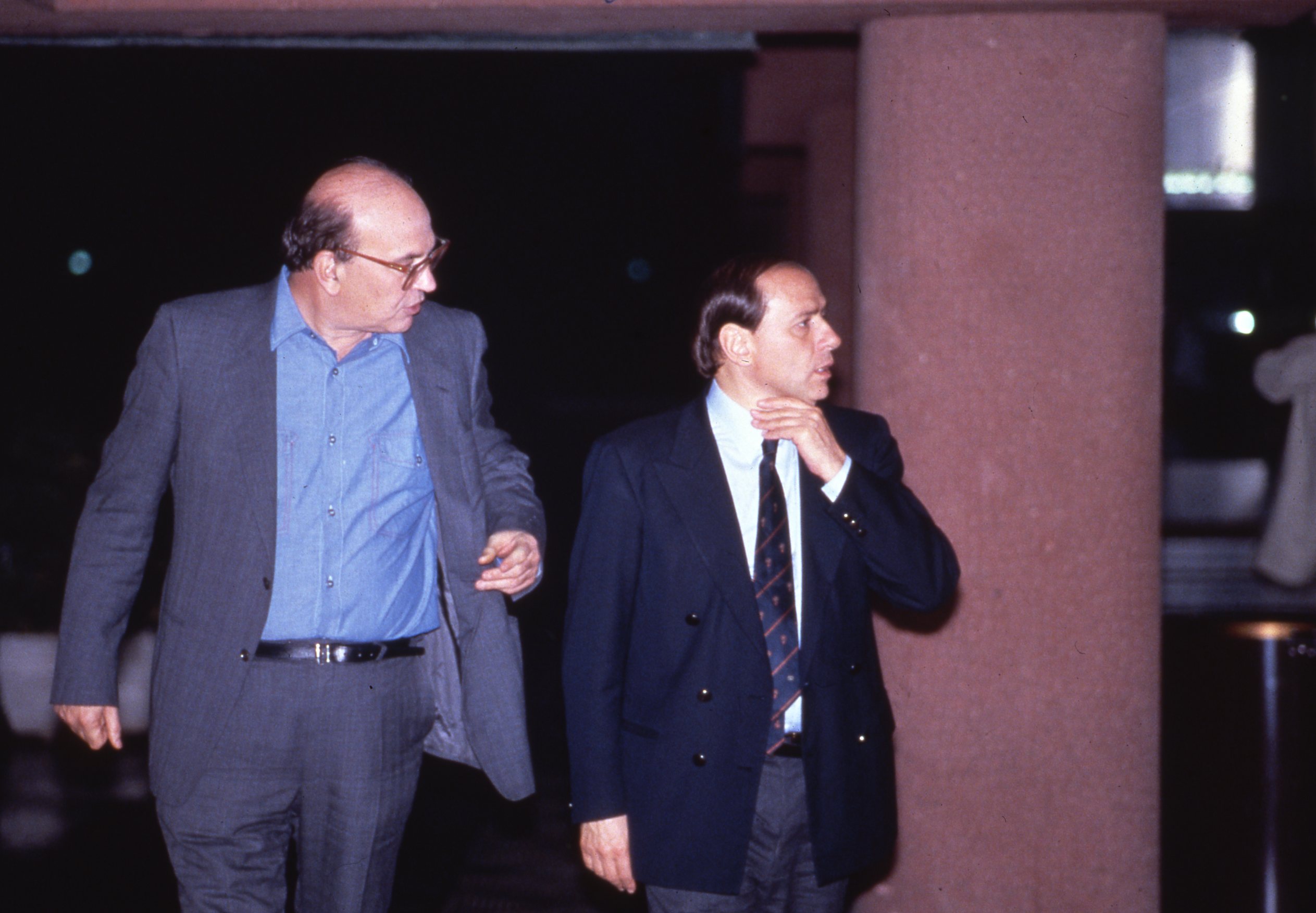
La diaspora dei socialisti dopo Tangentopoli è stata particolare. Molti, come detto, finirono nei partiti di centrodestra perché malvisti dalle nuove realtà di sinistra: erano “i ladri”, “i corrotti”. Altri tentarono di creare nuovi partiti socialisti senza successo. Qualcuno riuscì pure a entrare nell’Ulivo prima e nel PD poi, ma cancellando il proprio passato. Ed è un peccato che l’intera esperienza socialista in Italia sia esclusivamente riconducibile a Tangentopoli o agli inciuci con la Democrazia Cristiana, perché questo ha impedito alla sinistra di porre delle nuove basi sulle fondamenta del socialismo finalmente staccato da Mosca. All’estero è stato possibile farlo proprio perché non ci sono state delle Tangentopoli a disintegrare l’intera ideologia socialista. La memoria italiana, invece, era ancora legata a De Michelis a ballare con un cocktail in mano, al poltronificio parlamentare e a una sinistra dura e pura, quella operaia, che è sempre stata associata al PCI, mentre il PSI intrallazzava con la DC. La superiorità morale comunista ha smosso le masse molto più del pragmatismo dei garofani rossi: ci si ritrovava davanti alle fabbriche, mentre l’altra sinistra si dava appuntamento nei night. Eppure, il Presidente della Repubblica più amato di sempre, Pertini, era un socialista. Non è bastato: la memoria socialista è stata deturpata dalla personale battaglia di Craxi contro i comunisti, a suo dire mandanti delle sue sventure. Loro a uscire da Tangentopoli con lo smoking bianco; il PSI con il vestito da morto.


Nel libro di Ugo Intini Craxi: Una storia socialista, viene citata una frase pronunciata proprio dal leader socialista prima dell’esilio ad Hammamet: “Se proprio i comunisti non potranno essere fermati, abbiamo una carta di riserva. Bisogna che Berlusconi entri in politica personalmente”. Fu l’anatema finale sui sogni futuri di un’Italia socialista. Non a caso sia Bobo che Stefania Craxi, i figli di Bettino, hanno avuto in seguito dei ruoli nelle coalizioni berlusconiane. Così, oggi, nelle sedi locali del PD campeggia la foto di Berlinguer, non quella di Craxi, nonostante la natura piddina sia paradossalmente più vicina al PSI craxiano che al comunismo di Berlinguer: realtà liberale ormai del tutto assorbita, lotta politica alla sopravvivenza e all’ottenimento delle posizioni di potere, istanze socialiste tradite. Fa rabbia pensare che in Paesi come la Spagna o la Germania siano al potere partiti socialisti, mentre da noi la damnatio memoriae abbia totalmente cancellato i principi fondativi del concetto di socialismo, che sono ben più antichi del periodo sovietico e del comunismo novecentesco. Sono infatti ideali che si rifanno alla riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche, e nel resto del mondo si sono sviluppati andando a braccetto con il sigillo della democrazia, a differenza di parecchie esperienze comuniste che invece sono sfociate in dittature.
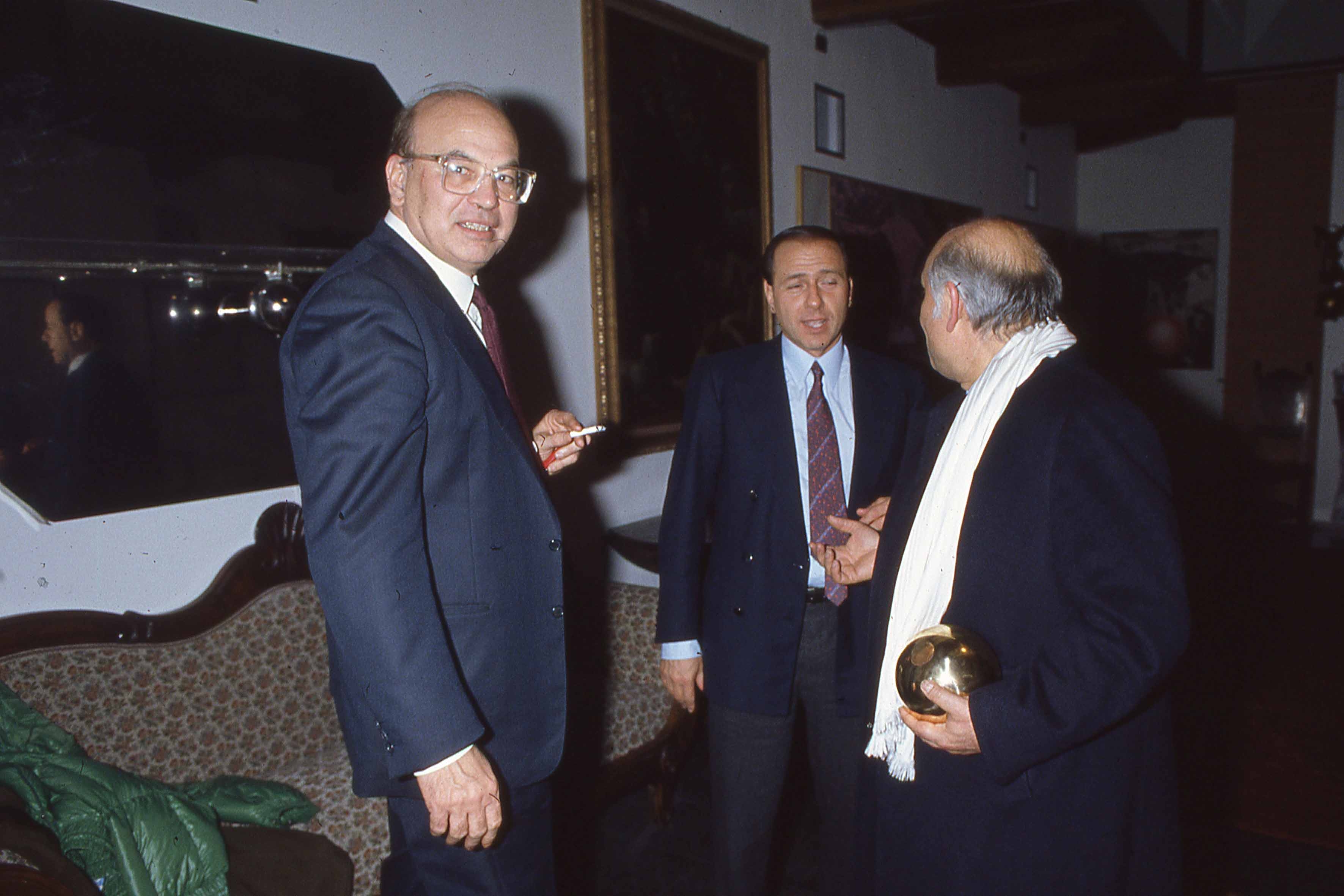
Forse dovremmo riabilitare la parola socialismo, toglierle quel velo della discordia che si porta con sé, impigliato a certi scandali del passato. D’altronde abbiamo digerito il fatto che Mussolini all’inizio della sua carriera fosse un convinto socialista, e la Germania ha superato l’equivoco del termine nazionalsocialismo a definire il nazismo. Il socialismo è l’unica strada per ripartire a sinistra, e nel terzo millennio non può che essere sinonimo di progressismo. A costo di tornare al riformismo di Matteotti e Turati e contemplare quella che all’epoca era un’alternativa alla rivoluzione sovietica e che oggi dovrebbe essere il faro per una sinistra libera dai propri fantasmi. Nel suo ultimo film, Il sol dell’avvenire, Nanni Moretti strappa un poster di Stalin. Sì, in Italia l’abbiamo fatto da decenni, già ai tempi del PCI, ma metaforicamente è necessario rimuovere da quella parete tutto ciò che lo stalinismo ha generato di rimando, ovvero quella che al tempo era la teoria del Socialismo in un solo Paese. Oggi deve esistere un socialismo universale, e deve essere quello di Pertini, dei partigiani delle Brigate Matteotti, di una visione internazionale del futuro. La rivoluzione non può che essere socialdemocratica, anche se nella nostra sinistra di socialismo sembra che non ci sia più nemmeno l’ombra, ed è un peccato.