
Le teorie del complotto sull’emergere del “marxismo culturale” pagano un tributo bizzarro all’influenza duratura di Gramsci. YouTube è pieno di seguaci dell’alt-right che spiegano come un marxista, demoralizzato dalla passività dei lavoratori, abbia deciso che fosse meglio dirottare la borghesia dal suo interno. Se dovessimo davvero credere a questi luminari, gli asterischi dei Social Justice Warriors e il tentativo dei Musulmani di “bandire il Natale” sarebbero le armi fondamentali del marxismo culturale attraverso cui abbattere l’edificio dell’ordine borghese.
Gramsci insisteva sul fatto che il suo partito dovesse lottare per l’egemonia su più livelli, ma oggi le sue argomentazioni sono ironicamente “egemonizzate” da forze politiche opposte. Come nota Angela Nagle nel suo recente libro sull’alt-right online, le figure che si sono lamentate del “marxismo culturale” hanno preso il posto della sinistra nell’attingere spunti dal nucleo della strategia di Gramsci. Andrew Breitbart, fondatore dell’omonimo sito alt-right, ha riassunto bene questa dinamica nel credo del “La politica sta a valle della cultura”.

Paradossalmente l’alt-right ha almeno il merito di aver compreso Gramsci per quello che è: un pensatore conflittuale e politico. Nella sua traduzione destrorsa, però, questa non è la principale influenza che oggi esercita; influenza che è stata soprattutto quella di leader del Partito Comunista italiano. Gran parte del mondo lo descrive come una figura “nota ma non conosciuta”, discussa nelle università anglosassoni come “un grande teorico di cultura” anziché “un intellettuale comunista”. A chi lo chiama ‘Gramski’ importa sicuramente poco della centralità del suo ruolo, soprattutto politico, all’interno della scena italiana.
Dalla caduta del partito nel 1991, gli studi su Gramsci sono stati più intensi nel mondo anglofono e in America Latina che nella sua stessa patria. Ad affossare il Gramsci politico è stato soprattutto il particolare ruolo da lui rivestito nell’iconografia della sinistra italiana. Dopo la sua morte, il Pci lo ha riproposto più come icona di legittimazione dell’ultima linea del partito che come fonte di conoscenza. La sua santificazione non ha fatto altro che renderlo ancor meno umano, come se la raccolta del suo pensiero costituisse una Bibbia politica ordinata dal divino. Come se Gramsci avesse parlato di cose poco “terrene”.


Da studioso della Resistenza, vedo costantemente questo eccesso di iconografia nella storia di Gramsci. La sua influenza sulla guerra partigiana è stata eterogenea: i suoi ultimi testi giornalistici risalgono ad almeno due decenni prima, e solo dopo il 1948 i suoi Quaderni del Carcere, la cui esistenza fu per la prima volta annunciata sull’Unità nell’aprile 1944, furono finalmente disponibili. L’associazione tra questo martire del fascismo e la Resistenza è stata in grado di generare un’attenzione – e un potere – molto più emotiva e simbolica rispetto a una discussione sulla sua importanza nei primi anni del comunismo italiano.
La fama di Gramsci beneficia del fatto che non si sia mai sporcato le mani di sangue nelle battaglie politiche decisive nel periodo tra le due guerre. Aver scritto il suo più grande lavoro in prigione gli ha dato una qualità senza tempo: sebbene non abbia mai attaccato frontalmente lo stalinismo (che ha raggiunto il suo picco quando lui era già in prigione), Gramsci è riuscito a produrre un diverso e specifico canone marxista italiano, decisivo per il Pci.

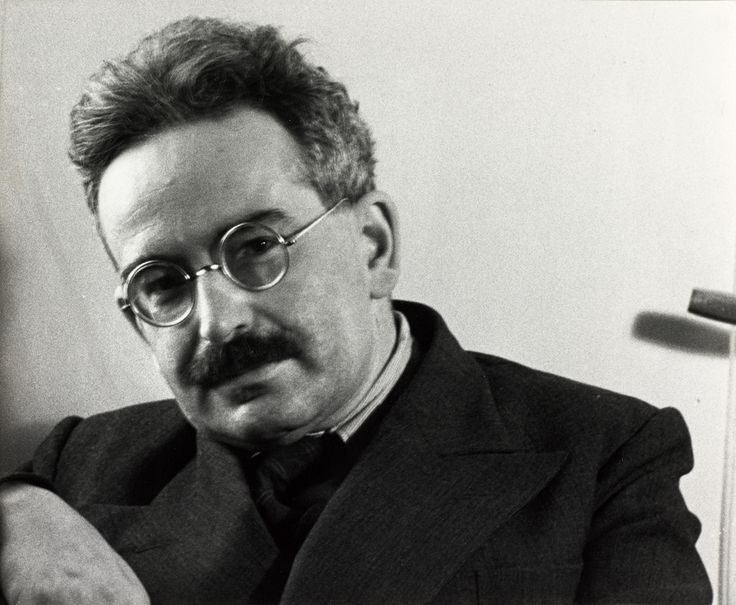
In giro per il mondo, i comunisti dissidenti hanno potuto abbracciare questa figura non ortodossa e la sua eredità, già anche al centro del più grande Partito Comunista dell’Occidente. Palmiro Togliatti trasse letteralmente in salvo i Quaderni del Carcere, eppure, insieme, presentò Gramsci come un generico “martire antifascista” e “grande italiano”, legando il partito a un’identità repubblicana e nazionale, ma anche a una maggior flessibilità nella tattica e nell’approccio.

Nei Quaderni del Carcere ci sono elementi che giustificano questo atteggiamento: Gramsci si è concentrato su specifiche condizioni dell’Italia per spiegare non solo perché la tattica russa non potesse essere meccanicamente applicata all’Occidente, ma anche le ragioni delle sue particolari strutture di classe, ereditate dalla storia italiana e dall’unificazione nazionale. Questo non ha portato a un’accoglienza generica della socialdemocrazia riformista o a un appello per “l’unità nazionale” negli interessi di ripetere il Risorgimento in modo diverso.
Durante la Resistenza il Pci ha abbracciato la nozione di “secondo Risorgimento” nel nome dell’unità nazionale, nonostante queste parole ovviamente provenissero da Giovanni Gentile, piuttosto che dal principale martire del partito. Negli anni ’70 le forze di estrema destra, a loro volta, cercarono di ricollegare Gramsci alla medesima tradizione. Per la Nuova Destra di Alain de Benoit, sia il pensatore sardo sia il filosofo fascista furono icone di un socialismo “anti-internazionalista, anti-materialista” e anti-comunista.
Nonostante questo tipo di discussioni siano ormai datate, oggi Diego Fusaro riscuote un successo non indifferente (e ha costruito una carriera) proprio riproponendole al pubblico italiano in forma provocatoria. L’avvicinamento di Gentile al leader del Pci, nel suo libro Antonio Gramsci, è in sostanza un miscuglio rossobruno, fondato sul presente scontro tra il ‘nazionale’ e ‘le forze di mercato della globalizzazione’, nel superamento delle divisioni tra destra e sinistra.
Questo superamento suona, tristemente, come la promessa del primo fascismo, per cui non sorprende che Fusaro ora scriva di Gramsci e Marx (e Gentile) per il giornale di CasaPound, Il Primato Nazionale. Nessun problema se Gramsci spese i suoi ultimi anni di vita da prigioniero del fascismo, o se Gentile venne ucciso da partigiani comunisti. Che rilevanza rivestono queste vecchie divisioni politiche quando possiamo tutti essere d’accordo sul fatto che “ha fatto anche cose buone”?
La lettura storicamente analfabeta di Fusaro riflette i nostri costumi post-moderni, in una morte del progresso che consente a tutti i tipi di cazzate di essere proiettate al sicuro, dietro un Gramsci depoliticizzato. Non c’è nessun comportamento più ciarlatano di quello che apostrofa Gramsci difensore della necessità di ascoltare gli intellettuali. Non importa che tra i suoi interventi più rilevanti ci sia l’esortazione ai subalterni a dominare la cultura e a trattare con condiscendenza i cosiddetti superiori.
Di fronte alla popolarità di queste assurdità, dobbiamo concludere che l’eredità di Antonio Gramsci è sconfinata eppure vuota, o almeno, svuotata. La maggior parte del suo impegno politico diretto è avvenuto nel periodo della Rivoluzione Russa e, nonostante le differenze tattiche, lui ha assunto quegli stessi fondamentali obiettivi politici. Oggi invece è stato trasformato in un’icona innocua, in vacui inni al suo ‘genio’ e ‘grandezza’, spesso mentre si ignora che cosa lui abbia davvero detto o per cosa abbia combattuto.
L’alt-right ha imparato da Gramsci a fare leva sul proprio ‘senso comune’, mentre i suoi supposti difensori ne invertono l’intenzione. È significativo che la lunga marcia attraverso le istituzioni sia spesso attribuita a Gramsci, riassumendo così la storia del suo partito e dei suoi eredi. La Sinistra italiana, dunque, più che costruire una propria cultura, ha finito per essere inghiottita dal mainstream istituzionale e dall’ordine costituito, anziché prometterne uno nuovo.
