
Martin Scorsese, a diciassette anni, rimase talmente affascinato dal semplice trailer de La dolce vita, di Federico Fellini, da diventare un regista. Anche Massimo Berruti, fotografo nato a Roma nel 1979, mi racconta di aver avuto una simile epifania, grazie a una foto del reporter statunitense James Nachtwey, scoperta in una libreria quando era ancora molto giovane. L’immagine in bianco e nero rappresentava il volto di profilo di un ragazzo del Rwanda, segnato dalle cicatrici – che sembravano argentate – dei colpi di un machete. “In maniera istintiva,” si ricorda Massimo, “l’ho identificata come un’immagine estremamente iconica, valida, potente e allo stesso tempo gentile, in grado di descrivere la situazione di violenza in cui si trovava il Paese in quel determinato momento storico e di parlare all’osservatore anche della forza del mezzo fotografico, di come potesse essere narrativamente evoluto, abbinato alla semplicità dello scatto”.
Il suo sogno prima ancora di quell’incontro, da bambino, era di imbarcarsi a bordo di una nave rompighiaccio insieme a Jacques Cousteau. “Mi iscrissi all’Università di Biologia con quel sogno in mente, ma una volta realizzato che il mio futuro in questo campo non sarebbe stato uguale al suo, ho riacceso la scintilla che era scattata in quella libreria”. Era il 2003. Un anno dopo Massimo cominciò la sua carriera di freelance autodidatta, dedicandosi a un progetto sulla crisi culturale ed economica in atto in Italia. Oggi sono passati vent’anni anni e sembra che quella crisi non solo non si sia risolta, ma anzi sia evoluta in peggio. Nel frattempo, Massimo con le sue immagini ha raccontato storie dall’Europa all’Africa, dall’Asia agli Stati Uniti.



Nel 2007, dopo appena quattro anni di carriera nel fotogiornalismo, arruolato all’epoca nella prima agenzia fotografica italiana e una delle più prestigiose, fino alla sua chiusura nel 2009, la Grazia Neri, si aggiudicò il secondo posto nella sezione “Contemporary Issue” del World Press Photo, uno dei premi fotografici più importanti del mondo. Il progetto raccontava il Roma Residence, un gruppo di condomini a un chilometro dal Vaticano costruiti nei primi anni Ottanta: impiegati principalmente per ospitare persone che avevano fatto domanda per una casa popolare, anche a causa della manutenzione costantemente trascurata, sono stati abbandonati da molti inquilini e occupati in breve tempo, in particolare da persone immigrate. Come si reagisce a una vittoria del genere ad appena ventotto anni, ma soprattutto all’inizio di un percorso, gli chiedo. “Per molti questa vittoria è arrivata troppo presto, credo pensassero che mi sarei montato la testa: diciamo che invece mi ha dato fiducia nei miei mezzi e nel poter portare avanti questo lavoro rispettando la dignità delle persone che fotografo, oltre all’opportunità di spiccare il volo all’estero dopo una gavetta in Italia”.




“Roma Residence” è il primo progetto in cui Massimo ha scattato in bianco e nero, una scelta di estetica e di poetica che porterà avanti nella maggior parte dei suoi lavori successivi, fino a oggi. “Quella che stavo rappresentando era una storia molto romana, ma anche molto comune e ripetibile in tutte le periferie urbane del mondo”. Fu per lui la prima esperienza in cui ha dovuto conquistare il consenso dei soggetti a essere fotografati, in particolare rispetto alla propria presenza nelle loro vite, già scottate da pessime esperienze con una stampa mordi e fuggi che aveva riempito le prime pagine senza mai davvero approfondire la loro storia. “Anche per questo,” spiega, “ho deciso di spogliarmi del colore per raggiungere la dimensione molto più istintiva, fattuale e giornalistica del bianco e nero”. L’istinto traspare anche dalle inquadrature, dalle immagini a volte leggermente mosse, spontanee – o grazie a un editing sapiente – anche in quelle più affollate di soggetti e di elementi tutto occupa il posto giusto, i gesti restano compiuti e lo sguardo continua a muoversi da una parte all’altra dell’immagine senza mai annoiarsi. È bello in molte di quelle immagini perdersi alla ricerca di un punctum che in realtà si scopre essere molteplice.

Nel 2008, anno in cui è entrato a far parte dell’agenzia VU, Massimo ha inaugurato oltre un decennio di progetti all’estero, in particolare quello a lungo termine, poi intitolato “The Dusty Path”, in Pakistan, Paese in cui ha lavorato e vissuto per diversi anni – dal 2009 al 2013, la sua permanenza più lunga – analizzandone e raccontandone la storia, i conflitti, il terrorismo e le sue contraddizioni. “Ho scelto il Pakistan perché in quanto Paese sovrano mi garantiva, rispetto all’Afghanistan, maggior possibilità di movimento: se nel secondo caso avrei dovuto lavorare prevalentemente embedded per la mia sicurezza, in Pakistan invece avrei avuto la libertà di cui avevo bisogno per procedere in maniera indipendente”. In quel momento, tra elezioni, un assassinio illustre e un peso crescente dell’importanza del Paese nella sua area geografica per me era il posto giusto su cui concentrare l’attenzione.


Le sue immagini suscitano lo stesso dinamismo dello sguardo, dato dall’immersione del fotografo nelle situazioni che ritrae, contrasti ricchi e potenti come in un testo scritto, in cui i bianchi spesso bruciati sembrano brillare e i neri definiti avvolgono i soggetti quasi in negativo, rendendo ininfluente, se non ai fini del racconto, che le immagini siano state scattate di giorno o di notte. La violenza è rappresentata senza spettacolarizzazioni, la dignità dei soggetti, anche quando sofferenti, è preservata dall’approccio del fotografo, la complessità delle situazioni non diventa mai fonte di confusione. Sono fotografie che richiedono il tempo di essere osservate nel dettaglio, ma allo stesso tempo scorse in sequenza offrono una panoramica esaustiva. Se da ragazzo Massimo era stato folgorato da una singola foto, oggi mi dice che approfondendo il mestiere si è reso conto di quanto il racconto in sequenza possa essere ancora più significativo.

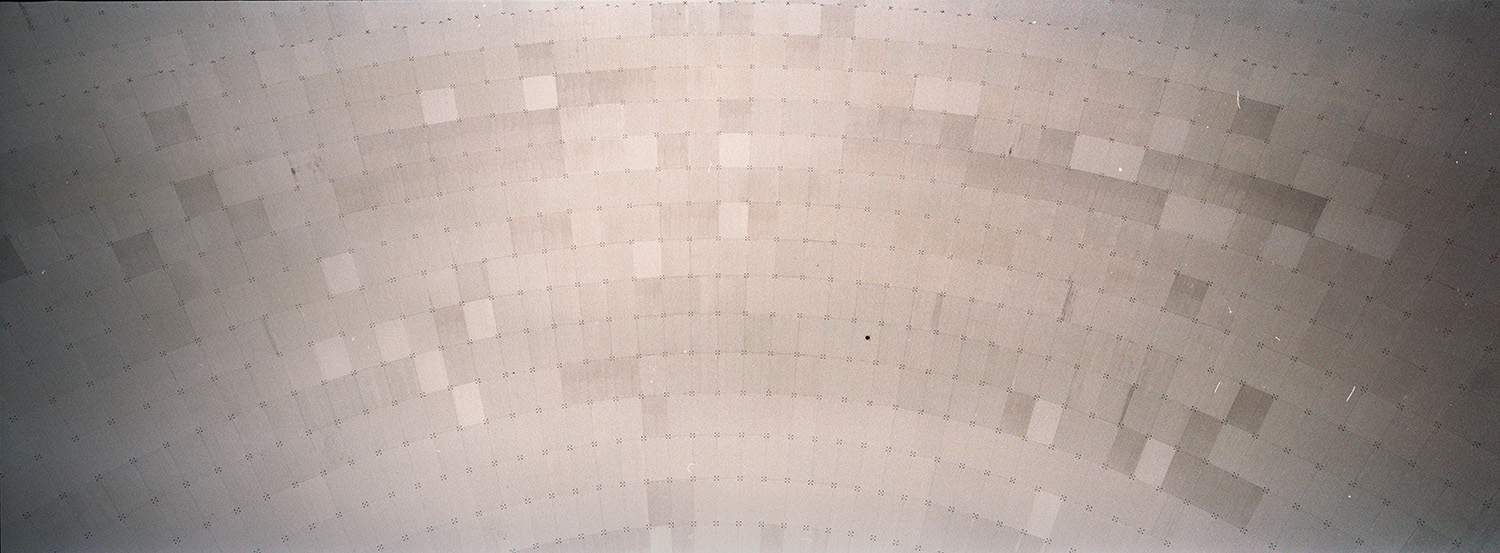
Il 2017 è stato poi l’anno di My Quiet Place, una storia ambientata negli Stati Uniti, a Green Bank, una cittadina microscopica che sorge nel mezzo della cosiddetta “National Radio Quiet Zone”, un’area di circa 10mila miglia quadrate nel West Virginia, dove dai primi anni Cinquanta ogni tipo di radiazione elettromagnetica è stato bandito per non interferire con il telescopio locale, impegnato nell’ascolto dello spazio più profondo in cerca dei segreti dell’universo e di tracce di vita aliena. Una zona in cui persone affette da elettrosensibilità si ritrovano da più di dieci anni per vivere al riparo dalle radiazioni di wireless, antenne telefoniche e radio.

A ispirarlo, in questo caso, è stato un documentario di Werner Herzog dedicato a Internet, Lo and Behold: Reveries of the Connected World, che racconta brevemente anche di questa comunità. Chiedo a Massimo cosa lo abbia condotto in questo caso a lavorare in via eccezionale con i colori. “È una storia molto diversa da quelle che ho fatto nella mia carriera, potenzialmente molto noiosa,” racconta. “È un luogo in cui le cose non succedono veramente, il cuore centrale della storia ha a che fare con qualcosa di invisibile e avevo bisogno di una mano da parte del colore, per una spinta interpretativa. Mi è servito per cercare di restituire quell’aspetto emotivo che nella storia c’è, ma che io dietro il mezzo fotografico avrei faticato a rendere rispetto al percorso da cui arrivavo”.


Da un lato i verdi acidi e i rossi infuocati che illuminano gli oggetti immersi nella notte e le insegne al neon, che si stagliano sui cieli al crepuscolo e che parlano di una società perfettamente sviluppata e contemporanea; dall’altro i verdi e i rossi più tenui e naturali dei boschi in cui sono immerse molte delle roulotte o delle baracche di chi ha scelto per necessità di trasferirsi in questa porzione di mondo per trovare sollievo da sintomi fisici e psicologici derivanti da campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, anche a costo di separarsi dalla famiglia e di non comunicare come il nostro mondo interconnesso ci spinge a fare di continuo.

La distopia presente di un luogo come questo viene trasmessa in modo suggestivo dal colore e concorre nel materializzare in maniera più lenta ed efficace quella sfera invisibile, che non richiede i contrasti drammatici di scene in cui protagonista è la distruzione e il modo che gli esseri umani hanno di sopravvivervi. Anche in questo caso, però, entra in gioco la resistenza, di un posto che sembra al riparo da tutto quello che potrebbe nuocerci.


Anche per uno dei suoi ultimi progetti, ancora in corso, Massimo ha scelto il colore. Per parlare di intelligenza artificiale, di qualcosa di proiettato al futuro e che aspira a eguagliare l’essere umano, in effetti, è necessario ricorrere ai rosa di una certa carnagione – che si riesce già a replicare con ottimi risultati – e in cui la scala microscopica di fibre e DNA richiede una visualizzazione in cui stimolare lo sguardo anche attraverso le scale cromatiche. “La fotografia,” mi dice Massimo, “è un linguaggio senza barriere geografiche. È muta ma allo stesso tempo grida. Non importa se sei pakistano, americano, italiano: bene o male, se l’immagine è buona, tutti abbiamo gli strumenti per coglierne almeno una parte. La sua sequenzialità, in un contesto di serie, è in grado – e deve esserlo necessariamente – di trasmettere il nocciolo di una storia, altrimenti non è una buona fotografia”.


Nel 2017, abbandonata l’agenzia VU, insieme ad altri reporter provenienti da diverse parti del mondo Massimo ha fondato MAPS, una realtà che mette insieme le diverse voci del gruppo condividendo gli stessi valori e principi etici. “Crediamo nell’indipendenza, nell’apertura mentale e nell’intelligenza collettiva. Siamo sinonimo di integrità, rispetto, perseveranza e trasparenza,” recita parte del manifesto. Il modo di vivere il fotogiornalismo di Massimo traspare da quello che racconta e dalle immagini che produce, trainate chiaramente da questo tipo di valori, che dovrebbero essere alla base del lavoro di qualsiasi professionista, ma che spesso si diluiscono in più compromessi di quanti se ne potrebbero immaginare.
Questo articolo fa parte di PARALLAX, il nuovo Vertical di THE VISION dedicato alla fotografia e al fotogiornalismo, e realizzato in collaborazione con Fujifilm Italia. L’intervista a Massimo Berruti è stata curata da Alessandra Lanza.
