
Non so come è successo, ma da quando ho ricominciato a rivedere i film di Jim Jarmusch per scrivere questo pezzo, ho iniziato a confondere i nomi di alcune persone, come succede spesso nei suoi dialoghi. Il lapsus è un fenomeno che può far emergere un significato, oppure è un segno di demenza, di distrazione, un errore comune. Eppure ogni volta che qualcuno ci chiama con un nome che non è il nostro per un istante si crea una cesura. I nomi, nei film di Jarmusch, vengono sistematicamente confusi, e l’identità dei personaggi finisce per adattarsi a questo errore. A volte, come succede in Coffee and Cigarettes, qualcun altro ordina al posto nostro, e anche se all’inizio ci mette a disagio con il fastidio di un’inutile prepotenza, dopo poco capita che ci adattiamo a quella scelta, abdichiamo alle nostre piccole volontà che ci identificano, diventiamo qualcos’altro senza accorgercene.



Il grande pregio di Jarmusch è forse quello di essere restato a lungo ostinatamente indipendente, mentre tutto in America e a Hollywood diventava in fretta sempre più dipendente. Seguendo le impronte di Nicholas Ray, il suo maestro – a sua volta discepolo del grande architetto Frank Lloyd Wright, Jarmusch ha invece saputo tenersi lontano ed evitare che il suo cinema venisse inquinato dalle dinamiche dello star system e dalle lusinghe della popolarità, che già negli anni Ottanta veniva spacciata come indispensabile per fare qualcosa, essere qualcuno. Jarmusch continuò a muoversi controcorrente, a guardare con attenzione in una direzione verso cui nessuno più si voltava, e così apparì originale. Inizia la sua produzione con film estremamente iconici – Permanent Vacation (1980), Stranger Than Paradise (1984) e Daunbailò (1986) – e a distanza di quindici anni Dead Man prima e Ghost Dog poco dopo lo consacrano definitivamente come uno dei grandi registi del nostro tempo.


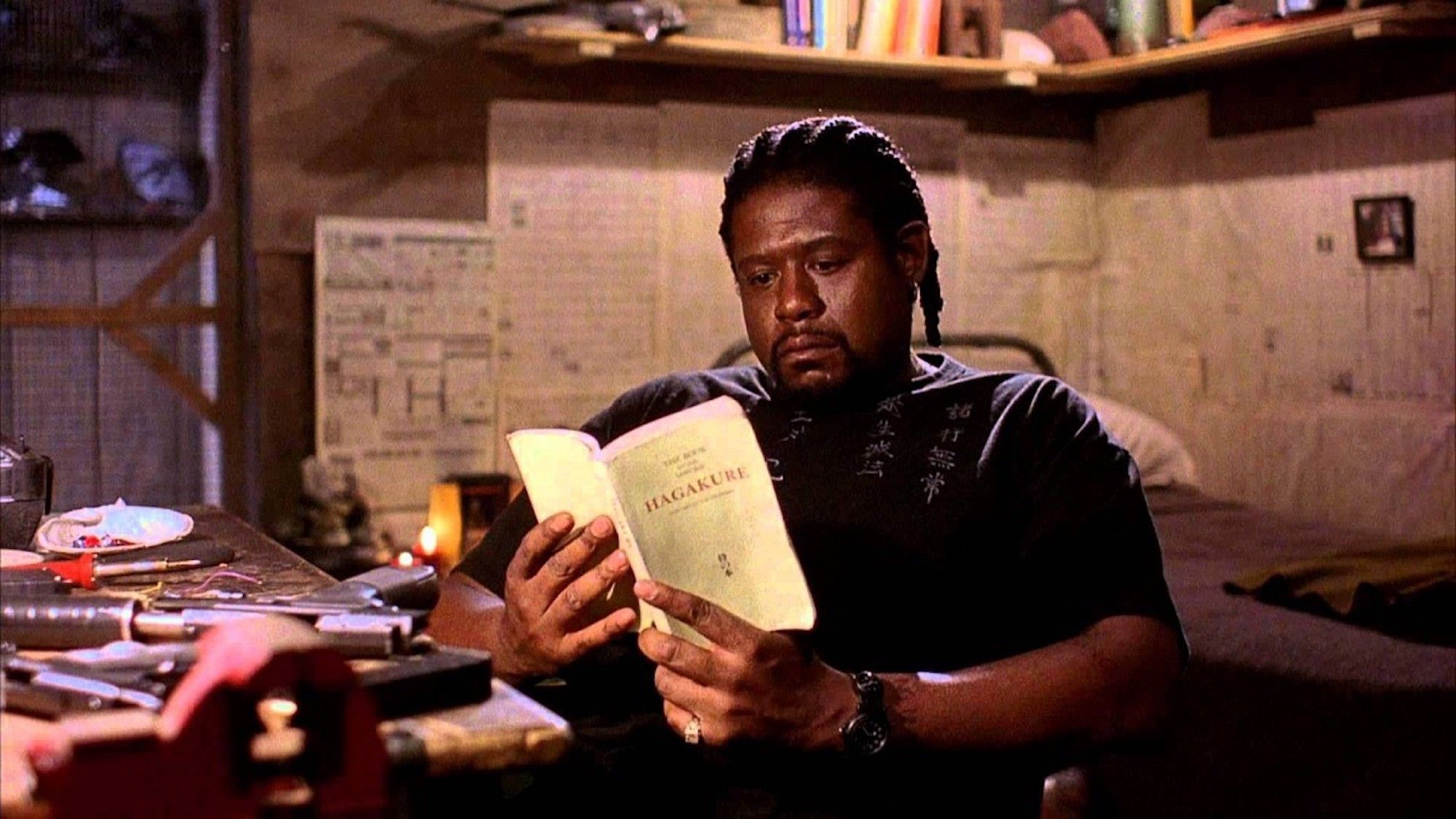


Se David Lynch diceva che i film sono la cosa più vicina ai sogni che facciamo, Jarmusch ha preso alla lettera questa lezione. Le scene di Jarmusch sono statiche, gli spazi espansi, disabitati, onirici, anche quando sono perimetrati dai muri di una stanza. È come se gli ambienti domestici avessero la stessa qualità delle highways e delle periferie disperse, come se qualcosa di oscuro ci si infiltrasse, influenzando anche l’esistenza dei personaggi che si muovono in quegli ambienti. Questi appaiono come fantasmi, sospesi, spiantati, fuori contesto, distratti, annoiati. Esseri umani che, aderendo all’immagine di se stessi, generano straniamento nell’altro, come se la struttura del senso, del reale, si smagliasse, lasciando emergere un vuoto che ricorda La noia di Alberto Moravia (1960), ma forse ancor più La nausea di Jean-Paul Sartre (1932) – nausea che sembra espandersi dal blocco sovietico dell’Est Europa fino alla California, in un’unica e vasta koinè culturale, proprio come succedeva nel cinema di Wim Wenders (Alice in den Städten; Paris, Texas; Lisbon Story). Ma se in Wenders dal nulla emerge un denso significato, in Jarmusch resta spazio solo alla confusione, a quel profondo senso di inadeguatezza nei confronti dell’esistente, quell’alienazione alla quale se l’io vuole sopravvivere è costretto a disintegrarsi.



L’atmosfera di Jarmusch è malinconica, è l’atmosfera di qualcosa che sta per finire, che sta scomparendo, di un’energia che si è esaurita. Tutto ciò che resta è un mondo grottesco, tragicomico, per certi aspetti tenero. Le atmosfere ricordano spesso quelle dei fratelli Kaurismäki, una sorta di nouvelle vague sinistra, dove ci si parla ma non ci si capisce, dove l’identità si confonde involontariamente e si sfuma come in un sogno e i confini personali si mischiano con l’altro, lasciando un senso di spaesamento, come quando trascinati da una situazione che la vita ci offre si sente di aver oltrepassato un confine entro cui ci sentivamo al sicuro. Non a caso Tom Waits, molto legato al regista e interprete di diversi suoi personaggi, ha detto: “Non riesco a capire coloro che si rifugiano nella realtà perché hanno paura di affrontare le droghe”. I film di Jarmusch sembrano un trip, un sogno ironico a occhi aperti dove qualcosa ci lega e non ci lascia andare dove vorremmo, una realtà alterata, intorno a cui il nulla, l’inconscio, l’incomprensibile sembra fare pressione da tutte le parti per emergere. I suoi personaggi così sembrano tutti fantasmi e a un certo punto se ne vanno così come sono venuti.
In Daunbailò (Down by Law), che è una specie di fiaba distorta, Roberto Benigni tira fuori una delle sue migliori interpretazioni. Roberto, un personaggio che sembra anticipare Johnny Stecchino o Loris de Il mostro, con un inglese naturalmente maccheronico racconta a due “innocenti” – Jack e Zack – com’è diventato assassino, evocando una sparatoria che al posto dei proiettili ha palle da biliardo. Roberto è una sorta di Arlecchino e alla fine del film le direzioni, così come le identità, non contano, a destra Est, a sinistra Ovest, o viceversa, chi se lo ricorda, tanto ci sono le indicazioni. Ma le indicazioni non ci sono. “Ha detto che a destra si va a Ovest”, dice Jack indicando a sinistra. “Ha detto che non lo sapeva”, controbatte Zack. “Senti, non importa, vai dove vuoi… e io andrò dall’altra parte”, risponde Jack. E poi Zack e Jack si scambiano le giacche e ognuno si allontana, non “per la sua strada”, ma per una strada, ridendo, verso il nulla. D’altronde uno dei motti di Jarmusch è: “Difficile perdersi se non sai dove stai andando”.



Uno dei temi a cui il cinema del regista ammicca è proprio quello dell’identità (i gemelli che riappaiono ciclicamente, un po’ come se fossero i daini di David Lynch) e dei suoi confini, dell’ironia e del senso di grottesco che emerge dall’identificazione e dalla sua smentita. Lo ricorda anche Tilda Swinton, nei panni della vampira Eve in Only Lovers Left Alive: “Come puoi aver vissuto così a lungo e non esserci ancora arrivato. Questo tuo egotismo è un’enorme spreco di vita. Potresti usarla per sopravvivere alle cose, amare la natura, coltivare la gentilezza, l’amicizia e… ballare. Almeno sei stato piuttosto fortunato in amore, se posso permettermi”.



Nel cinema di Jarmusch ci si incontra e non ci si riconosce, ci si parla e ci si fraintende. Le sue storie sono vuote, dilatate, oltre ai dialoghi, alla possibilità del contatto con l’altro; si vede allargarsi il nulla come una macchia nera, e quel nulla è l’unica cosa che riconosciamo, in cui paradossalmente ci viene voglia di rifugiarci pur di non dover assistere alla fatica che lo nasconde, al perenne senso di imbarazzo che Jarmusch ci fa provare. Marcel Proust, nel primo volume della Recherche, Dalla parte di Swann, affronta questo disagio, che spesso si prova da bambini. Tre anni prima, nel 1910, anche Rainer Maria Rilke aveva fatto qualcosa di simile, anche se in molto meno spazio, con I quaderni di Malte Laurids Brigge, influenzato dalla filosofia di Nietzsche. Questi romanzi trattano temi esistenziali come la ricerca dell’individualità, il significato della morte e la riflessione sull’esperienza del tempo e del ricordo. Così fa Jarmusch, anche se in maniera postmoderna e per certi aspetti manierista, giocando con stili, codici e registri, senza velleità di essere originale e per questo diventandolo.


I film di Jarmusch sembrano il bordo aperto di un rotolo di tessuto: i fili, fino a un millimetro prima ben intrecciati a formare una fantasia, improvvisamente, a partire da una certa linea iniziano a sfilacciarsi, a sputacchiare. Se non li fermi, o peggio se li tiri, piano piano tutto finisce per disfarsi. In Paterson questo processo si arresta, sembra che Jarmusch scelga deliberatamente di arrivare a capo di una storia. Il vuoto, l’assurdo della vita, preme, eppure l’aderenza al rito della regola, la quiete, la cappa magica della luce obliqua che scende sulla provincia, tengono insieme il marasma dell’esistenza grazie a un solo sguardo, a un’identità ampia (Paterson viene sempre chiamato per cognome, che ironia della sorte è anche il nome stesso dell’anonima città in cui vive) che riconosce d’essere nulla, perché non vuole essere, e in quel suo non essere può osservare e dire, traducendo il reale, l’esserci in poesia. Non a caso Paterson è l’unico personaggio che viene riconosciuto, non in quanto Paterson, ma in quanto possibile poeta (“Tutti lo siamo?” sembra essere la domanda che aleggia nel corso della storia?). Sia in Only Lovers che in Paterson, allora, l’arte che si genera come espressione dell’Io viene irrimediabilmente distrutta dal caos, e se per Adam è una liberazione, per Paterson è una conferma: per il primo il punto infatti è l’amore e la condivisione, per il secondo il fatto che l’arte non sia il risultato, ma lo sia invece il processo di ascolto delle segrete corrispondenze del mondo e di manifestazione di queste ultime, l’essere essi stessi tramite, ponte.



Per Jarmusch, infine, la musica gioca un ruolo importantissimo, tanto che ha collaborato sistematicamente con diversi musicisti in veste di attori, o generando storie dalla loro stessa musica. Diversi film sono nati proprio dalla cultura musicale di alcune città – in particolare Daunbailò da New Orleans e Mistery Train da Memphis. La sceneggiatura di questi due film è nata prima ancora che Jarmusch visitasse effettivamente queste città, come se la musica stessa, cresciuta lì, li evocasse. I luoghi dunque appaiono prima di tutto come atmosfere. Al di là della musica, i suoi film, così come le atmosfere che percepiamo, nascono da stimoli estremamente vaghi e vari che si condensano: un dialogo rubato, una risata, un dipinto, il colore del cielo, sono vere e proprie aggregazioni di inconscio, e forse è per questo che è riuscito a rendere così bene il tempo, il ritmo, dell’esperienza del poeta in Paterson.
La poetica di Jarmusch si potrebbe allora sintetizzare con una canzone dei Kinks, “Too Much on My Mind” – peraltro tanto amati da Wenders da dedicargli il suo primo film, Summer in the City (1970), che per certi aspetti, a partire dal titolo, assona con Permanent Vacation: “I’m thinking of the time / There’s too much on my mind / It seems there’s more to life than just to live it”.
