
Era il 1987, e nell’Italia dei governi Craxi e Fanfani, con la sua moneta sovrana, La Piovra in prima serata, l’Unione Europea ancora di là da venire e trecentomila lire che erano davvero trecentomila lire, spuntava uno studio che oggi farebbe rabbrividire. Si intitolava Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, l’autrice era la rinomata linguista Alma Sabatini e, che ci crediate o no, fu commissionato dal Parlamento italiano e messo alle stampe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di allora, a maggioranza democristiana. Se non siete già scappati a gambe levate, pensate allo straordinario tempismo di questo manualetto, che a seguito di un’accurata indagine sulla terminologia usata nei libri di testo e dai mass media, si proponeva di “dare visibilità linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile”.
In altre parole già trent’anni fa, molto prima delle vandee populiste scatenate oggi da destra e da sinistra contro il politically correct, esisteva un’analisi scientifica che affrontava le implicazioni sociali e politiche della lingua e proponeva nuove linee guida alle scuole e all’editoria: con buona pace della nazione spaesata e nostalgica che ha trasformato Laura Boldrini nel suo capro espiatorio.

La verità è che toccare una parola vuol dire toccare una persona. Perché, come scriveva Sabatini, “l’uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione del pensiero e nell’atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta”. La reazione al cambiamento la vedete in questi giorni, quando la maggior parte della gente sembra rispondere con diffidenza – se non aperta ostilità – ai mutamenti linguistici richiesti in una società che cambia che disturbano le sue abitudini. O, peggio, sembrano una violenza contro il senso comune, contro la natura: una vera e propria molestia.
Non bisogna chiamarsi Diego Fusaro per notare come, tra gli espedienti più in voga in certi ambienti di sinistra, l’uso dell’asterisco o della chiocciola per la declinazione egualitaria dei sessi all’interno dei testi sia uno dei più artificiosi e controversi che ci siano. Molti trovano questa prassi decisamente disturbante: io sono tra questi. Trovare scritto «compagn*», «tutt*», «ragazz*», eccetera al posto del maschile plurale in un comunicato politico, in uno status di Facebook, persino in uno slogan stampato a caratteri cubitali, è quasi insopportabile.
Certo Fusaro, che è il pensatore più amato dal fascioleghismo, aggiungerebbe che questo è l’ennesimo inganno della “neolingua liberista”; che ogni ipotesi di riforma della parola in senso più inclusivo è una trappola del femminismo per renderci ancora più schiavi, effemminati e succubi del Capitale. Curioso, tra l’altro, è il fatto che ormai a parlare dei rischi di un Newspeak imposto dall’alto, sulla falsariga del romanzo di George Orwell 1984, sia principalmente la galassia degli ex comunisti incattiviti, dei maschilisti di ritorno, dei delusi della globalizzazione, dei cosiddetti “rossobruni”; laddove, nell’originale orwelliano, era uno spauracchio inventato da un autore trotzkista per metterci in guardia dal totalitarismo sovietico e dal nazionalismo.

In generale, il rigurgito reazionario contro il politically correct andrebbe preso piuttosto sul serio, perché anche una battaglia apparentemente innocua come quella per una lingua più rispettosa può trasformarsi – e si è già trasformata – in occasione per rimescolare e svilire ogni legittima istanza sociale: se ormai basta proporre un “incontro sulle differenze di genere e il bullismo” per passare per sciocchi mercenari del Nuovo Ordine Mondiale, ogni legittima messa in discussione degli eccessi del perbenismo, di quelle istanze individuali e sessuali nate a partire dal Sessantotto, rischia di essere sequestrata dai moralisti più pigri, e dagli antimodernisti di maniera. Si sono confuse le acque, e non di rado ci si sente costretti a passare per snob elitisti pur di non finire assieme alla barbarie.
Il problema è che l’italiano, a differenza ad esempio dell’inglese, è una lingua flessiva e non isolante: cioè vede declinati per genere, oltre ai pronomi, anche gli articoli e i sostantivi. E laddove in inglese si trovano sostantivi declinati per genere (es: husband/wife, sister/brother) molti di essi hanno un’alternativa di genere neutro (spouse, sibling). Che è successo dunque in quest’epoca di sensibilità più diffusa al tema del rispetto di genere, in cui sono coinvolti anche gli individui gender-neutral, in fase di transizione o di indeterminatezza identitaria, e le loro preoccupazioni hanno sfondato la nicchia? Che l’inglese (e il cinese, per quanto ne so) si è trovato avvantaggiato, e il lavoro di riforma della lingua si sta concentrando sui pronomi.
Per l’italiano è molto più complicato. Fin dall’infanzia le scuole patrie ci insegnano che il plurale va al maschile anche se nel gruppo c’è un solo elemento (persona, animale o cosa) di genere maschile. E certo, questa è una legge apparentemente ingiusta: perché uno dei generi deve prevalere assorbendo l’altro, anche quando è minoranza? Perché non viceversa? “Le risposte sono due”, ha spiegato l’archeologa Paola Mazzei. “La prima, più filosofica, è che il genere maschile corrisponde, di per sé, all’universale (vedi l’uomo di Leonardo)”. La seconda è più antropologica: “Per un individuo di genere femminile essere omologata al maschile costituisce una promozione, mentre per un individuo di genere maschile, essere omologato al femminile costituisce una degradazione”. Di fronte a riflessioni simili, come si fa a non concedere almeno la sbarretta per la doppia declinazione?

“Personalmente scelgo l’asterisco”, scrive sul suo blog l’educatrice e psicoterapeuta Francesca Fadda, “[perché] è un espediente grafico che può essere usato in sostituzione alla desinenza per indicare la forma sia al maschile che al femminile e, in base all’intenzione di chi scrive, includere le forme che non rientrano in nessuna delle due”. Chi lo utilizza dunque si rivolgerebbe anche a chi, per vari motivi, non rientra nel binario maschile/femminile. L’asterisco, col suo effetto impertinente (“un abbraccio a sei braccia che accoglie ogni espressione del genere”, lo definisce Fadda) attirerebbe l’attenzione sulla censura quotidiana operata dal nostro linguaggio sul sesso femminile. Un fastidio a fin di bene, insomma?
Per non nascondermi, dirò che la mia risposta è “no”: l’asterisco non vale il disturbo che arreca. Lo so: dovrei specificare di essere maschio ed eterosessuale; anzi, cisessuale: la mia identità di genere corrisponde al sesso a cui sono stato assegnato alla nascita. E capisco pure, da una prospettiva un po’ situazionista (o anarchica), gli argomenti dietro la scelta di causare impiccio ai confortati. Ma ciò non toglie che la duplicazione delle forme (“lui/lei”) o l’uso dell’asterisco sono soluzioni inefficaci, rozze e direi persino ignoranti: non solo rendono poco scorrevole il testo ma, nel caso dell’asterisco, è per di più limitato al solo linguaggio scritto, in quanto privo di fonema corrispondente.
Circa cinque anni fa ha fatto il suo ingresso nel vocabolario della sinistra radicale americana la parola trans*: un “termine-ombrello” per indicare qualsiasi opzione all’interno dello spettro dell’identità sessuale, inclusi coloro che ancora non hanno deciso se identificarsi come uomo o come donna. Non sembra avere avuto lunga vita. Da un decennio o forse più, molti attivisti americani usano il termine di genere neutro latinx, al posto di latino o latina, per riferirsi all’identità etnica o culturale latinoamericana. Una boutade? Sufficiente a riempire pagine e pagine di discussioni, però, in mezzo ad accuse incrociate di imperialismo linguistico tra docenti di origine ispanica e lo scrittore Hector Luis Alamo, che sottolineava come nessuna parola abbia mai oppresso nessuno (“tranne forse la parola Dio”). Più facile a farsi, che a dirsi. Ma almeno la parola latinx un aiuto ce lo dà: è pronunciabile, perché tale è il suffisso -x. L’asterisco, che durante la lettura non si può intendere come nient’altro che un carattere tipografico, è paradossalmente una scelta discriminatoria: ammicca a una peculiare forma di scrittura, che è quella generata dai computer o dai cellulari.
Il secondo problema è che l’asterisco fa davvero poco per decostruire il linguaggio sessista. Con la scusa della maggiore inclusività, questo “jolly” in realtà sposta l’ingiustizia su un piano diverso, “interiore”, che richiama la censura di parole poco raccomandabili. Pensate, ad esempio, all’asterisco sulla parolaccia o l’offesa razziale, quando essa viene riportata in un testo scritto dalla gente perbene: un escamotage che attutisce davvero il peso della parola, o piuttosto costringe il lettore a proiettarsela nel cervello; a ripeterla una volta in più, in silenzio, alleviando chi scrive dalla responsabilità della parola? Cioè un po’ quello che succede con la parola nigger nella cronaca o nella conversazione anche informale tra progressisti: una parola “talmente carica di significati razzisti”, scriveva Mattia Ferraresi su Il Foglio, “che è stata espunta da ogni forma di comunicazione ufficiale. Il vocabolario risciacquato nel puritano senso di colpa l’ha ridotta a n-word, accanto alla f-word e ad altre parole indicibili identificate soltanto con l’iniziale”.

Forse la colpa più grave dell’asterisco è quello di essere una pratica male informata, perché attribuisce all’archeologia della lingua una progettualità discriminatoria, una schematicità del potere che essa non porta necessariamente con sé. Ricordo che ci fu un periodo in cui andava di moda, nell’attivismo anglosassone, parlare di herstory anziché history, per indicare la storia scritta da una prospettiva femminista – enfatizzando il ruolo della donna – o raccontata dal punto di vista femminile. Niente di male: il problema è che quel neologismo fu coniato come se quel -his fosse davvero un pronome possessivo tramandato dai patriarchi normanni, e non invece il derivato del greco ἱστορία, o historia. Quando Erodoto scriveva le sue Storie, utilizzava per titolo un termine che indica “la conoscenza ottenuta tramite l’indagine”, e per di più era declinato al femminile.
Parlando di lingue antiche, Paola Mazzei ha spiegato come molte di esse siano apparentemente meno “maschiocentriche” dell’italiano e di altre lingue moderne: il greco ha άνϑρωπος per dire «uomo, essere umano (generico)», mentre il latino ha homo, ed entrambe le lingue altre due parole diverse per dire essere umano maschio (rispettivamente: ἀνήρ e vir) ed essere umano femmina (rispettivamente: γυνή e mulier). Se l’ebraico usa la radice maschile hish-, aggiungendo la terminazione -a per il femminile (hish-a), così il turco moderno separa bay (maschile) da bayan (femminile). Quello che cerca di dire Mazzei è che non bisogna farsi troppe illusioni: il fatto che molte lingue antiche fossero più inclusive non vuol dire che le donne non fossero subordinate, e asservite, nelle società che quelle lingue parlavano.
Indubbiamente molti di noi, quando si trovano a dover affrontare un cambiamento, assumono un atteggiamento ridicolmente moralistico: quasi come se la difesa della lingua si trasformasse nella difesa di un territorio sacro e intoccabile. In realtà, nei confronti della lingua, così come della politica, alterniamo passività e attività con fare quasi schizofrenico: saremmo capaci di perdere ore a dibattere di gabelle sui sacchetti biodegradabili e poi indugiamo in un meticciato linguistico che farebbe rabbrividire i Padri fondatori della Repubblica. Ai tempi di Fanfani si accettavano neologismi quali «cassintegrato» o «irizzato» senza troppi problemi, nonostante i linguisti di allora gridassero allo scandalo. Oggi accettiamo i barbarismi provenienti dall’inglese come «blastare» (da to blast, distruggere) o «twittare» senza battere ciglio. Di sicuro alcuni vocaboli hanno la capacità di conquistarci meglio di altri in modo subliminale. Forse li accettiamo senza proteste perché, in fondo, non ci coinvolgono più di tanto. O forse il cambiamento riesce a passare meglio quando sembra provenire “dal basso”, piuttosto che dalle istituzioni; quando non è percepibile l’azione degli intermediari politici o intellettuali (che, va detto, in questo momento non stanno messi proprio bene).
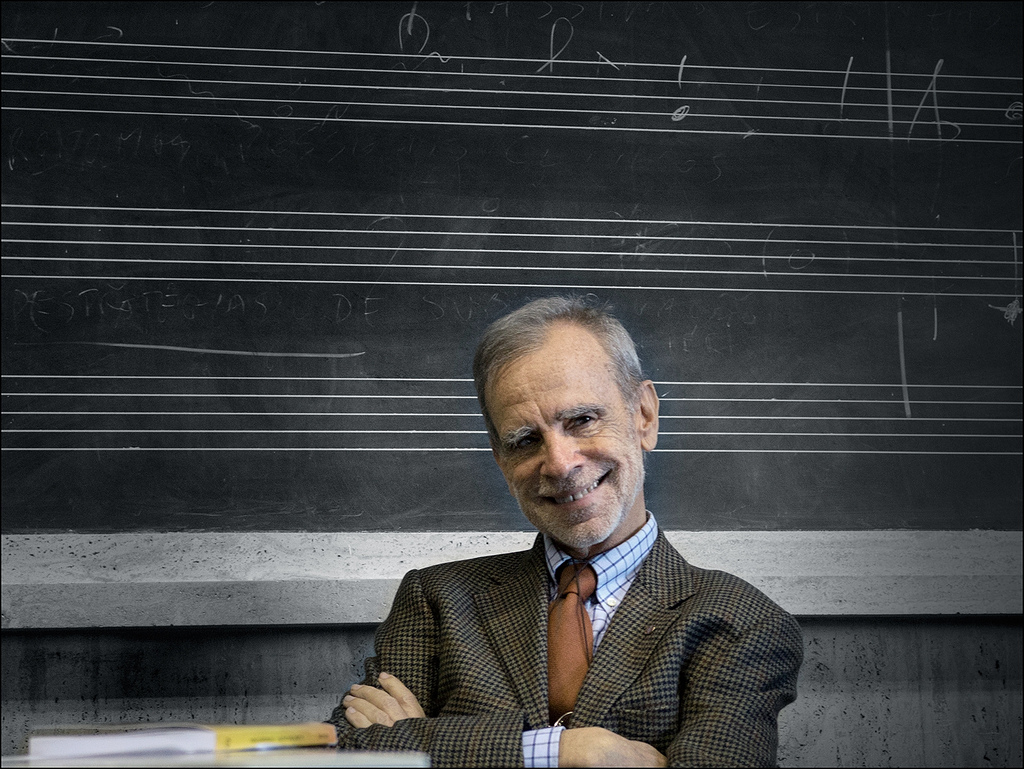
Come si può accettare il fatto che la lingua è un organismo in mutazione senza scatenare fiaccolate di cittadinanza indignata? Potrebbe forse essere utile, invece di aggiungere sfumature e caratteri impronunciabili, togliere significatività a quel che è già in uso: “desessualizzare” il maschile e femminile della nostra lingua fino a che possano essere usati l’uno al posto dell’altro, proprio come quando riconosciamo l’inglese la lingua franca del mondo.
In fin dei conti, se non si volesse usare lo sgradevole asterisco, basterebbe rispolverare il vecchio manuale di Alma Sabatini: declinare al femminile i mestieri che si possono declinare, evitare di usare sempre il maschile plurale per parlare di popoli, ricorrere il più possibile a sostantivi epiceni, cioè privi di marca di genere (ad esempio, “le persone”) o cercare forme alternative (“gli elettori” può diventare “chi è andato a votare”), e così via. Una serie di regole che non tutti assorbirebbero con la stessa prontezza, ma davvero semplici se paragonate alle linee di codice e alle interfacce socialmediali che ormai ogni giornalista e studente universitario è costretto a imparare. Come direbbe l’esperto di turno dei diritti dei consumatori invitato in tv: gli strumenti per combattere il sessismo linguistico ci sono. Basta saperli usare. Pigrizia: sostantivo femminile, vero nemico della Rivoluzione.
