
Quando a ottobre dell’anno scorso fu annunciata la morte di Enzo Mari, a causa di complicazioni dovute al Covid, l’Italia lo salutò come un maestro di cui non si è mai riusciti a conoscere a pieno la portata. A differenza di altri designer italiani, infatti, l’importanza di Enzo Mari risiede più nel suo pensiero critico che nella sua produzione, anche se nel corso dei suoi sessant’anni di carriera ha ideato migliaia di oggetti per alcune importanti aziende, tra cui Alessi, Zanotta e Danese, con cui strinse un sodalizio durato decenni e che segnò il successo dell’azienda stessa. Non a caso il suo primo Compasso d’oro – il famoso premio nato nel secondo dopoguerra per idea dell’architetto Gio Ponti, da assegnare ai migliori progetti di disegno industriale – lo vinse per le sue ricerche e non per un oggetto specifico. Politicizzato, impegnato nel sociale e fortemente convinto della direzione “etica” da perseguire attraverso le proprie opere, Enzo Mari è stato uno dei designer che più di tutti hanno influenzato la “teoria del design” dagli anni Sessanta a oggi, fornendo una base filosofica a una pratica convenzionalmente considerata meramente tecnica.


Nato a Novara nel 1932 cresce a Milano, dove suo padre, dopo la seconda guerra mondiale, trasferisce la famiglia, lavorando come venditore porta a porta di macchine da cucire Necchi. Nel 1947 il padre muore prematuramente, lasciando Enzo con la responsabilità del ruolo di capofamiglia. In quegli anni Mari svolge qualsiasi tipologia di lavoro, dai primi lavoretti di grafica pubblicitaria alla vendita di sapone al dettaglio. Nel 1952 si iscrive all’Accademia di Brera, unico istituto d’istruzione superiore che al tempo non prevedeva un diploma per essere ammessi. A Brera conoscerà la sua prima moglie, Iela Mari, al secolo Gabriella Ferrario, sua compagna di corso, diventata poi illustratrice di libri per bambini, da cui nasceranno due figli, Agostina e Michele, anch’esso divenuto celebre come scrittore e accademico, che descriverà il difficile rapporto con il padre nella sua autobiografia, Leggenda privata.
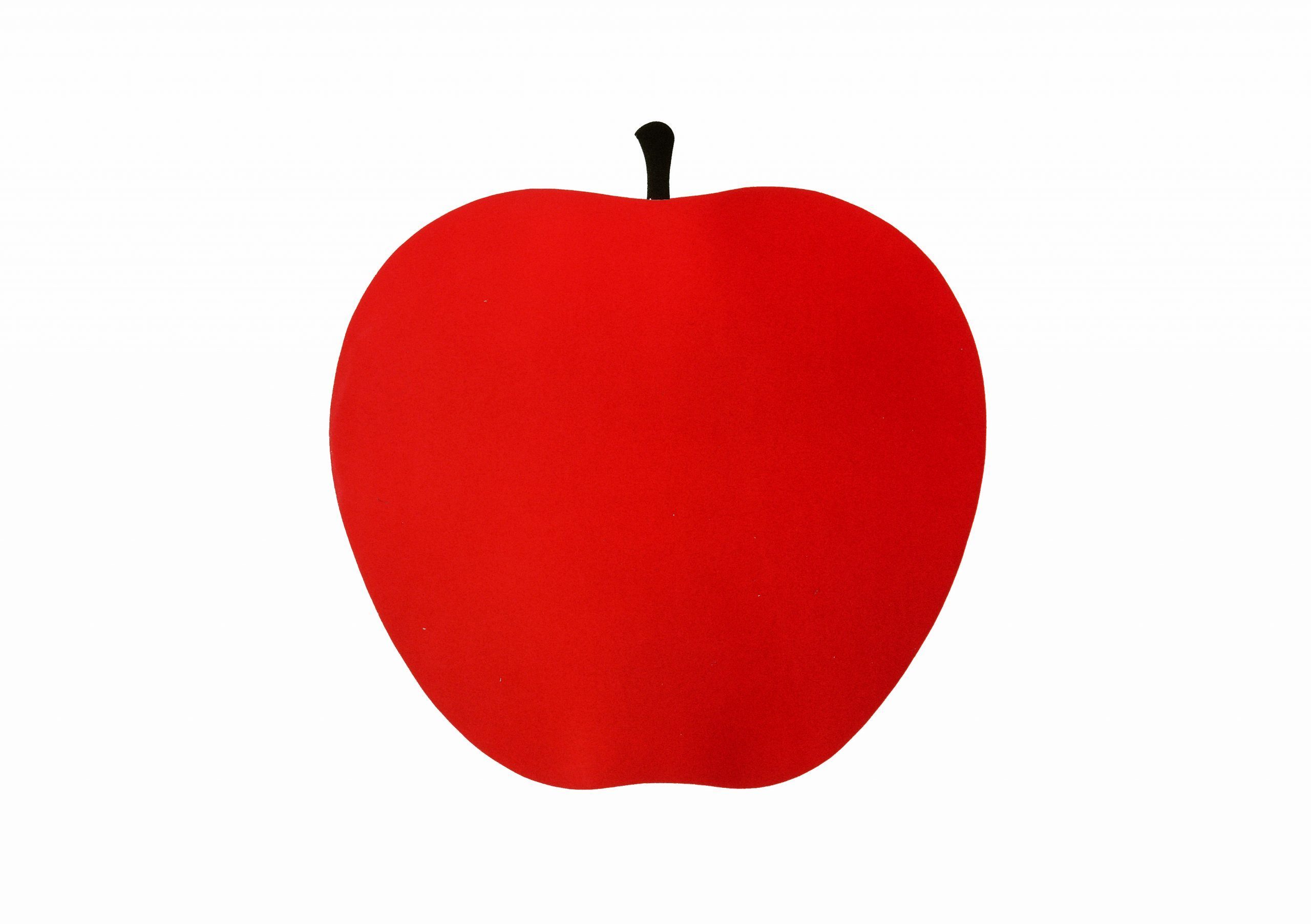
Nel 1957 Enzo Mari esordisce come artista allo studio B24, un atelier di architettura nel centro di Milano, con una mostra dal titolo “Enzo Mari: esperimenti colore-volume”, presentata da un testo di Guido Ballo, al tempo docente a Brera. Quello stesso anno Munari – che aveva visto i suoi primi lavori e con cui da quel momento aveva dato vita a una solida e proficua collaborazione – gli presenta l’imprenditore Bruno Danese. Danese si innamora immediatamente delle sue opere, a partire dal Gioco dei 16 animali: un puzzle per bambini in legno, tra i primi a essere messi in commercio dalle Edizioni Danese e che segnerà il principio di un sodalizio che tra gli anni Sessanta e Settanta farà sviluppare a Mari una sessantina di progetti, diventati veri e propri cult del design italiano. Sempre per Danese Mari progettò nel 1959 Putrella, un vassoio ottenuto da un pesante segmento di trave a doppia T incurvata alle estremità, il cui obiettivo concettuale era quello di rovesciare la logica della produzione industriale.


Enzo Mari era un designer atipico, lontano dal concetto di un design classista ed elitario come spesso siamo portati a immaginarlo oggi. La politica influenzò fortemente la sua produzione e il suo essere un pensatore e un artigiano prima ancora che un designer vero e proprio si esprimeva nell’idea che gli oggetti dovessero appartenere a chi ne faceva utilizzo, fin dalle fasi della loro ideazione. Dichiaratamente comunista, il suo lavoro non smise mai di essere democratico, provocatorio, avanguardistico. Nell’aprile del 1973 Carla Pellegrini, storica gallerista della Galleria Milano, lo chiama per inaugurare la nuova sede di via Turati/via Manin, dove Enzo Mari propone una mostra intitolata Falce e martello. Tre dei modi con cui un artista può contribuire alla lotta di classe, all’interno della quale riprogettò lo storico simbolo che dava nome alla mostra in una forma “esteticamente elevata”, concludendo però che il “valore formale non incide sul messaggio veicolato”, adducendo al simbolo un valore collettivo che andava oltre la sua grafica.


La sintesi simbolica del suo lavoro di designer la raggiunse però nel 1974, quando pubblicò Proposta per un’autoprogettazione, un progetto per la realizzazione di 19 modelli di sedie, tavoli, armadi e librerie da realizzare mediante l’uso di tavole in legno e chiodi. Quella di Mari era una vera e propria provocazione, una sfida alle logiche industriali, alla meccanizzazione, che voleva e vuole oggi più che mai l’utente lontano dal processo di produzione. Tra le icone emerse da questo progetto, la Sedia P., primissimo progetto di Autoprogettazione, diventato il simbolo, nell’immaginario collettivo, del lavoro di Mari come progettista. Il suo lavoro con l’auto-progettazione svolgeva un ruolo didattico prima che funzionale: toccando con mano gli elementi alla base della produzione di un arredo, infatti, l’utente poteva sentirsi libero di reinventarlo e adattarlo alle proprie necessità, sia pur seguendo un schema tecnico già stabilito. L’autoprogetto così inteso rivendicava il ruolo dell’individuo rispetto al processo di produzione, cercando di riavvicinarlo alla materia.



Del suo impatto sul panorama culturale italiano ne darà una definizione il designer Alessandro Mendini, quando nel 1980, sul numero 607 di Domus scriverà: “Mari non è un designer, se non ci fossero i suoi oggetti mi importerebbe poco. Mari […] è la coscienza di tutti noi, è la coscienza dei designers, questo importa”. Per Mendini che aveva condiviso con lui un approccio radicale e utopista alla progettazione, Enzo Mari era un “inquisitore progettuale”, intento a lanciare laconiche invocazioni ai suoi contemporanei e ai suoi colleghi. I suoi appelli suonavano come un: “Vuotate tutto, cambiate tutto, reinventate tutto!”.
Eppure, nonostante i suoi sforzi per risvegliare le coscienze le cose sono andate in modo diverso. Enzo Mari non ha mai nascosto la sua disillusione nei confronti della direzione intrapresa dal design italiano, in quello che lui stesso, nella sua autobiografia, considera: “un’ondata di spazzatura che è aumentata a dismisura fino ad oggi […]”, adducendone la causa alle regole del mercato globale, che ha imposto all’oggetto la facile replicazione al minor prezzo possibile, a scapito dei Paesi dove la manodopera è meno cara. Ciò che Mari provava a spiegare precedendo di diversi decenni i tempi è che il concetto di ecologia da solo non basta, quello di cui la società ha bisogno è di attuare una decrescita consapevole, partecipata e su larga scala, che permetta l’abbandono di oggetti inutili e non etici. Non si tratta di un pensiero utopico, ma di una necessità dell’uomo contemporaneo, posto dinanzi alla sua unica vera sfida: sopravvivere. Enzo Mari ha speso la propria esistenza cercando di promulgare un’idea del design che fosse incompatibile con le logiche del mercato odierno, e osasse sfidare in questo modo l’idea che gli oggetti dovessero essere “temporanei”.

Arrabbiato, critico e volutamente distante dal mondo culturale che apparteneva ai suoi colleghi, alla domanda di chi fosse per lui il miglior progettista, Enzo Mari rispose: “[…] È un vecchio povero contadino che pianta un bosco di castagni. Non potrà mangiare le prime castagne, non potrà utilizzare il legno, in agosto non potrà godere dell’ombra di un grande albero. Lui no, i suoi nipoti sì”. Mari cercò di elevare il design a uno strumento di emancipazione, combattendo apertamente ciò che lui definiva “la cultura del karaoke”, dell’imitazione. Per lui l’utopia era il “corrimano etico” a cui appoggiarsi per introdurre riforme concrete. Il “bosco di castagni” che Enzo Mari ci ha lasciato, è l’idea che ogni uomo sia in grado di progettare per se stesso e che, al di là della strada seguita dalle aziende e dal mercato, sovvertire l’ordine costituito sia un nostro dovere, se vogliamo vivere in un mondo migliore, “progettare per non essere progettati”, come avrebbe detto lui.
