
Da una controstoria culturale degli anni Novanta in Italia, segnati da una fitta rete di centri sociali che diventano fortini di resistenza culturale e politica, a una riflessione sull’amicizia femminile, passando per biografie sul nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, e romanzi che attraversano 15 anni di storia degli USA, ecco cosa abbiamo letto questo mese.
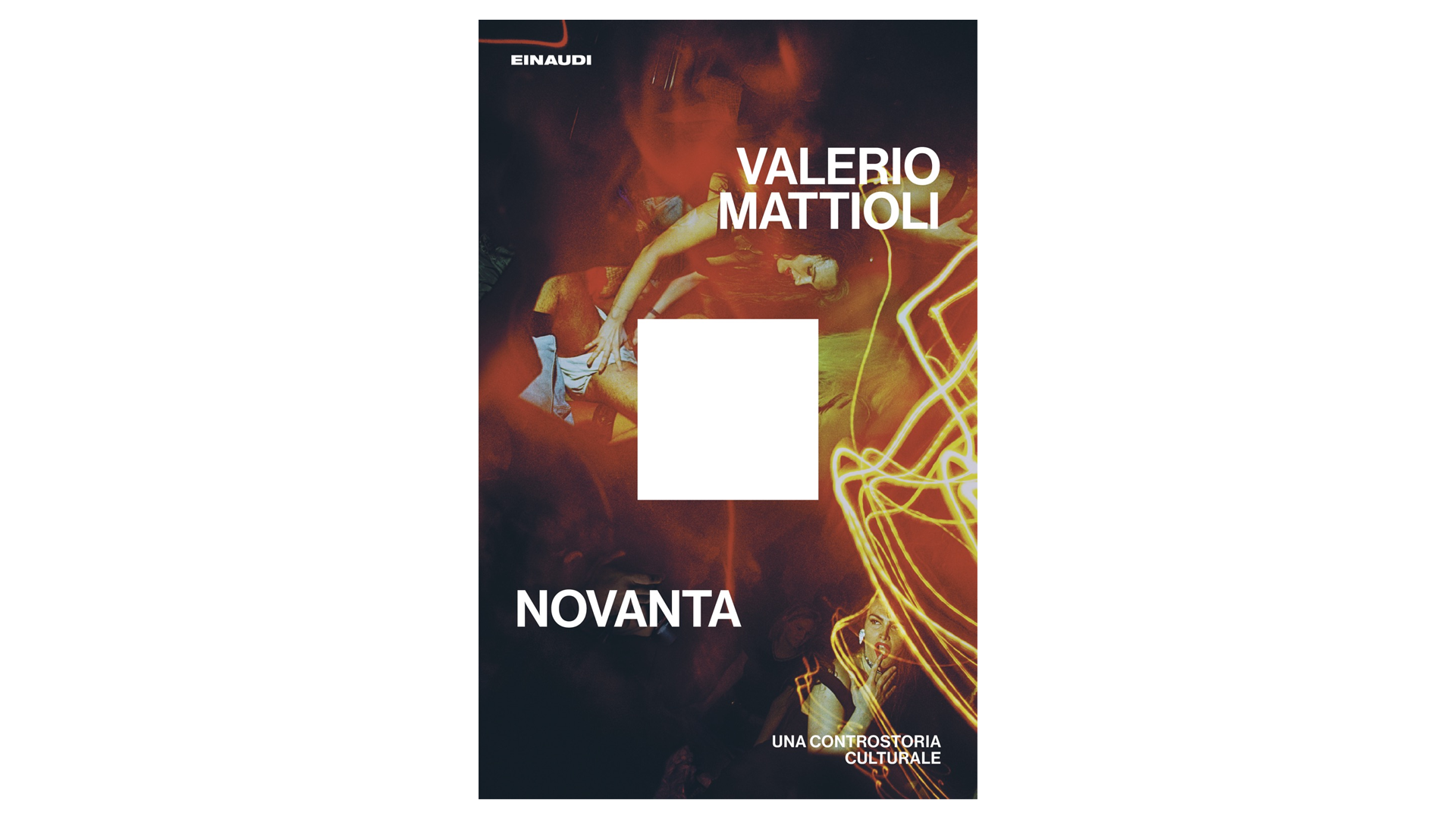
Novanta. Una controstoria culturale, di Valerio Mattioli (Einaudi)
Per la retorica ufficiale, gli anni Novanta sono un corridoio chiuso tra due date: il 9 novembre 1989, con il crollo del Muro di Berlino e la “fine della storia”, e l’11 settembre 2001, con le Torri Gemelle e lo “scontro di civiltà”. In mezzo, il racconto rassicurante del trionfo dell’Occidente, della fine delle ideologie, di una pace garantita dal mercato.
Novanta. Una controstoria culturale di Valerio Mattioli ribalta questo quadro e mostra cosa succede se, invece di guardare ai palazzi del potere, si seguono le tracce lasciate ai margini: riviste fotocopiate, spazi autogestiti, free party in capannoni abbandonati, occupazioni e assemblee. Ne esce la mappa di un’Italia attraversata da una fitta rete di centri sociali, da Nord a Sud, che diventano fortini di resistenza culturale e politica. È lì che nascono il primo rap in italiano, le distopie cyberpunk, una cultura rave radicale, le riflessioni su reddito di base, sorveglianza digitale, neoliberismo tecnologico: temi considerati allora fantasie da estremisti e oggi al centro del dibattito pubblico.
Luoghi come il Leoncavallo, il Cox 18, il Forte Prenestino, il CPA, il Livello 57 o Officina 99 accolgono posse rap come Assalti Frontali, Sangue Misto e 99 Posse, riviste come Decoder e Torazine, compagnie teatrali, hacker, Mutoid e mille altre esperienze. Mattioli sostiene che “il meglio della cultura italiana” dei Novanta sia passato da lì e che senza quelle infrastrutture dal basso molte traiettorie artistiche non esisterebbero. Novanta. Una controstoria culturale tiene insieme politica e cultura senza edulcorare nulla: mette in scena fratture e conflitti – tra Tute Bianche e squatters, tra b-boys puristi e posse politicizzate, tra chi rifiutava ogni dialogo con le istituzioni e chi lo sperimentava. Più che un modello da mitizzare, quella stagione diventa un archivio di pratiche, immaginari ed errori da cui ripartire per leggere il presente. Con una certezza: mentre qualcuno decretava la fine dei conflitti, un’altra storia continuava a scriversi dal basso. Ed è, che lo vogliamo o no, anche parte della nostra.
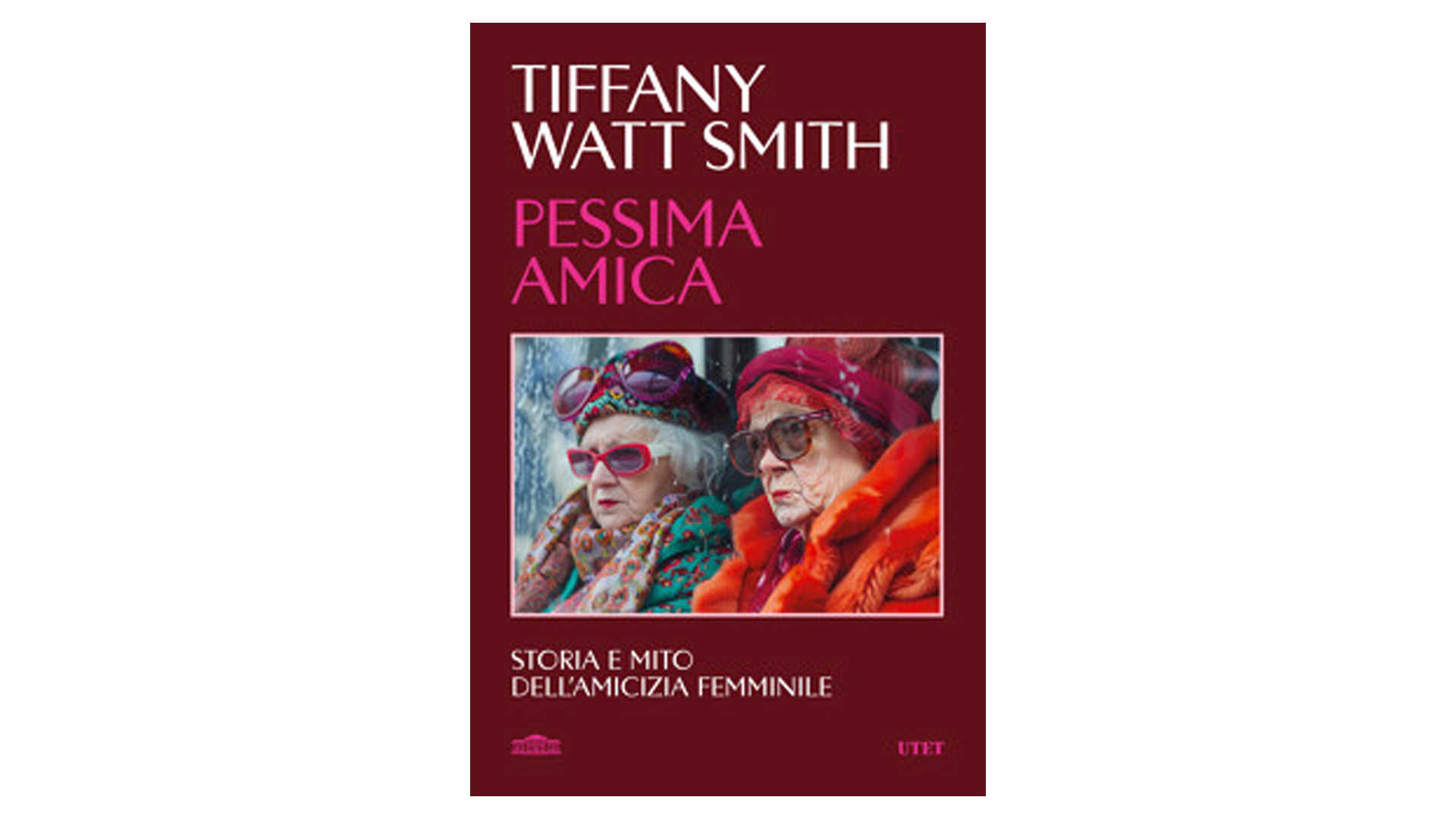
Pessima amica, di Tiffany Watt Smith (Utet)
Come purtroppo sappiamo l’amicizia femminile non è affatto quel santuario perfetto e irreale che ci hanno fatto credere, fatto di complicità assolute, viaggi, aperitivi e messaggi vocali terapeutici. Pessima amica, il nuovo saggio di Tiffany Watt Smith – storica culturale e autrice del bestseller Atlante delle emozioni umane – parte proprio da qui: dal “sospetto” che dietro il mito dell’amicizia tra donne si nasconda un mondo molto più contraddittorio, vulnerabile e, soprattutto, reale. Watt Smith confessa subito il suo disagio di fronte al topos delle amiche-alleate-perfette: nella sua vita, come in quella di molte altre, le amicizie non assomigliano neanche per sbaglio ai legami indissolubili delle serie tv. Ci sono rotture improvvise, tradimenti, amicizie evaporate nel silenzio, presenze invadenti che diventano un peso, rapporti sbilanciati che vivono di aspettative mai dette, ipocrisia e prepotenza. Eppure, sono proprio queste crepe a diventare la premessa del suo viaggio attraverso i secoli, le culture, e le classi sociali: dai collegi vittoriani alle comuni hippy, dai quartieri della middle class alle comunità beduine. I legami tra donne, nonostante le loro ombre, reggono anche interi mondi: proteggono, sostengono, accendono movimenti politici, creano spazi di libertà per corpi e desideri.
Il libro smonta così, con ironia e precisione storica, l’idea che l’amicizia femminile sia un fenomeno recente o accessorio. Per secoli è stata ignorata, negata, addirittura considerata impossibile. Oggi, invece, viene caricata di aspettative sproporzionate: dovrebbe essere intensa ma non soffocante, leale ma senza drammi, sempre presente ma mai dipendente. E quando non lo è, ci convinciamo di essere noi le pessime amiche. Pessima amica ci libera proprio da questo: dagli ideali impossibili che pesano su legami che, come ogni relazione umana, sono fatti anche di goffaggini, errori, sbilanciamenti. Watt Smith ci invita a guardarli da vicino, a ridere delle nostre ansie (“Le avrò scritto troppo?”, “Perché visualizza e non risponde?”), e a recuperare quella gioia istintiva e scomposta che rende le relazioni vere, non perfette. Questo saggio illumina – finalmente – quella “vasta sala non ancora visitata”, come la definiva Virginia Woolf, “[…] tutta mezze luci e ombre profonde, come quelle grotte labirintiche dove si va con una candela in mano, scrutando qua e là, senza sapere dove si mettono i piedi” delle amicizie tra donne. In cui, grazie a questo libro, possiamo quantomeno entrare senza dover fingere di essere migliori di ciò che siamo.
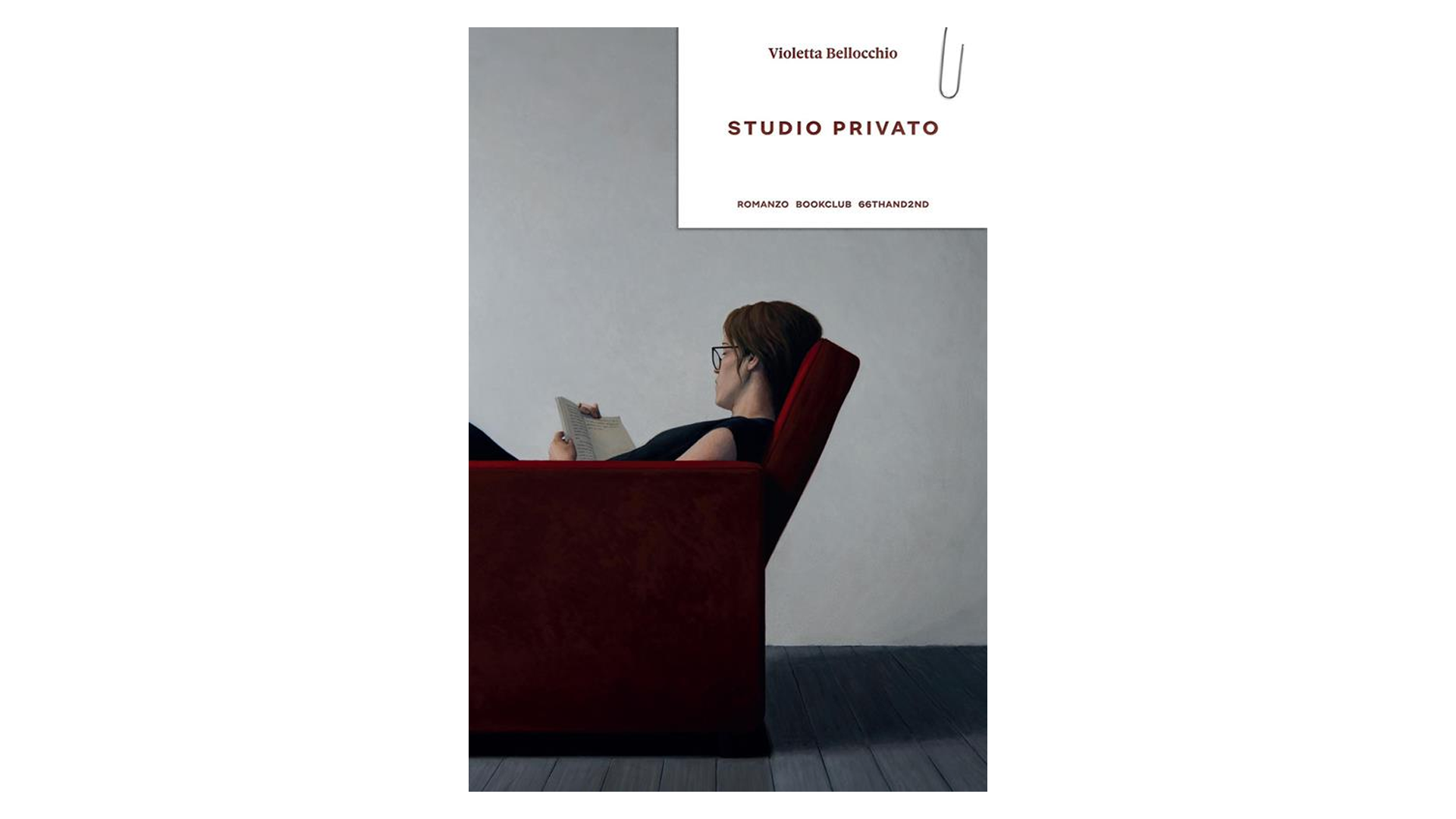
Studio privato, di Violetta Bellocchio (66thand2nd)
Che cosa succede quando la temperie culturale di una città come Milano riesce a trasformare anche la salute mentale in una performance, una valuta, un brand? Studio privato, il nuovo libro di Violetta Bellocchio, attraversa questa città con la precisione di un bisturi e la tenerezza di chi quel luogo lo ha davvero abitato fino allo stremo, e le ha restituito allo specchio un’immagine ambivalente: la “pazza da sedare” e la “professionista affidabile” a cui persone facoltose e disperate (come tutte) affidano le proprie ferite. Due ruoli opposti, apparentemente incompatibili, eppure al tempo stesso perfettamente coerenti con una cultura che trasforma il disagio in un servizio e la cura in un mercato, in cui niente si spreca, tutto va monetizzato. Bellocchio racconta di essere stata etichettata, in un colloquio durato una decina di minuti, come un caso che necessitava di pesanti cure farmacologiche; e, quasi in parallelo, di essere stata ingaggiata – in nero – come “psicologa” da un gruppo di sedicenti curanderi che si muovevano al confine tra naturopatia, rituali sincretici, medicina cinese, beauty farm e altre derive del benessere contemporaneo.
Ma il paradosso in cui si trova l’autrice non è solo suo. Siamo incoraggiati a occuparci della nostra salute mentale, sì, ma purché questo serva a restare sempre e comunque iperproduttivi, allenati alla reinvenzione costante, sempre pronti a fatturare senza cedimenti, a cercare nuovi clienti, a dimostrarci funzionali, prestanti, vincenti in tutti gli ambiti dell’esistenza. In questo doppio binario – grave paziente, terapeuta ready-made – Bellocchio mette a nudo un sistema che rimbalza le persone più vulnerabili tra studi privati, diagnosi affrettate e illusioni terapeutiche, spingendole in molti casi nel cercare aiuto altrove, e finendo in mani non del tutto oneste. E lo fa con la sua voce inconfondibile: evocativa e tagliente, intima e feroce, capace di trasformare il caos di questa piccola metropoli in una tragicommedia, dove l’assurdo si fa verità, forse l’unica. Studio privato è un memoir che scava nella carne delle contraddizioni milanesi, raccontando cosa resta dei suoi abitanti quando la città chiede loro tutto, troppo, di mostrarsi fragili e invincibili allo stesso tempo, come intrappolati in una nevrosi collettiva. Un libro che aspettavamo, che ci fa sorridere, arrabbiarsi e riconoscersi. E che, come sempre quando si tratta della scrittura di Bellocchio, non offre consolazioni facili: solo una lucidità tagliente che, a suo modo, ci cura.

Come la luce tra le foglie, di Joyce Maynard (NN)
Ci sono romanzi che non si limitano a raccontare una storia, ti prendono per mano e ti ci portano all’interno, la attraversano insieme a te, ti costringono a fermarti, respirare, ricordare ricordi che non sono i tuoi ma che improvvisamente sembrano essere parte di te. Come la luce tra le foglie di Joyce Maynard è uno di quei libri. È il seguito de L’albero della nostra vita, ma non serve aver letto il primo per restare rapiti da Eleanor, la donna al centro di queste pagine. Dopo la morte dell’ex marito, Cam, Eleanor vive ancora nella fattoria del New Hampshire in cui ha cresciuto i suoi figli e costruito, pezzo dopo pezzo, quell’idea di felicità che ora le sembra sul punto di sfaldarsi. Nel 2010,a cinquantaquattro anni la ritroviamo sola, con accanto Toby, il figlio più vulnerabile, che le è rimasto più vicino. A tenerlo legato a lei non è solo l’amore, ma una lesione permanente causata da un incidente avuto da piccolo, che richiede cure continue. Intorno a loro la famiglia si è dispersa: Al, il maggiore, dopo la transizione vive a Seattle con la moglie, lontano ma non dimentico del passato; e la figlia Ursula, in Vermont con i suoi due figli, ha invece sepolto sotto a un rancore feroce il suo legame con la madre. È una famiglia scheggiata, attraversata da faglie che sembrano impossibili da riunire. Eleanor, però, non smette di credere ostinatamente nella fragile possibilità di rimettere insieme ciò che ha amato e che ama.
Ed è questa speranza a guidarla attraverso quindici anni di storia degli Stati Uniti, in cui la vita privata e quella collettiva finiscono sapientemente per confondersi: la crisi climatica che altera il ritmo delle stagioni, le sparatorie di massa che cambiano la percezione della sicurezza, l’assalto a Capitol Hill che incrina un intero immaginario democratico. Maynard non usa la Storia come sfondo, ma come pressione costante su chi, nel quotidiano, cerca semplicemente di sopravvivere e proteggere i propri affetti, come un vero e proprio personaggio agente. E poi c’è l’amore, un amore nuovo, inatteso, che entra nella vita della protagonista come una promessa che sembrava irraggiungibile. Perché questo romanzo parla soprattutto di seconde possibilità, quelle che ci sorprendono proprio quando pensiamo di non meritarle più. Come la luce tra le foglie è un romanzo pieno di dolore, ma anche pieno di luce, una storia di riparazione, che accoglie tutte le nostre umane imperfezioni con tenerezza, una storia che di questi tempi potrebbe farvi bene leggere, per sentirvi un po’ meno soli e spaesati.
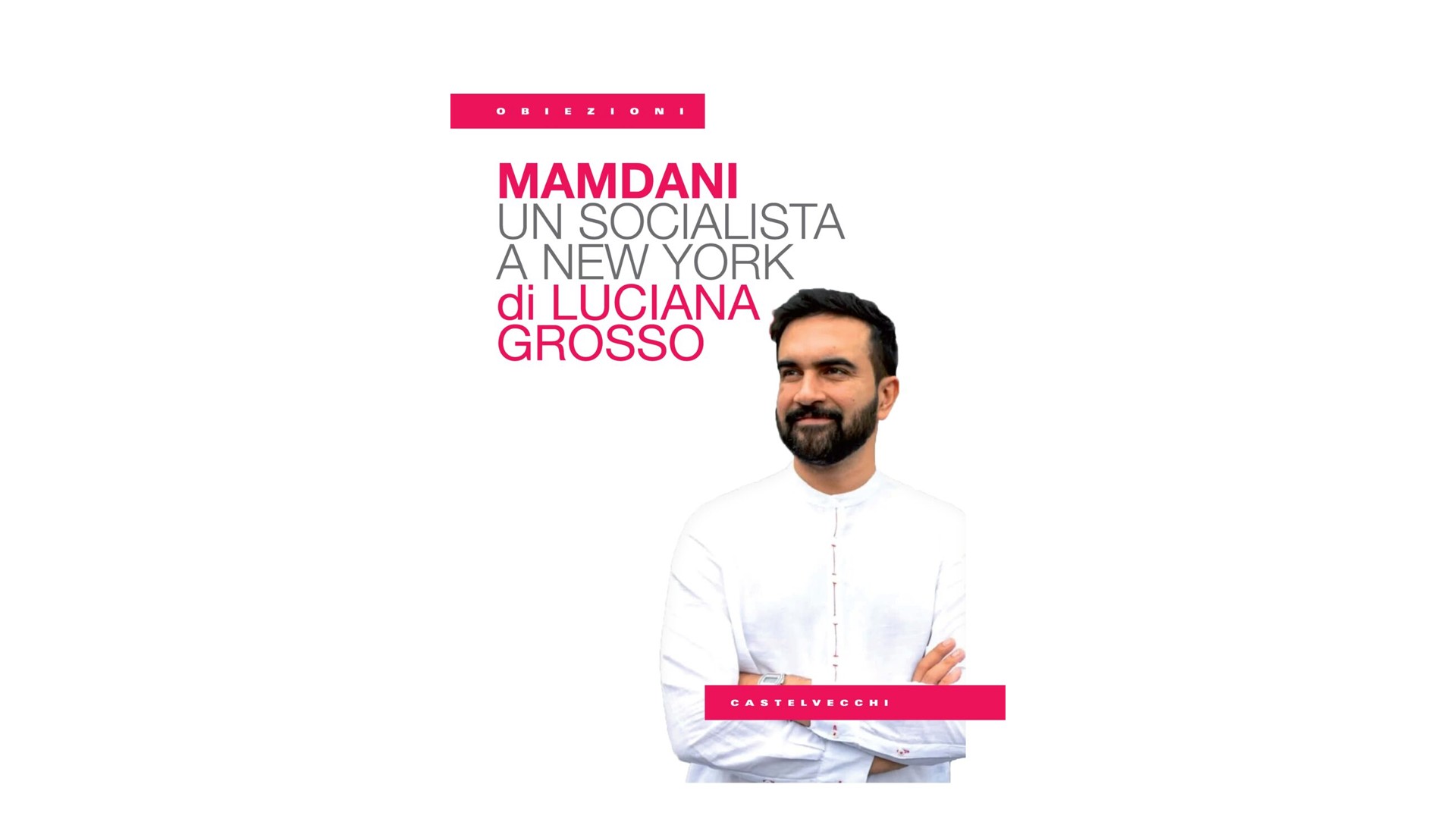
Mamdani. Un socialista a New York, di Luciana Grosso (Castelvecchi)
La storia di Zohran Mamdani sembra uscita da un romanzo. E invece è tutto vero: un trentatreenne di origini indiane, musulmano, socialista e sconosciuto che sbaraglia Andrew Cuomo – uno dei boss più consolidati del Partito Democratico, per quanto caduto in disgrazia – e vince le elezioni per una carica tanto simbolica quanto complessa: il sindaco di New York.
Nel libro Mamdani, un socialista a New York, la giornalista Lucia Grosso ricostruisce con precisione chirurgica il contesto in cui esplode il “caso Mamdani”: un Partito Democratico logorato da anni di compromessi e rese identitarie, un’America guidata per il secondo mandato da Donald Trump e una base progressista sempre più insofferente verso il centrismo che per decenni ha dominato la scena.
Il libro mostra come la vittoria di Mamdani non sia un miracolo ma il risultato di un ottimo lavoro comunicativo e di una strana costante della politica statunitense: i predestinati, all’elettorato, non sembrano piacere. Una verità particolarmente evidente nel caso di Hillary Clinton, battuta inaspettatamente nel 2016 dal neofita Donald Trump. Come Clinton, anche Cuomo sembrava aver dato per scontato la vittoria, invece i newyorkesi hanno optato per altro.
Grosso mette in luce la fragilità dell’establishment democratico, incapace di leggere i segnali che arrivano dal basso, ma sottolinea anche la difficoltà di gestire una città come New York, soprattutto per un politico alle prime armi. Mamdani potrebbe rappresentare il primo tassello di una nuova sinistra americana, ma il pericolo che non riesca a mantenere le promesse c’è, ed è concreto.
Grosso non dà risposte facili, e proprio per questo il libro funziona: perché mostra la faticosa battaglia in corso. Se il futuro del Partito Democratico passerà da figure come Mamdani o tornerà a rifugiarsi nel centro rassicurante lo decideranno gli elettori. Ma una cosa è chiara: da New York arriva un segnale forte. E arriva dalla base, che ha trovato una voce nuova e, a sorpresa, socialista.
