
Dal romanzo vincitore del Premio Strega, che si chiede cosa succede quando la famiglia, invece di essere rifugio e conforto, diventa un carcere invisibile e totalizzante, a un saggio che intreccia cibo e cultura per raccontare la storia della Cina, passando per un memoir sul ricordo, il lutto e l’amore in un giardino simbolico dove vita e morte si incontrano, ecco cosa abbiamo letto questo mese.
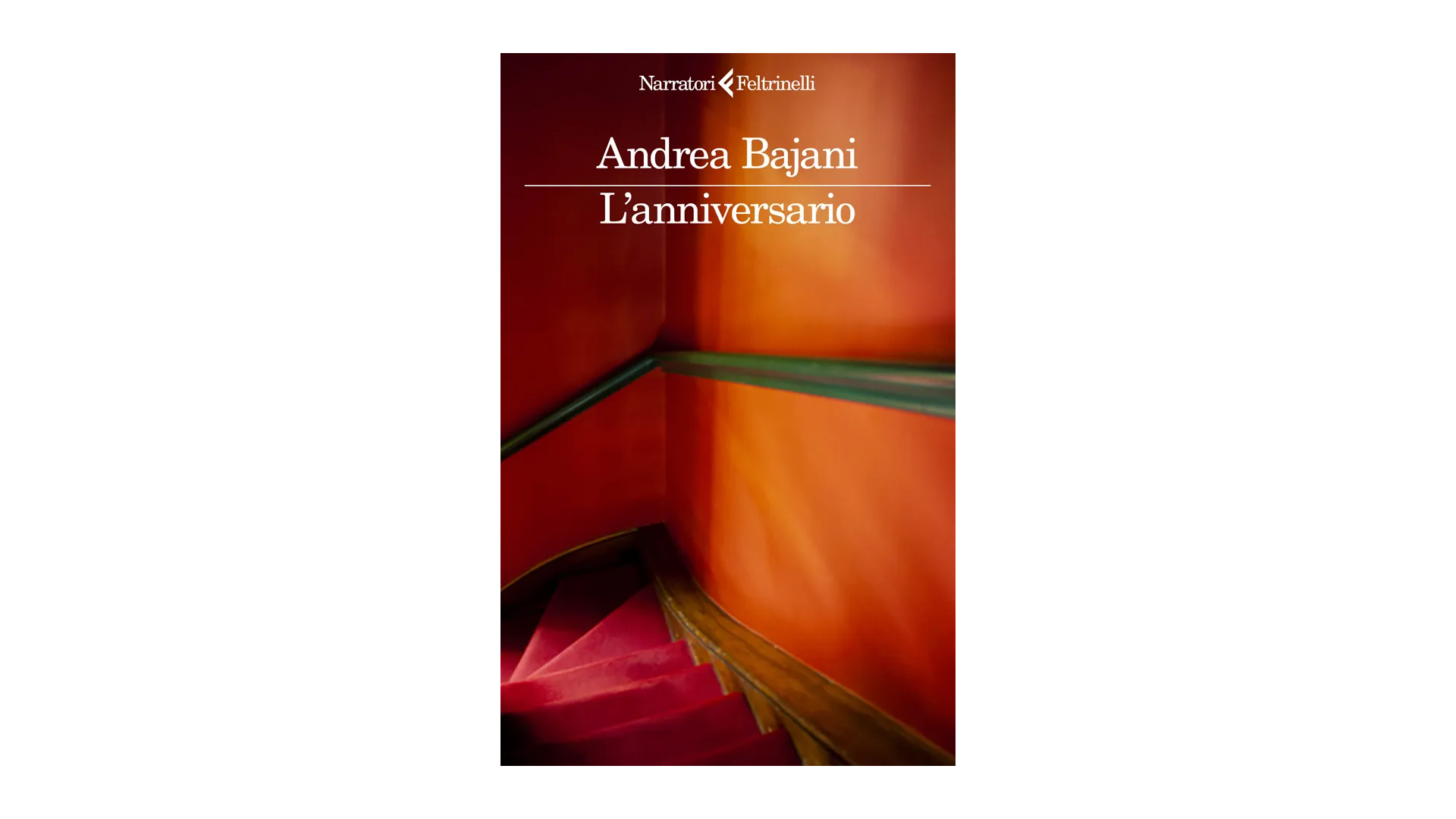
L’anniversario, di Andrea Bajani (Feltrinelli)
Cosa succede quando la famiglia, invece di essere rifugio e conforto, diventa un carcere invisibile e totalizzante? In L’anniversario, vincitore del Premio Strega e dello Strega Giovani 2025, Andrea Bajani affronta una delle domande più scomode e inconfessabili: si può abbandonare la propria famiglia per salvarsi? Si può scegliere, da figli, di voltare le spalle e non guardare più indietro? Il romanzo si apre con una dichiarazione secca e definitiva: “Dieci anni fa ho visto i miei genitori per l’ultima volta”. Da quel momento, il protagonista – alter ego narrativo dell’autore – ha cancellato ogni contatto, ha attraversato l’oceano, ha costruito una nuova vita liberandosi da un passato che non ammetteva compromessi. È questa distanza, fisica e affettiva, a rendere possibile il racconto: un anniversario silenzioso, ma lacerante, che permette finalmente di nominare ciò che prima era indicibile. Bajani racconta questa storia senza mai indulgere nel vittimismo, con quella “voce scandalosamente calma” che Emmanuel Carrère ha giustamente individuato come la cifra più spiazzante e potente del romanzo.
Il dolore è ovunque, ma è trattenuto, elaborato, messo in forma attraverso una lingua esatta, che scava, porta alla luce, purifica. La casa dell’infanzia viene descritta come un microcosmo oppressivo, in cui vige la legge non detta del padre-padrone e la sottomissione muta della madre: un regime domestico che si regge sull’amore come pretesa, sull’isolamento come metodo, sulla vergogna come collante. Eppure, L’anniversario non è un libro contro qualcuno, ma per qualcosa: per la libertà di scegliersi, di smettere di obbedire, di interrompere una catena di dolore che si protrae di generazione in generazione. È un romanzo di formazione e di emancipazione, dove l’atto di raccontare coincide con quello di salvarsi. L’anniversario, pur raccontando una storia eccezionale, parla a tutti: di come si cresce, di quanto può costare dire “basta”, di ciò che siamo disposti a perdere per diventare pienamente noi stessi. È un libro che non fa sconti e non cerca perdono o redenzione, ma ci accompagna, con compassione e lucidità, nel territorio più pericoloso di tutti: quello delle nostre origini, dei legami di sangue, e ci mostra che l’unica vera fedeltà che a volte dovremmo sforzarci di mantenere è quella verso la nostra stessa voce.
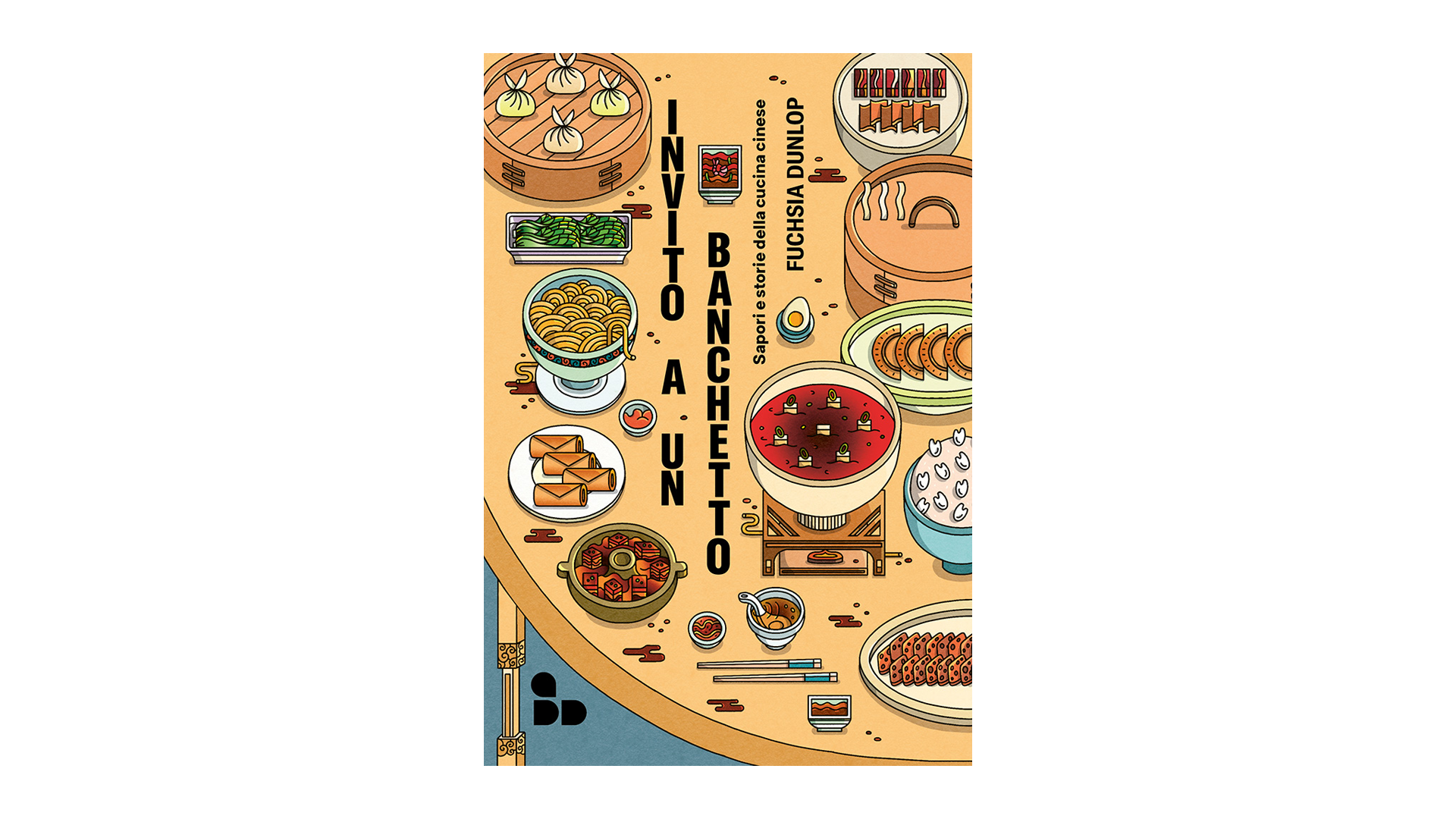
Invito a un banchetto, di Fuchsia Dunlop (add editore)
Un piatto non è mai solo l’insieme degli ingredienti di cui è composto, ma è come una finestra aperta sul mondo e sull’altro. Un tramite per scoprire, esplorare, conoscere ciò che accade al di fuori del perimetro in cui ci muoviamo. Fuchsia Dunlop è, da tempo, una delle voci occidentali più autorevoli nel raccontare la cucina cinese, e con Invito a un banchetto: Sapori e storie della cucina cinese l’autrice britannica firma un’opera a metà tra saggio storico, memoir culinario e dichiarazione d’amore verso una delle tradizioni gastronomiche più complesse, sofisticate e fraintese del mondo, che si propone proprio di fare del cibo un tramite per il mondo. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: un invito ad abbandonare i preconcetti che l’Occidente ha costruito intorno alla cucina cinese. Fin dalle prime pagine, infatti, Dunlop smonta l’immagine monolitica e stereotipata che spesso viene associata al cibo cinese nei Paesi occidentali: unto, approssimativo, privo di raffinatezza. In realtà, si tratta di una galassia culinaria vastissima, stratificata e profondamente legata alla cultura, alla medicina, alla filosofia e alla storia. Dunlop usa ogni pietanza come chiave d’accesso per esplorare un aspetto della cultura gastronomica cinese: il significato della consistenza (“mouthfeel”), l’estetica del taglio, la centralità del riso rispetto al grano, le origini della fermentazione, o l’idea di armonia tra gli ingredienti, creando una sorta di mappa sentimentale della cucina cinese. Partendo dai noodles, discute l’importanza del glutine e delle farine nel Nord della Cina, tracciando un arco che va dalla storia agricola all’arte dell’impasto; da un semplice piatto di tofu fermentato, ricostruisce la complessa alchimia della conservazione e il ruolo simbolico del “marcio” nella cultura alimentare asiatica.
Alternando momenti di introspezione personale – dai suoi primi viaggi in Cina negli anni ’90 al suo percorso per diventare la prima straniera ad aver studiato alla prestigiosa scuola di cucina di Sichuan – a riflessioni accademiche, linguistiche e storiche, l’autrice britannica costruisce un’argomentazione profonda a favore del pluralismo culinario. Il razzismo alimentare, la sinofobia che ha accompagnato la diaspora, le accuse di “barbarie” rivolte alla cucina dell’Altro, sono tutti elementi culturali che hanno costruito socialmente un senso di disgusto verso tutto ciò che non è considerato occidentale. In un momento storico in cui la destra alimenta il gastronazionalismo, Invito a un banchetto si pone come un manifesto in difesa della diversità gastronomica – non solo da preservare, ma da comprendere e celebrare, anche contro un mondo globalizzato in cui l’uniformità del gusto minaccia le tradizioni locali.
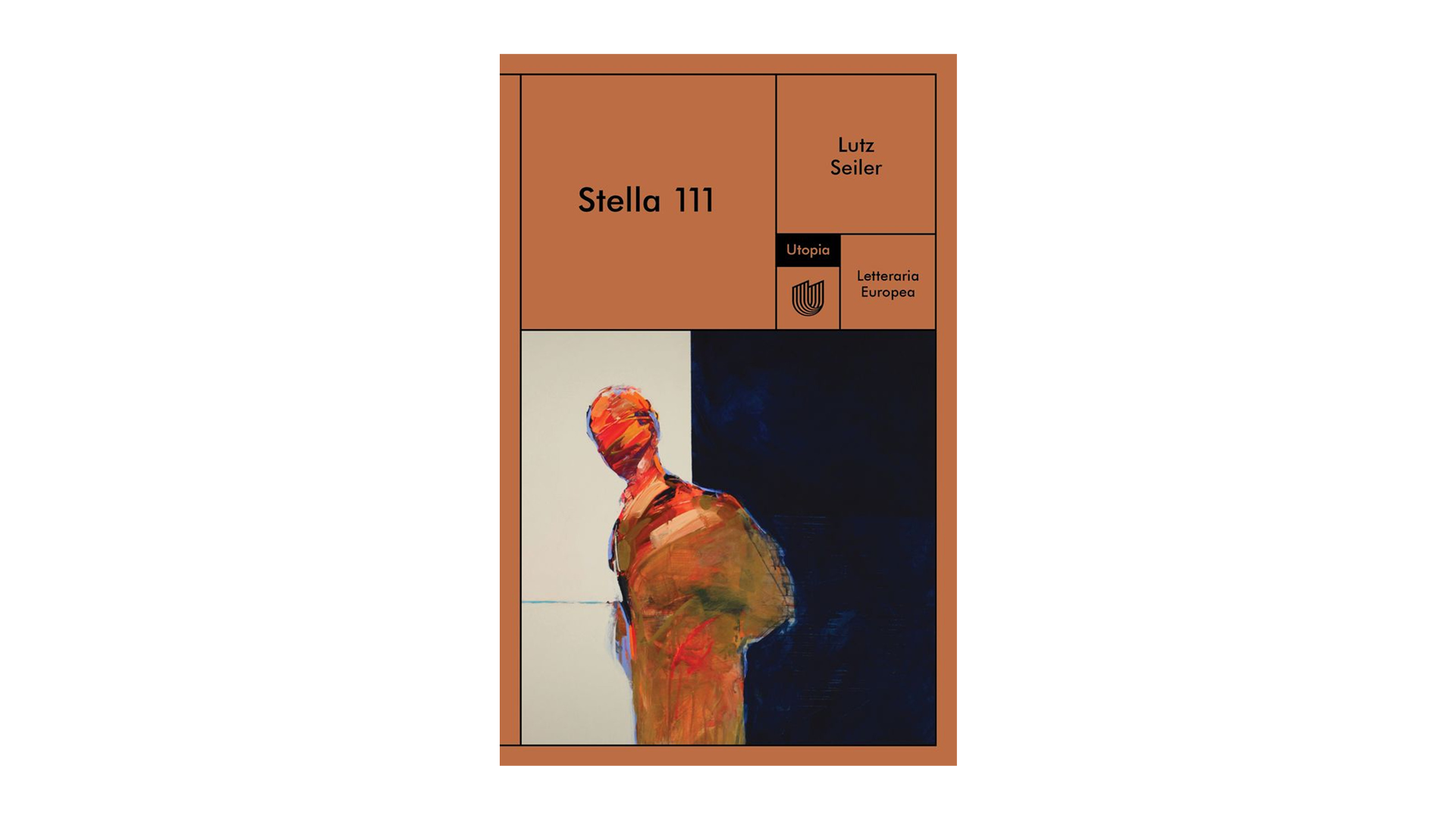
Stella 111, di Lutz Seiler (Utopia)
Vincitore del Premio della Fiera del Libro di Lipsia (2020) e pubblicato in Italia da Utopia, Stella 111 è un romanzo ambizioso che unisce racconto di formazione, memoria storica e indagine esistenziale. Al centro: la fragilità dell’identità nel momento in cui una nazione intera cambia pelle. Il romanzo si apre nell’inverno del 1989-1990, subito dopo la caduta del Muro di Berlino. Nella Germania dell’Est ormai sventrata dall’euforia e dall’incertezza, due genitori – Inge e Walter – decidono di partire per Ovest, abbandonando la DDR ormai agonizzante per “ricominciare”. Ma il loro figlio Carl, ventiquattrenne, resta a Berlino Est. Ed è da questo abbandono che parte la sua traiettoria narrativa: una lenta e tortuosa immersione nel caos del tempo presente, alla ricerca di una nuova collocazione nel mondo. Proprio Berlino è forse la vera protagonista del romanzo. Ma non la Berlino “capitale” dei libri di storia, bensì quella dei margini, delle rovine. Seiler ci conduce in un sottosuolo sociale e culturale fatto di artisti, musicisti, vagabondi, falsi profeti e anarchici che cercano di reinventare la vita tra le macerie del socialismo reale.
Stella 111 è un romanzo di formazione atipico, che rifugge dalle tappe canoniche del genere per costruire una traiettoria più onirica e poetica. Carl non cresce verso qualcosa di definito, bensì vaga, si smarrisce, si disgrega. Seiler restituisce questo senso di spaesamento con una prosa che alterna momenti di estrema densità lirica a passaggi di sorprendente concretezza. Il titolo stesso del romanzo allude a una radio di fabbricazione sovietica, un oggetto ereditato dal padre e simbolo di un passato ideologico e affettivo che continua a risuonare nella sua vita. Quello di Seiler non è solo un romanzo storico, ma una riflessione profonda sulla transizione: quella di un paese, di un sistema, di un’identità personale. Ciò che gli interessa è la frattura, il trauma silenzioso che accompagna il passaggio dalla collettività alla solitudine, dalla stabilità alla libertà disorientante. È un romanzo denso, stratificato e profondamente originale. Non cerca facili risposte, non propone una lettura definitiva della fine della DDR né una morale da esportare. È piuttosto un viaggio dentro l’incertezza, la solitudine e la possibilità di rinascere.
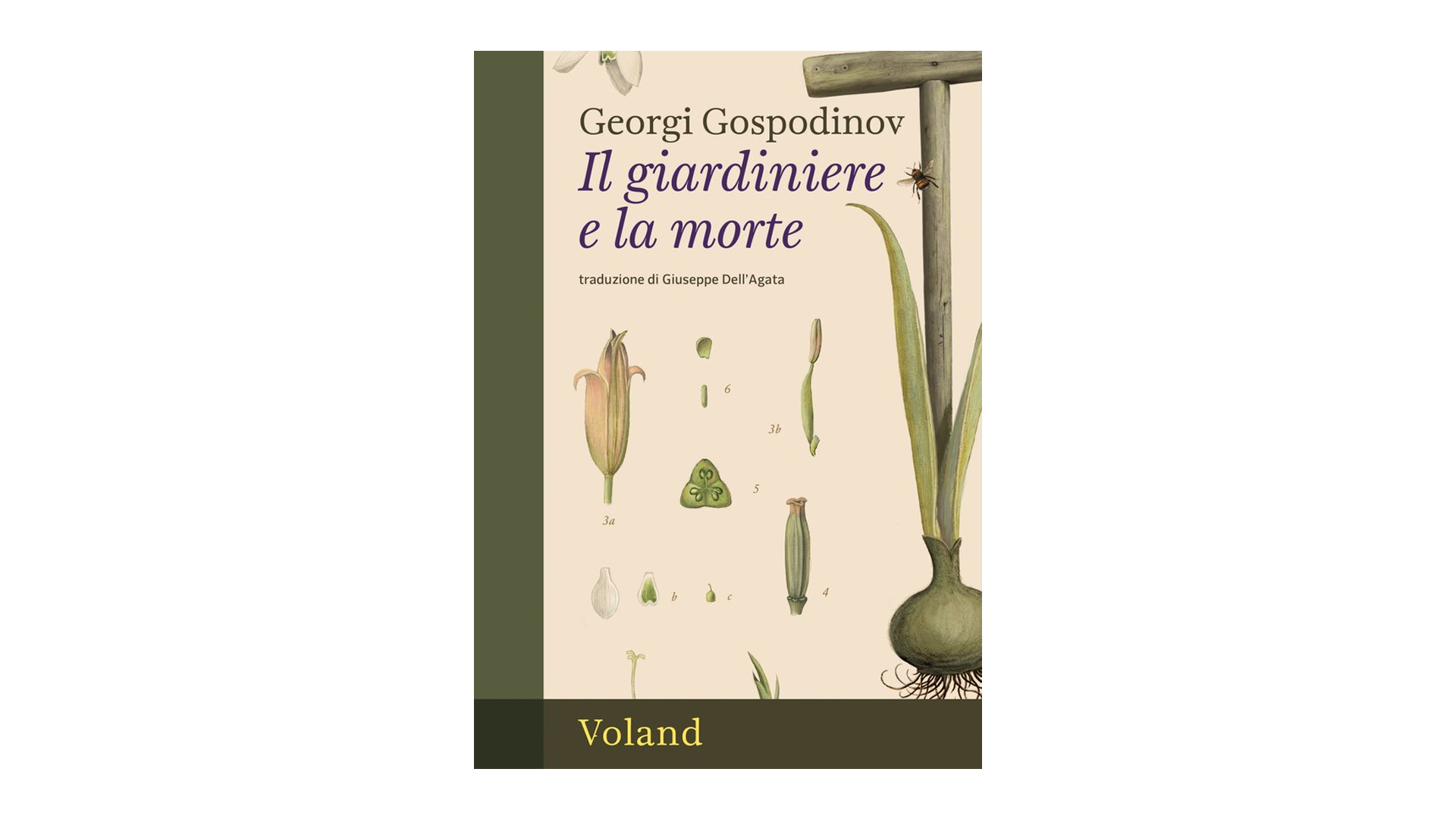
Il giardiniere e la morte, Georgi Gospodinov (Voland)
“Mio padre era giardiniere. Ora è giardino”, scrive Georgi Gospodinov nel primo rigo del suo ultimo libro, trasformando questa frase in un leitmotiv che celebra la ciclicità della vita. Nel tempo delle piante, che si rigenerano senza fine, la morte perde il suo volto temibile, diventando parte di un eterno ritorno: e questo un giardiniere lo sa.
Con l’acclamato Il giardiniere e la morte – edito in Italia da Voland, con traduzione di Giuseppe Dell’Agata – Gospodinov, voce autorevole della letteratura europea, consegna un’opera struggente che sfuma i confini tra fiction e memoir, intrecciando ricordo, lutto e amore in un giardino simbolico dove vita e morte si incontrano. Dopo Cronorifugio, premiato con il Booker Prize 2023 e il Premio Strega Europeo 2021, l’autore bulgaro conferma la sua abilità nel tradurre il personale in universale. L’opera, composta da novantuno frammenti poetici, rinuncia a una narrazione lineare per un mosaico di ricordi che si ramificano come radici. Al cuore, il legame tra un figlio e il padre anziano e morente.
Oltre a una calorosa vita famigliare, nel libro Gospodinov dipinge una Bulgaria umile ma dignitosa, intrecciando il destino individuale con il crollo del socialismo e la resilienza di una generazione forgiata dalla guerra. La prosa, malinconica ma mai cupa, bilancia poesia e racconto: Gaustìn, alter ego dell’autore, è una presenza discreta che lascia spazio al padre, figura quasi mitologica nella sua umanità.
Un tema universale del libro, che tocca corde profonde, è il senso di colpa dei figli costretti a vivere lontani dai genitori anziani per inseguire carriere o vite altrove. Gaustìn, diviso tra la Bulgaria e un’Europa cosmopolita, incarna questo conflitto. Il rimpianto si annida nei gesti semplici del padre – potare rose, lavorare la terra – che il figlio non può replicare né ricompensare. La distanza fisica si fa metafora di un distacco emotivo involontario, un destino imposto dalla modernità. Gospodinov, però non cede all’autocommiserazione: il giardino paterno, con i suoi cicli vitali, offre una redenzione. Scrivendo, Gaustìn coltiva le sue memorie, perpetuando l’eredità del padre.
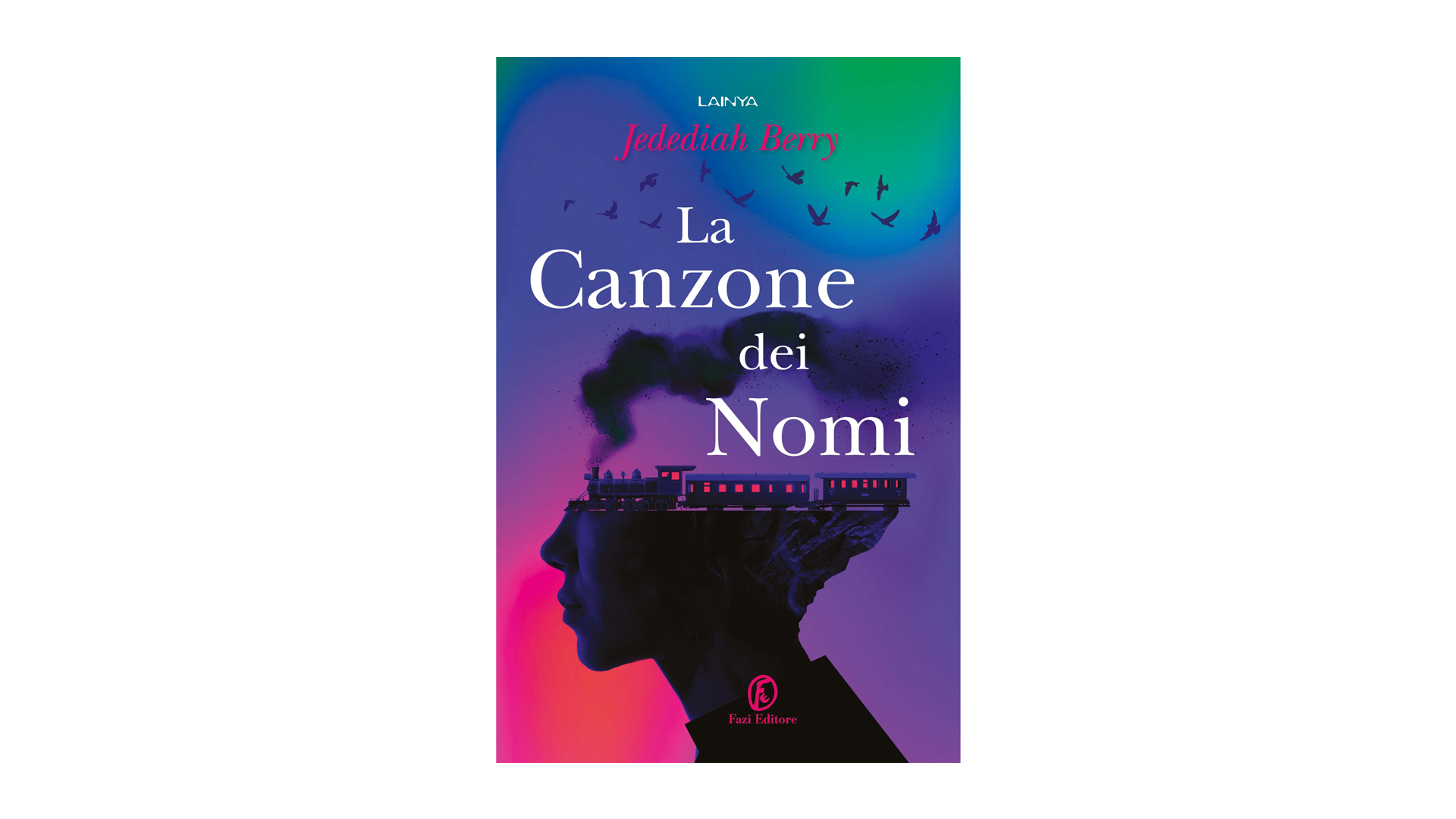
La canzone dei nomi, di Jebediah Berry (Fazi Editore)
Cosa accadrebbe se le parole sparissero, e con loro anche il senso delle cose? Se non potessimo più chiamare una casa “casa”, un ricordo “ricordo”, o la paura “paura”? Ne La canzone dei nomi, il romanzo di Jedediah Berry, il mondo è sopravvissuto a una misteriosa catastrofe linguistica: le parole sono svanite, e l’umanità ha dovuto ricominciare da zero, ricostruendo da capo il significato delle cose, e quindi il proprio rapporto con la realtà. In questo scenario post-apocalittico – ma venato di fiaba e mitologia – operano i comitati, gruppi di individui incaricati di rinominare tutto: dai paesaggi ai sogni, dai fantasmi ai mostri. Nulla infatti può essere contenuto, riconosciuto o affrontato se non possiede un nome. È in questa cornice che si muove la protagonista, un’aralda del Comitato dei Nomi, la cui missione è quella di consegnare nuove parole ai villaggi che ancora brancolano nel buio semantico. Eppure, la sua stessa identità rappresenta un’anomalia: lei infatti non ha mai avuto un nome. Quando il mondo comincia di nuovo a vacillare sotto l’attacco di entità non identificate, l’aralda è costretta alla fuga, in compagnia di un trio improbabile e affascinante – un fantasma, un mostro molto goffo e un animale dalla natura misteriosa – che la accompagnerà in un viaggio ai margini dei territori nominati. È qui, nelle crepe del sistema, che incontrerà la compagnia del Quadrato Nero, una stravagante formazione teatrale custode delle antiche storie, narrazioni originarie che non si lasciano addomesticare dalle convenzioni del nuovo ordine.
La scrittura di Berry è ipnotica e visionaria: ogni pagina è un piccolo incantesimo che mescola immaginario fantasioso, riflessioni filosofiche sul linguaggio e una sottile critica politica ai meccanismi attraverso cui il potere impone la propria versione del mondo. Il romanzo ricorda, per certi versi, Il nome del mondo è Foresta di Ursula K. Le Guin, ma anche La Storia infinita di Michael Ende: come in quei casi, la narrazione si fa strumento per interrogarci sul rapporto tra linguaggio, identità e libertà. La canzone dei nomi è una parabola potente e visionaria sulla perdita e sulla riscoperta, sull’uso delle parole non come semplici etichette, ma come strumenti magici capaci di trasformare la realtà, evocare il passato e immaginare il futuro. È anche un’avventura, piena di creature incredibili e momenti di meraviglia, ma che non rinuncia a farci riflettere sul mondo che abitiamo oggi, in cui spesso i nomi vengono usati per manipolare, per ridurre, per cancellare. Con questo romanzo, Berry ci invita invece a “cantare” i nomi, a restituire senso a ciò che è stato dimenticato, a dare voce a ciò che è stato messo a tacere. Perché, come insegna la protagonista, nominare significa anche prendersi cura. E ogni nome, se scelto con attenzione, può diventare una forma di resistenza e di rinascita.
