
Se mi dicessero cosa ti rende italiana, e dovessi rispondere sinceramente, direi le canzoni di Antonello Venditti. Come tutti i nati negli anni Novanta sono cresciuta a Blob e cantautorato italiano. La triade di casa era De André, De Gregori e Venditti – e se il primo mi sembra tuttora una monade irraggiungibile e il secondo ha segnato la mia educazione sentimentale, è al terzo a cui forse sono istintivamente più affezionata. Uno dei miei primi ricordi è quello di me bambina di quattro o cinque anni che schiaccio PLAY sul giradischi e, sdraiata sul tappeto del soggiorno mentre mia madre prepara la cena, mi lascio sommergere dalla voce metallica e dal pianoforte schietto e nostalgico di Venditti che canta “Autostrada deserta, al confine del mare” e sogno – chissà cosa, non lo so – tutto quello che la vita potrà riservarmi.
Venditti per la provincia italiana è la promessa di Roma, il centro delle cose, il seme della vita, Roma quando Roma sa essere l’Italia, quella più bella, godereccia, struggente, passionale, calda e notturna, amata e odiata. Venditti è la possibilità di avere un cuore (“Se c’hai un core tu me poi capì”) e un’identità, la giovinezza di una generazione che non aveva paura di sperare, divisa tra l’obiezione di coscienza e la leva obbligatoria che ti mangiava un anno di vita costringendoti a imbracciare un fucile – magari proprio alla Cecchignola – quando avresti voluto scrivere poesie o studiare Meccanica razionale.

Venditti è la Roma sognata da tutto il resto d’Italia – “Bomba o non bomba noi arriveremo a Roma” – ma al tempo stesso la Roma di quelli che ci stanno e vorrebbero andarsene. “Vivere a Roma è sempre un problema soprattutto se ti viene un’idea”: Stukas sembra la risposta della Roma degli anni Ottanta a “Morire per delle idee” di De André, del decennio precedente. Non avere una casa alle dieci di sera, ma averci un’idea, a Roma negli anni Ottanta è un problema, ma anche a Milano, nel 2021. Eppure Venditti è sempre stato un inguaribile ottimista, e senza niente si canta e si balla e “siamo grandi farfalle” ancora capaci di volare e si invoca un aiuto che non si sa da dove possa arrivare – che infatti non è arrivato e non sta arrivando – e allora ci si deve aiutare da soli e magari amarsi per sentire di meno quella cesura a volte disperata e insanabile.
Venditti è una colonna della cultura pop del nostro Paese, una voce ricca e dalle forme molteplici e disparate, un grande musicista – cosa di cui subito si accorse il suo primo produttore Vincenzo Micocci – dall’incredibile capacità vocale, unica nel suo genere. Le canzoni di Venditti sono inni generazionali che pur essendo legati a un luogo e a un’epoca ben precisa si fanno voce assoluta di una stagione dell’esistenza e il suo “Qui” – che sia Roma o Modena o una qualsiasi strada tra la Capitale e Milano – diventa il qui di tutti noi, una giovinezza che ha ben poco a vedere con i dati anagrafici, ma è una condizione del cuore.

L’occasione di cantare le sue canzoni in pubblico arriva verso la fine degli anni Sessanta, sono i tempi del Folkstudio in via Garibaldi, realtà di riferimento musicale romana dove ha suonato anche Bob Dylan. E infatti la prima volta che Venditti ci mette piede, come racconta nel suo libro L’importante è che tu sia infelice (frase che gli ripeteva sempre sua madre, professoressa di latino e greco), ci trova De Gregori che alterna suoi brani a cover tradotte di Leonard Cohen e Bob Dylan. Venditti da giovane assomigliava a un mix tra il filosofo Manfredo Tafuri, il poeta Allen Ginsberg e il mio amico Bernie, e a quanto pare girava sempre in montgomery, come tanti all’epoca, tra cui mio padre. “Mi presentarono Giancarlo Cesaroni”, racconta Venditti, “[…] grande boss, diviso fra sigaro, Ballantine’s e corse dei cavalli. A fare i provini c’era la fila, decideva lui a insindacabile giudizio. In un angolo addossato al muro, malmesso e di schiena al pubblico, c’era un pianoforte che veniva usato solo in caso di jazz. Quasi non esisteva come strumento nell’immaginario collettivo”. Questa scena fa subito pensare al finale di Inside Llewyn Davis, il film dei fratelli Coen ambientato a New York; a Venditti le cose però vanno diversamente: suona allora “Sora Rosa”, “Roma capoccia” e “Viva Mao” – canzoni che aveva scritto intorno ai quattordici anni – e Cesaroni laconico gli dice: “Puoi venire domenica”. Lo spazio domenicale cominciava dopo pranzo e finiva quando “I Giovani del Folk(studio)”, De Gregori, Giorgio Lo Cascio ed Ernesto Bassignano – i quattro ragazzi con la chitarra e il pianoforte sulla spalla di “Notte prima degli esami” –, decidevano di far girare le chiavi nella serratura.

L’8 marzo del 1978, il giorno del suo compleanno (una settimana prima del rapimento di Aldo Moro), esce Sotto il segno dei pesci, un album che è un vero e proprio manifesto politico. Il disco – prodotto per la Philips da Michelangelo Romano (che aveva già lavorato con Roberto Vecchioni) – segna il destino della carriera dell’artista, nonché della storia musicale italiana, raggiungendo il primo posto nelle classifiche sia dei 33 che dei 45 giri. Pur uscendo negli anni di piombo raccoglie l’eredità culturale del ‘68. I pesci, l’ultimo dei segni zodiacali, diventano simbolo di una rinascita sociale e generazionale: sono un segno fantasioso, geniale, sognatore, naturalmente portato all’amore; hanno una forte sensibilità che li porta a vivere in maniera intensa e a essere messi profondamente alla prova dalle circostanze negative della vita. Chi nasce sotto questa costellazione si dice abbia una personalità molto empatica, che gli permette di comprendere gli altri e di entrare in contatto con i loro stati d’animo, con spirito di sacrificio e abnegazione nei confronti delle giuste cause. È una società con queste caratteristiche che si e ci augurava Venditti.
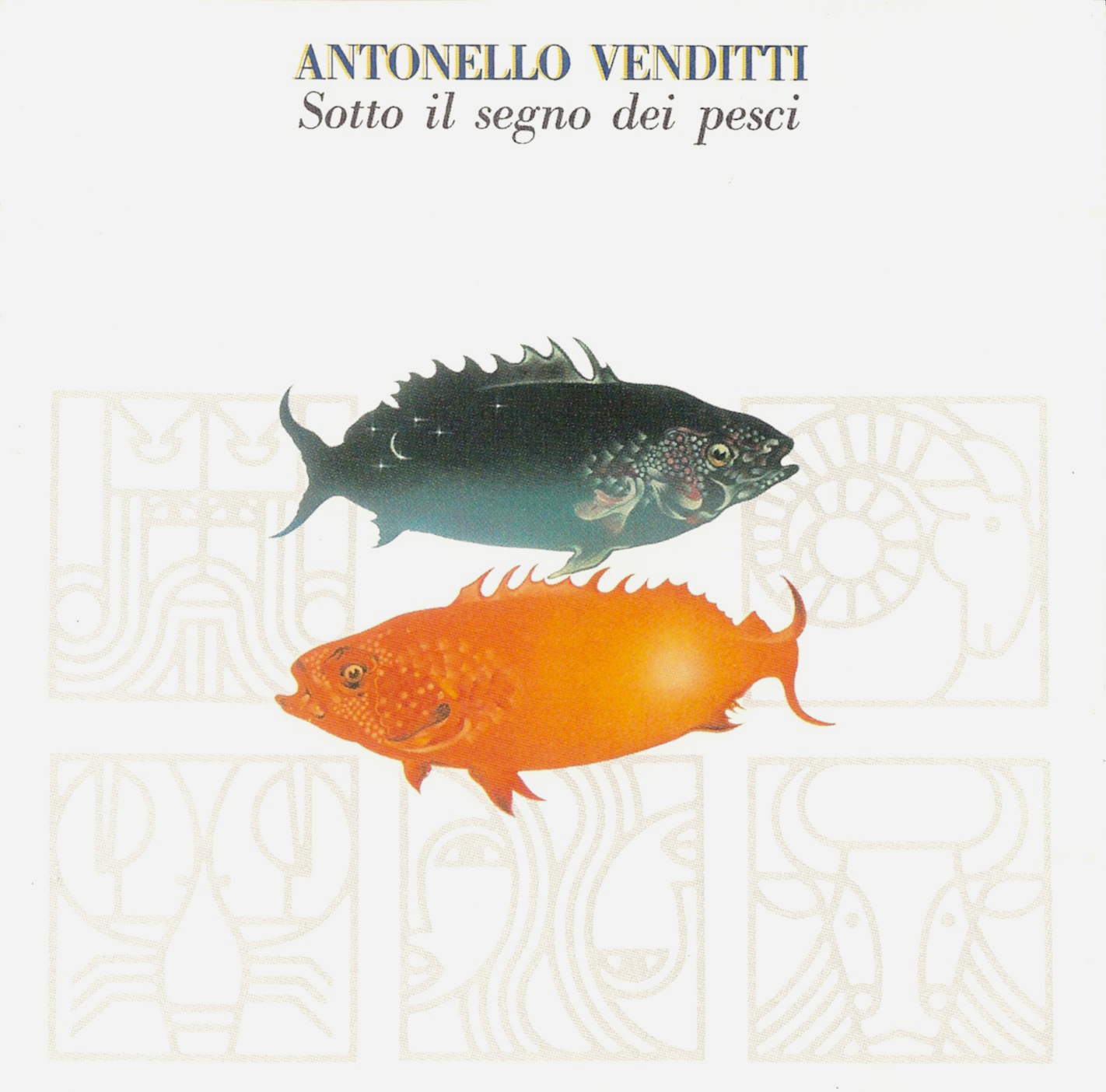
“Tutto quel che voglio, pensavo, è solamente amore / ed unità per noi che meritiamo un’altra vita / più giusta e libera se vuoi / nata sotto il segno dei pesci” è un vero e proprio inno generazionale che ci racconta in modo specifico la storia di Marina, Giovanni e tutti gli altri ragazzi del Movimento Studentesco. Esseri umani che non si rassegnano e vogliono e chiedono di più, che credono nella musica intesa come metafora di aggregazione corale, di unica voce che si leva. Il punto di forza dei testi di Venditti è proprio questa epica sociale che si incarna in una realtà precisa, che invece di distrarre si fa veicolo di condivisione empatica e valoriale. Ancora una volta la Storia si declina nell’esperienza intima dei singoli, mescolandosi nella memoria collettiva: Ti ricordi quella strada / Eravamo io e te / E la gente che correva / E gridava insieme a noi”.

Sembra davvero che per Venditti l’unico strumento possibile di catarsi dell’individuo, in una società di cui non si sente parte, marcia, bacata, fondata sull’utile, che attacca, critica e denuncia, sia l’amore (“Annamo via, tenemose pe’ mano / C’è solo questo de vero pe’ chi spera”). La prima vera canzone d’amore di Venditti però è “Le tue mani su di me”, inserita in Le cose della vita (1973), cantata poi da Patty Pravo. Parla con una tenerezza infinita dell’amore ai tempi del Movimento Studentesco, la scoperta dell’altro (basta aprire una finestra per capire un’altra verità), del corpo come corpo sociale, dell’amore inteso come forza di coesione della collettività e dell’impossibilità di credere a un amore calcificato, svuotato di significato dagli obblighi e dalle pressioni sociali. L’amore è qui ed ora, sono le tue mani che mi toccano, un momento sfilato al flusso dei grandi eventi della storia, l’amore è qualcosa di immenso ed effimero destinato a rompersi. Per Venditti l’amore è un prisma attraverso cui guardare e raccontare il mondo. Uno degli esempi più lampanti è “Lilly”, la canzone italiana più struggente mai scritta sul tema della dipendenza da eroina. Venditti nel brano riesce a parlare con una forma sempre lucida e precisa della devastazione dovuta alla dipendenza. Lo fa come un ragazzo che fissa il baratro senza inutili retoriche, in tutto il suo orrore, e ancora una volta l’unica cosa che gli resta sono i sentimenti, l’affetto, la relazione profonda con gli altri.

Le canzoni di Antonello Venditti sono sempre state impegnate e hanno affrontato temi sociali e politici di fondamentale importanza, legati in particolare ai diritti e alle battaglie di chi non ha voce, coloro che una volta facevano parte di quel proletariato urbano che oggi fingiamo non esista. Spaziano dalla corruzione all’emigrazione, dal diritto alla casa, passando per la difesa ambientale fino alle battaglie femministe e per la rivoluzione sessuale, con un’idea d’amore sempre libero e di volta in volta declinato sull’esistenza delle persone che lo vivono. Con “Sara” fu il primo a toccare il tema dell’aborto con una canzone, a poche settimane dal referendum; e poi c’è “Giulia”, in cui affronta il tema della bisessualità e dell’amore saffico raccontando una donna nuova, libera, alternativa, diversa dal canone della figura che solitamente veniva cantata; si passa poi per “Donna in Bottiglia”, che inizia con questi versi: “Se vuoi dire di sì, di’ sì / Se vuoi dire di no, di’ no”, concetto che in tanti fanno ancora fatica a capire; passando per “Ora che sono pioggia”, fino a “Il treno delle sette”, che racconta il sogno di una madre operaia proiettato sulla cultura della figlia.
Altre canzoni di denuncia sono “Canzone per Seveso” – sul disastro ambientale causato dall’ICMESA nel 1976, con la fuga di una nube tossica di diossina –; “Chen il cinese”; “E li ponti so’ soli”, sul tema dell’emigrazione e dell’emarginazione sociale; “Giulio Cesare”; “Campo de’ fiori”; “Lontana è Milano”, “Modena”, “Lo stambecco ferito” (1975), che finisce per intersecarsi – almeno nel mio immaginario – con “L’era del cinghiale bianco” (1979) di Franco Battiato e “Coda di lupo” (1978) di De André. La canzone si ispira alla figura di Felice Riva, che per Venditti si fa simbolo della violenza connaturata del sistema politico e dell’ingiustizia sociale. Lo stambecco rappresenta allora il ricco industriale che ammazza la moglie, non paga i dipendenti e poi tenta la fuga in Svizzera solo con il suo denaro, mentre il bracconiere, che lo vuole ammazzare, è il proletario che chiede disperatamente giustizia. Visto che nessuno gliela dà allora se la va a cercare, come un cacciatore, al freddo, sul confine, ma essendo così diverso dallo sfruttatore che vuole ammazzare non è capace di fare male a nessuno. “Uno sparo riecheggia tremante per tutta la valle. ‘Polizia uccide cacciatore di frodo sulla terra comasca’. Lo stambecco felice e ubriaco vola lontano e la nebbia delusa e sconfitta se ne va… piano, piano”: questi gli ultimi versi della ballata che si conclude poi con una delle code di pianoforte più indimenticabili della nostra musica.

Era come se all’epoca non si avesse paura di fallire, e questo permetteva di vivere e rischiare tutto. I vinti non pretendevano di fingersi vincenti, sapevano di essere in maggiore o minor misura comunque dei combattenti, e questo bastava a far sì che il mondo ne riconoscesse il valore. Una volta ci si poteva ancora prendere in giro e fare la stessa cosa con la realtà quando le cose si mettevano male, cosa che accadeva e accade spesso, e non a caso la madre di Venditti gli “dava sempre 4, anche se gli voleva bene”. In questo verso amaro c’è tutta la prospettiva pedagogica ed esistenziale delle generazioni venute prima di noi: i meriti non hanno nulla a che fare con l’affetto. La nostra generazione invece ha iscritto nel profondo che se non eccellerà non sarà accettata, abbiamo instaurato una sorta di meritocrazia dell’amore che ci ha distrutti. I “buchi nel cervello” portati dal benessere sembrano essere diventati sempre più grandi e aver raggiunto anche il nostro cuore. Eppure, le canzoni di Venditti, fin dalle prime battute ci ricordano che si può sempre fare qualcosa, e senza retoriche sforzate e false ideologie ci risvegliano e tornano ancora a farci cantare, ricordandoci che la musica non è solo intrattenimento.
