
In molti Paesi del mondo si parla di interventi economici che possano attenuare le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, accentuate negli ultimi mesi dalla crisi globale scatenata dalla pandemia. Dagli Stati Uniti Janet Yellen, segretaria del Tesoro dell’amministrazione Biden, ha aperto alla proposta di una tassa globale sulle multinazionali da presentare alla prossima riunione del G20, che quest’anno sarà a presidenza italiana. Intanto, istituzioni come il Fondo monetario internazionale e l’Ocse hanno chiarito senza mezzi termini che l’unico modo per alleviare la crisi economica è aumentare le tasse sui patrimoni più alti. In Italia, però, il tema sembra quasi assente nel dibattito pubblico e politico. La parola “diseguaglianze” compare appena 7 volte nelle circa 270 pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inviato a Bruxelles lo scorso 30 aprile, contenente i dettagli sulla gestione da parte del governo italiano dei 191,5 miliardi di euro del Recovery Fund europeo. Fino all’ultimissima bozza il piano prevedeva il “rafforzamento della tutela del lavoro attraverso l’introduzione di un salario minimo legale per i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva nazionale”, salvo poi eliminare questa parte del testo nella versione definitiva consegnata al Parlamento pochi giorni dopo. Per l’ennesima volta l’Italia ha rimandato l’intervento sulla retribuzione dei lavoratori, nonostante l’introduzione di una misura simile sia sempre più urgente.
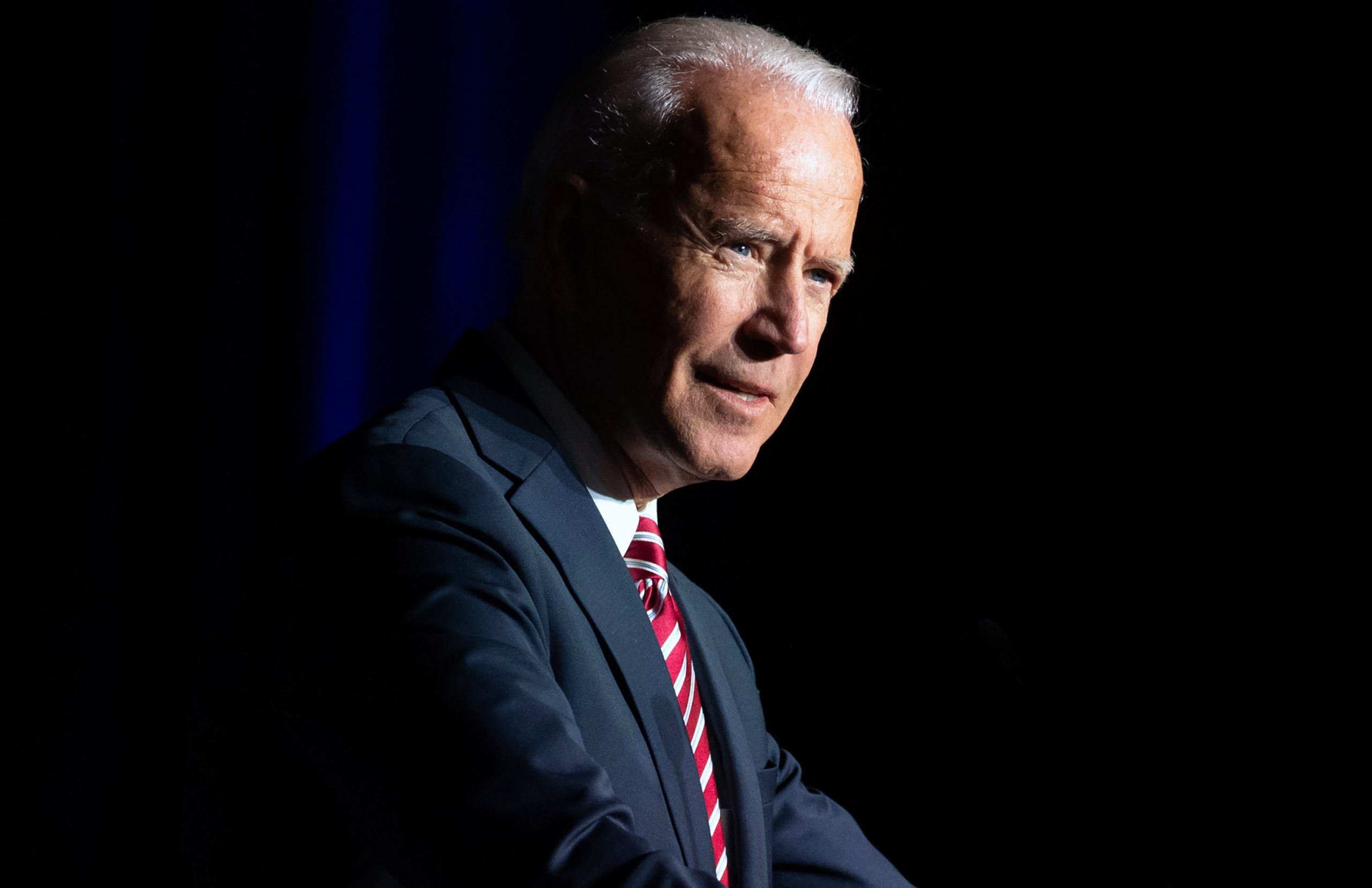
Secondo la confederazione dei sindacati europei, in Italia il 12,2% della forza lavoro si trova in condizioni di povertà lavorativa, cioè non riesce ad affrontare le spese per i beni di sussistenza pur lavorando e percependo un salario. Nel Global Wage Report 2020-21 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha ricordato che sebbene nella maggioranza dei Paesi del G20 si registrino tendenze positive, l’Italia, insieme a Giappone e Regno Unito, registra una preoccupante contrazione dei salari reali. Nei primi 6 mesi del 2020, infatti, la spesa salariale in Italia è diminuita del 7,6%, in gran parte per via della crescita della disoccupazione, risultato che ci classifica tra i peggiori dieci tra gli Stati Ue. Il monte salariale è diminuito soprattutto per le dipendenti donne (-9,7%), mentre per gli uomini si è registrata una perdita più lieve. Nello stesso report l’Oil ha ribadito l’utilità del salario minimo orario per correggere gli errori nella distribuzione della ricchezza e per ridurre le disuguaglianze tra i salariati, a beneficio delle fasce di lavoratori più deboli, ossia le donne vittime del gender pay gap e i giovani, che spesso sono precari e mal retribuiti.

Il nostro Paese fa parte di un ristretto gruppo di Stati membri dell’Unione europea privi di una legge sul salario minimo insieme ad Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia. Nel resto dell’Europa il salario minimo lordo varia dai 2142 euro al mese del Lussemburgo ai 312 della Bulgaria. Il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata a dignitosa, sancito dall’art. 36 della nostra Costituzione, è stato fino a oggi tutelato attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale di categoria, che attualmente interessa 73 settori lavorativi. Tuttavia la copertura concreta di questo strumento, vale a dire il numero di lavoratori che tutela, è dubbia. Rimane infatti la possibilità per le aziende di non aderire alla contrattazione collettiva e continuare a fissare autonomamente le retribuzioni dei propri dipendenti. Più volte il tema è stato preso in considerazione dalla politica, dal Jobs Act di Renzi al Decreto dignità del M5S, passando per diverse proposte depositate da singoli parlamentari, ma non si è mai riusciti ad arrivare all’approvazione di una legge sul salario orario minimo. Tra le ultime proposte discusse e poi abbandonate, con il sopraggiungere della crisi di governo, c’è il Ddl Catalfo presentato nel luglio 2018, che prevedeva l’istituzione di un salario orario legale minimo di 9 euro al lordo degli oneri contributivi. Secondo l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), tale misura avrebbe coinvolto il 21,2% dei lavoratori dipendenti in Italia, comportando un costo per le imprese di circa 7 miliardi di euro. Tra i beneficiari di un salario minimo di 9 euro l’ora ci sarebbero stati 1,9 milioni di dipendenti a tempo pieno, vale a dire il 18,4% del totale dei lavoratori full time. Le rilevazioni dell’Istat del giugno 2019 confermano l’utilità di una misura simile per tutelare le fasce più deboli della popolazione, dato che i rapporti di lavoro con retribuzione oraria inferiore ai 9 euro lordi sono circa il 20% del totale e si concentrano tra gli apprendisti (59,5%) e gli operai (26,2%), nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (27,1%), in quelle artistiche e sportive, tra le donne (23,1%) e tra i giovani sotto i 29 anni (32,6%).

Un interessante caso a cui l’Italia potrebbe guardare per l’introduzione di un salario minimo legale è quello tedesco. Nel 2015 la Germania è infatti passata dalla contrattazione collettiva, che lasciava scoperti il 40% dei lavoratori subordinati, a una legge sulla retribuzione oraria minima in origine fissata a 8,5 euro, con l’obiettivo di aggiornarla ogni due anni. Nel 2018 il salario orario minimo è stato così portato a 8,84 euro all’ora (circa 1.498 euro al mese) e nel 2019 a 9,19 euro. Con un piano di lungo termine il governo tedesco prevede di arrivare a un salario orario minimo di 10,5 euro l’ora nel 2022. Prima dell’introduzione della legge l’11,3% dei lavoratori tedeschi erano pagati meno di 8,5 euro l’ora, e nella stragrande maggioranza si trattava di donne e risorse poco qualificate, spesso impiegate in piccole aziende o con contratti part-time. Aumentando lo stipendio dei lavoratori meno retribuiti, la legge tedesca ha avuto come effetto la riduzione delle disparità ed è riuscita a livellare i salari dei vari land, senza però portare alla crescita della disoccupazione preventivata dai critici di questa normativa. Il caso tedesco è anche indicativo dell’importanza dello Stato nel monitorare e intervenire sul comportamento dei datori di lavoro, che in Germania hanno a volte interrotto la progressione salariale di anzianità e nel 6,1% dei casi hanno tentato di eliminare i benefici monetari aggiuntivi al salario dei dipendenti.

Di fronte alla sempre più preoccupante povertà dei lavoratori salariati, anche la Commissione europea ha elaborato di recente una direttiva per un salario minimo europeo. Va precisato però che l’Unione europea non ha autorità in materia salariale, infatti l’art 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea chiarisce che questa non può intervenire per regolare la retribuzione tra i vari Stati membri. Anche per questo, quella della Commissione europea è una soluzione abbastanza temperata, basata proprio sullo strumento della contrattazione collettiva nazionale già usato in Italia. Durante i lavori la Commissione ha però notato che i dati italiani riguardo i contratti collettivi nazionali sono di fatto inattendibili, invitando in ultima analisi tutti gli Stati membri che si regolano grazie ai contratti collettivi a verificare l’adeguatezza dei salari. A tal proposito l’Ue ha indicato criteri precisi per la determinazione del salario minimo, quali il 60% del salario lordo mediano o il 50% del salario lordo medio. Basandosi su queste indicazioni, la stessa proposta del governo Draghi, poi depennata dal documento finale del Pnrr, non sarebbe comunque stata sufficiente, andando a intervenire esclusivamente sulle categorie prive di un contratto collettivo nazionale, senza preoccuparsi che alcuni di questi contratti prevedono paghe che non possono ritenersi dignitose, come per esempio quello relativo ai Servizi fiduciari (tra cui vigilantes e steward), che per le qualifiche più basse prevede un salario orario di 4,6 euro.

Fino a oggi a opporsi a una legge sul salario minimo in Italia è stata non solo Confindustria, che sostiene che aumentando il costo del lavoro si finirebbe per provocare anche un’impennata dei licenziamenti o comunque una tendenza alla riduzione dell’orario lavorativo, ma anche gli stessi sindacati, che temono di perdere il loro potere contrattuale. Rimane però l’evidenza che questa misura, se applicata ad ampio raggio e accompagnata da un’efficace opera di contrasto al lavoro in nero, finirebbe per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e aumentare la loro capacità di acquisto, con una ricaduta positiva per l’intero sistema economico. Il punto più importante della questione rimane però la capacità del salario minimo legale di intervenire sulle discriminazioni lavorative, aiutando donne e giovani a raggiungere un’indipendenza economica che in questo momento è negata nei fatti alla maggioranza di loro. In un Paese che da anni è alle prese con l’inverno demografico e la disoccupazione giovanile, e in cui le donne continuano a subire una discriminazione quotidiana sul mercato del lavoro, rimandare di nuovo la regolamentazione salariale significa rimandare per l’ennesima volta la tutela delle categorie di lavoratori più deboli. Un’ingiustizia sostenuta dalla mancanza di azione di una classe dirigente incapace di capire che questa non pesa solo sui diretti interessati, ma nel lungo periodo danneggia l’intero Paese.
