
Qualche giorno fa ho letto la notizia della consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle che ha detto che “guardare vecchi film è un feticismo”, e la prima cosa che ho fatto è stato andare a leggere il suo curriculum per capire che tipo di formazione avesse. Gemma Guerrini, vicepresidente vicaria della commissione Cultura in Campidoglio, è laureata in Lettere e ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Paleografia della Sapienza. Non era proprio quello che mi aspettavo da una persona in grado di fare un’affermazione simile. Leggendo con attenzione il post della consigliera trasteverina, mi sono resa conto che il suo ragionamento è solo un volo pindarico per screditare – che incredibile novità – un certo ambiente legato alla sinistra, che avrebbe usato le iniziative del Cinema America come strumento di propaganda: una declinazione moderna di panem et circenses, diciamo.


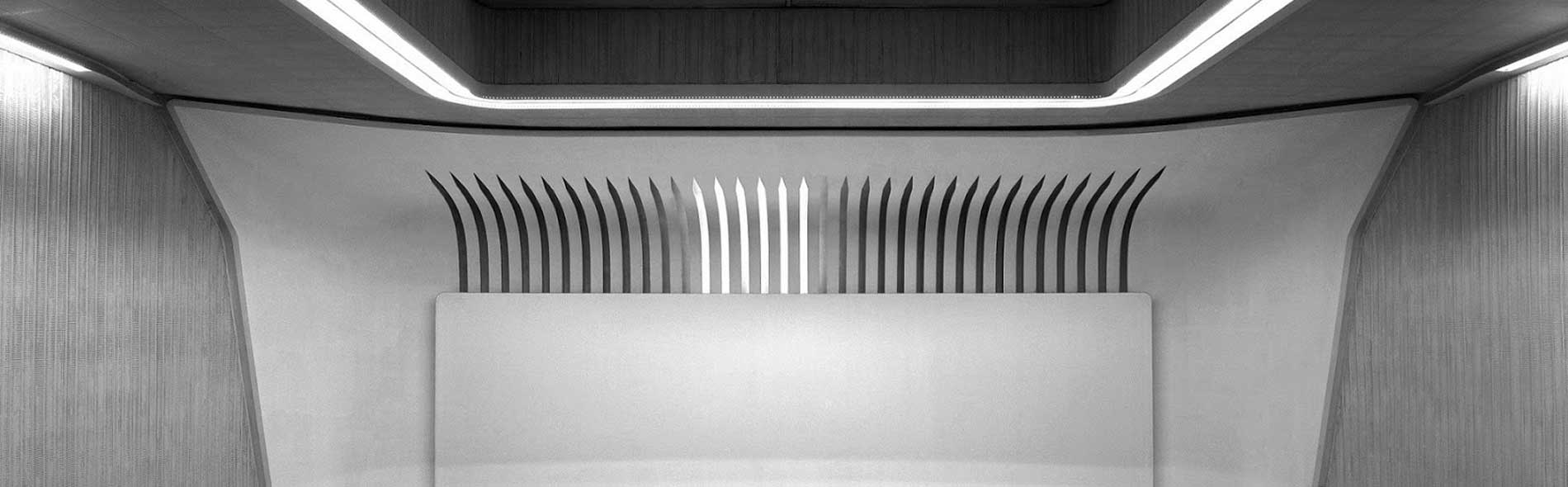

Voglio credere che la consigliera, a meno che non abbia rinnegato completamente il suo passato tra gli archivi dell’Istituto di Paleografia, abbia solo avuto l’infelice idea di spingere un po’ troppo oltre la sua verve pentastellata, finendo col ritrovarsi in quella scomoda posizione di chi non ha centrato il vaso. Al di là della vicenda del Cinema America – che è complessa e meriterebbe un’analisi a parte – la miopia di un’affermazione come “guardare vecchi film è un feticismo” mi lascia molti dubbi sulla consapevolezza storica di Gemma Guerrini, ma immagino che la sua sia stata solo un’uscita infelice. Perché guardare vecchi film, invece, non è affatto una “civilizzazione di stampo colonialista”. Anzi, direi proprio che è il contrario.

Da un po’ di anni a questa parte ho cominciato a sfruttare la pratica del binge-watching per dedicarmi a monografie di registi, in particolare di quelli italiani che hanno girato film tra gli anni ’60 e ’70. È una modalità di fruizione un po’ ossessiva, ma molto efficace. L’ultimo regista su cui mi sono concentrata è stato Dino Risi, e mentre mi districavo tra le sue numerose opere ho avvertito una strana sensazione di familiarità. A parte i film che già conoscevo, anche altri mi rievocavano immagini che avevo visto da qualche parte. Poi ci ho pensato bene e ho capito: mi ricordavano Wes Anderson.


Dai primi anni 2000 in poi, l’universo estetico cinematografico americano è stato conquistato da un regista texano che ha dato il via a un filone di immagini e suggestioni a cui siamo tutti ormai più che avvezzi. Wes Anderson ci ha regalato una scorta infinita di foto profilo, foto copertina, poster, sfondi del desktop e scale cromatiche da cui partire per i nostri videoclip di canzoni indie. Sapremmo distinguere un fotogramma di un film di Wes Anderson tra mille: inquadratura geometrica e speculare, colori forti e definiti, personaggi ben delineati prima di tutto da un punto di vista estetico, con accessori e indumenti che sono talmente caratteristici da prestarsi bene a costumi di carnevale. Chi non ha mai visto almeno una Margot Tenenbaum a qualche festa in maschera? È anche evidente che, tra gli obiettivi di Wes Anderson, oltre a favorire una cornice e un dipinto preciso di tutte le scene che rappresenta imprimendoci in testa esattamente il suo immaginario – tanto appunto da poterlo riprodurre con facilità – c’è quello di rimandare a un’atmosfera vintage, sia attraverso gli oggetti e i vestiti che usa, sia per i colori in stile filtro Amaro Instagram. Tra citazioni dirette e indirette, i film di Wes Anderson hanno un sacco di riferimenti al cinema d’autore, in particolare quello americano e francese – Nouvelle Vague e Orson Welles, per esempio.





Tra i tanti riferimenti che ho scovato nei suoi film però, ce n’è uno che mi sembra nessuno abbia mai notato – perlomeno, nessuno su internet. Sembrerà molto azzardato e anche ingenuo, ma se quando vedo Wes Anderson mi si accendono nella testa certi schemi precisi e definiti del suo modo di lavorare, è così strano che quando guardo certi film di Dino Risi se ne accendano di molto simili? È possibile che nessuno si sia mai accorto di quanto wesandersoniano sia il cinema (un certo cinema, ovvio) di Dino Risi? Forse però, considerate le epoche a cui appartengono e la famosa favola di Fedro sul lupo e l’agnello, dovrei dire piuttosto che è il cinema di Wes Anderson che a tratti diventa dinorisiano.



Del regista italiano si può parlare in due modi: o dicendo che ha rovinato il nostro cinema, affidandolo al degrado della commedia – che sarebbe poi sfociata nei filmetti con Banfi o nei cinepanettoni, ben lontani dai presupposti nobili del neorealismo – oppure dicendo che è uno dei registi che lo hanno consegnato con gloria ai posteri. Io, personalmente, mi sento più di appartenere alla seconda schiera, nonostante tenga conto di tutte le considerazioni storiche riguardo al tema dell’impegno sociale nel cinema: ci sono dei film di Dino Risi che a guardarli oggi mi fanno domandare come sia possibile che ci inebriamo dell’universo estetico di Wes Anderson e non facciamo lo stesso con il suo – tranne che con pochi casi isolati, tipo quello del Sorpasso che, bene o male, anche solo di passaggio, conosciamo un po’ tutti.






Quel fotogramma in bianco e nero di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant in macchina che fanno le corna è impresso nell’immaginario collettivo del cinema italiano anni ’60, ma è guardando altri film di Dino Risi un po’ meno conosciuti e più difficili da reperire che ho avuto l’epifania: inquadrature geometriche, carrellate repentine che terminano in close-up, personaggi pittoreschi, colori forti, scenografie curate nei dettagli che creano un’atmosfera carica e ben definita. Sembra di guardare proprio uno di quei film che si prestano alla perfezione a riutilizzi per scopi decorativi dei propri social. In nome del popolo italiano, con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman che interpretano rispettivamente un magistrato incorruttibile e un imprenditore disonesto e viveur che si fanno la guerra, è un ottimo esempio di come Risi abbia saputo creare scenari visivi perfettamente compatibili con l’esigenza estetica di chi ricerca questo tipo di gradevolezza nei film di Wes Anderson. Noi donne siamo fatte così, invece, film a episodi del 1971, vede Monica Vitti trasformarsi in dodici donne diverse: ognuno dei suoi personaggi ha un’immagine caratterizzata nei minimi dettagli per rimanere fissa in testa, complice ovviamente anche la bravura dell’attrice che li interpreta, ma anche fortemente supportata da tutte le atmosfere che si creano attorno a lei in ogni cambio di ruolo. I costumi, le ambientazioni, le scale cromatiche, la fotografia: non è esattamente quello che ci piace cercare nelle composizioni cinematografiche di Wes Anderson?







Ciò che mi ha sempre più o meno annoiato, o comunque lasciata insoddisfatta, dei film del regista di Moonrise Kingdom era l’impressione che non ci fosse un contenuto all’altezza della forma. Per quanto trovassi le trame sempre carine e ben fatte, il risultato finale continuava a lasciarmi addosso la sensazione che i suoi film fossero un’esperienza da fare molto più con gli occhi che con le orecchie. Con Dino Risi, invece – grazie ovviamente al lavoro di sceneggiatori come Age & Scarpelli – questo sentimento di incompletezza non mi ha mai nemmeno sfiorata. Trame come quella dell’episodio Alberta, leggera ma allo stesso tempo acuta e brillante, combinate con la bellezza delle loro immagini creano un mix che è esattamente quello che cerco in una commedia.

Il punto, dunque, non è mettere Dino Risi accanto a Wes Anderson e decretare un vincitore della competizione “chi fa le commedie più foto-profilizzabili del mondo”. Il punto, semmai, è proprio quello di smentire opinioni superficiali come quelle di chi sostiene che il vecchio cinema sia noioso, inutile, o – sempre per citare la consigliera Guerrini – un ridicolo feticismo da colonizzatori culturali. Se non avessi guardato i film di Dino Risi non mi sarei così tanto interrogata su quelli di Wes Anderson. Se non avessi dato spazio anche al passato non sarei mai arrivata a provare quel senso di soddisfazione che invece ho sentito alla fine di Noi donne siamo fatte così. Grazie al cielo esiste un bacino infinito di film italiani (e francesi, tedeschi, scandinavi, inglesi, americani) dal quale attingere nel momento in cui non ci si sente perfettamente soddisfatti del presente, che non levano per nulla spazio alla contemporaneità, ma semmai la accrescono, dandole una struttura più solida. Sennò, consigliera Gemma Guerrini, non mi spiego a cosa dovrebbe servire la storia.
