Una delle cose che mi ha sempre colpita della socialità milanese è la sfacciataggine con cui si chiede alle persone appena conosciute che lavoro fanno. Domande altrove considerate più normali come “di dove sei”, “come conosci l’amico in comune” lasciano il posto a questioni atte a valutare a spanne la tua RAL o un’eventuale collaborazione. Per quasi dieci anni, però, alla risposta “lavoro da VICE”, mi è sembrato di leggere in molti interlocutori un misto di curiosità e rispetto che andava oltre la morbosità sui soldi. Il mito intorno al magazine, soprattutto per la generazione dei Millennial, era molto vivo. E chi lo conosceva si aspettava racconti di party continui, droghe in ufficio e interviste a personaggi improbabili. Dopo qualche aneddoto divertente di rapper famosi e situazioni bizzarre, finivo però inevitabilmente per descrivere la realtà quotidiana: una redazione normale, spesso persino troppo silenziosa, anche mentre produceva articoli e video pazzi. A volte, questo scenario generava quasi delusione, come se il dietro le quinte non fosse all’altezza della leggenda.

Per me, cresciuta nella provincia abruzzese e formata in un liceo classico che ancora si illudeva di “forgiare la futura classe dirigente del Paese”, l’incontro con VICE era stato un colpo di fulmine tardivo. Era intorno al 2012, stavo studiando in Germania quando su Facebook mi era apparsa la sponsorizzata di un articolo in tedesco sul sesso anale. Il logo del magazine mi diceva qualcosa – probabilmente lo avevo incrociato in qualche negozio di streetwear che non potevo permettermi – ma di quel pezzo mi avevano colpito più di tutto due cose: lo stile di scrittura fresco e innovativo e la sua utilità. Un articolo sul sesso che sembrava scritto da Chuck Palahniuk: sporco, tendente al letterario e allo stesso tempo dettagliato. Ed è proprio questa miscela di libertà e provocazione che VICE Is Broke, il documentario di Eddie Huang ora disponibile su MUBI, cerca di ritrarre e in un certo senso di rimpiangere. Una specie di memoir che racconta la parabola ascendente e discendente di VICE Media, da magazine punk nato a Montreal a fine anni Novanta a media empire multimiliardario, fino al fallimento e alla bancarotta. Huang, già volto noto di Huang’s World sul canale televisivo di VICE, Viceland, entra nel cuore della storia con un approccio personale, intervistando i protagonisti di allora e usando la propria esperienza da insider come lente critica al grido di “non doveva finire così”.

Il film si apre con una vecchia intervista di Huang a Shane Smith, uno dei fondatori del magazine e successivo magnate dell’impero. Smith, di fronte a una bistecca, gli racconta con entusiasmo la Brooklyn dei primi Duemila, la vita cheap, interessante e fuori dagli schemi che la animavano quando VICE era ancora un magazine con sede in uno scantinato. Una intro che da un lato introduce uno dei protagonisti della storia – che si rivelerà in seguito il cattivo – e dall’altro pone un parallelismo perfetto tra la gentrificazione del quartiere newyorkese e la parabola della media company. Dalle birre a pochi euro all’invasione di birrerie artigianali gestite da barbuti, da un magazine underground a un impero che sponsorizzava le sigarette elettroniche: in entrambi i casi, la coolness è lentamente evaporata con l’arrivo dei capitali.
Huang ricostruisce poi il periodo in cui il magazine era un incubatore creativo: rubriche sul rap, libertà totale, provocazioni dentro e fuori dalla pagina, niente freni su temi come sesso e droga, storie di marginalità raccontate senza censura e con uno stile curato e riconoscibile – da hyperintelligent valley girl, dice lo storico editor-in-chief Jessee Pearson. Le rubriche leggendarie come Dos e don’ts, le foto abiliste e le definizioni nemmeno troppo velatamente sessiste che popolavano il magazine sono oggi impensabili, ma all’epoca rappresentavano qualcosa per qualcuno, il modo di vedere la vita di un gruppo sociale in ascesa, composto per lo più da bianchi colti e relativamente benestanti. E non importava che quel modo gonzo di fare giornalismo avesse in un certo senso ucciso il giornalismo professionale, come alcuni ex collaboratori giustamente sostengono nel film: i contenuti piacevano, interessavano, ma soprattutto vendevano.
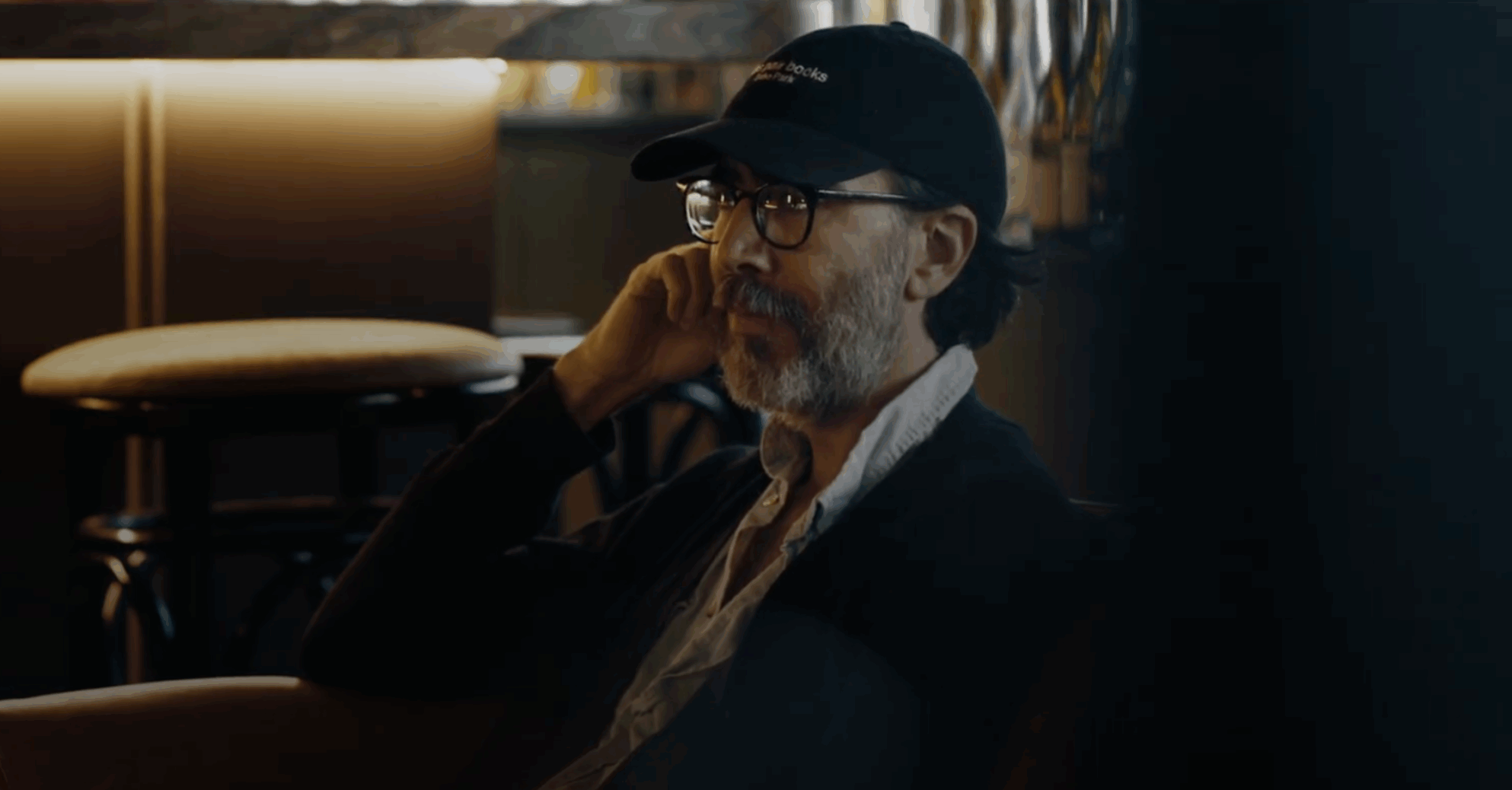
Uno dei meriti del documentario, infatti, è mostrare il contrasto tra la spinta ideale di un progetto editoriale e il degrado che lo ha travolto negli anni. C’è una vena di critica feroce e di struggente nostalgia tra i contributor intervistati, consapevoli delle promesse tradite verso i principi e la community. Con il tempo, ricostruisce Huang, il culto del magazine cartaceo ha lasciato il posto ai documentari in cui aspiranti giornalisti e videomaker allo sbaraglio venivano inviati in posti esotici e pericolosi, ritraendo scene in cui persone di altre culture consumavano droga e usavano armi. Il racconto giornalistico freddo e distaccato era stato sostituito da un approfondimento immersivo, quasi antropologico, ma allo stesso tempo sensazionalistico. Dopo un reportage in Jamaica non abbastanza adrenalinico per gli standard del canale, racconta Huang, era stato strigliato da un dirigente e successivamente sospeso: “dove sono le droghe? dove sono le armi?”, si era sentito urlare contro.
Alcuni di questi video, con un approccio nemmeno troppo velatamente colonialista, sono diventati meme e culto – come quello sul sesso con gli asini in Colombia – settando uno standard ancora attuale per decine di altri outlet e youtuber. Per quanto VICE avesse avuto il merito di creare questa Weltanschauung giornalistica universalmente riconosciuta – con tutti i limiti e le problematicità che all’epoca non sembravano emergere – presto i comportamenti tossici e sessisti tra colleghi, le rivalità, i brand e le holding si sono intromessi, ponendo fine una magia fondata già su un equilibrio precario. Da punto di riferimento dell’underground occidentale, VICE è diventata una fabbrica di soldi, arrivando a curare progetti-ombra di dubbia moralità per l’Arabia Saudita e per le multinazionali delle sigarette.

Per quanto il documentario si concentri sulla realtà statunitense, non menzionando le decine di sedi di VICE in tutto il mondo, i pattern rappresentati possono essere facilmente riscontrati anche nella realtà italiana ed europea. La lenta ma inesorabile trasformazione della redazione in un’agenzia di comunicazione ha riguardato tutte le sedi, con licenziamenti in tronco e limitazioni sul piano editoriale. Per non incorrere in rischi di sorta, i contenuti – per quanto ancora di valore – sono diventati via via più seriosi e standardizzati, e l’anima punk iniziale si è liquefatta sotto il peso della sostenibilità economica dell’azienda e della paura di infastidire i brand. VICE, valutata pochi anni prima 5,7 miliardi di dollari, nel maggio 2023 ha fatto richiesta di bancarotta, licenziando migliaia di dipendenti – tra cui me. Un filo rosso del documentario, che emerge verso la fine, è un’indagine aperta sulle cause di questo fallimento, costato a Huang decine di migliaia di dollari di arretrati: l’impero è caduto per avidità, per cattiva gestione o per cambiamenti strutturali nel giornalismo e nelle generazioni?
Sul motivo di questo declino, che dall’interno era percettibile da molto prima della bancarotta ufficiale, mi interrogo da anni. La risposta che mi sono data, da umile autrice estranea alle dinamiche aziendali, è che la fine di VICE è anche l’emblema di un banale cambiamento generazionale: con il passare degli anni, l’approccio Millennial alla vita era semplicemente passato di moda. Ciò che Huang descrive nel documentario – e che io ho vissuto da vicino – incarna la parabola discendente di una generazione e del suo modo di vedere la vita. VICE era il megafono, la bibbia dei Millennial: giovani privilegiati che si sentivano speciali e pronti a scuotere il mondo con il loro modo di raccontarlo senza peli sulla lingua. Ogni articolo, ogni foto, ogni video rifletteva questo immaginario, la voglia di trasgredire senza davvero tradire la propria comfort zone. Ma con il tempo è arrivata la Gen Z: più social, più attenta alle diverse sensibilità, meno sedotta da una trasgressione fatta di fisting e funghi allucinogeni – e, soprattutto, che ha coniato un dispregiativo preciso per definire il mondo Millennial: cringe.

La centralità culturale dei nati tra gli anni Ottanta e Novanta, com’è naturale che sia, è evaporata e il tentativo di trasformare VICE in un brand di culto per la generazione successiva è miseramente fallito. Nella realtà quotidiana di una redazione di Millennial, il compito di creare contenuti considerati cool da persone con dieci anni in meno era semplicemente frustrante. In questo senso, il documentario di Huang non racconta solo la caduta di VICE, ma anche il declino di una generazione che ha dominato l’immaginario per un paio di decenni e che oggi, arrivata alla mezza età, si confronta con un mondo che corre più veloce di quanto potesse prevedere. “La coolness, qualsiasi cosa sia, non è una risorsa rinnovabile, puoi venderla una volta sola”, dice Jesse Pearson ai microfoni di Huang. Ed è questa, probabilmente, la frase più saggia e riassuntiva dell’epopea di VICE Media e delle migliaia di persone che, nel bene e nel male, hanno contribuito alla sua grandezza. In attesa di un ritorno dal gusto vintage in stile Oasis, che comunque non è da escludere, bisogna ammettere la sconfitta.
“VICE is Broke” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.
Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom