
All’ultimo festival di Cannes risultano in concorso soltanto tre film firmati da “registi donne”: Alice Rohrwacher, Eva Husson e Nadine Labaki. I rimanenti diciotto portano nomi maschili. La situazione ha dato il via alle solite polemiche. Dove sono le donne? Esiste discriminazione artistica nei confronti delle femmine? Che fine hanno fatto i numerosi film, in teoria pronti, realizzati da personaggi di assodato spessore? Nessuna risposta. Una delle grandi assenti è Claire Denis, ad esempio, veterana del cinema d’autore nota agli appassionati di tutto il mondo e frequente ospite dei festival internazionali, da Berlino a Venezia. Denis ha in ballo un nuovo film, High Life, un thriller fantascientifico ad alto budget con un attore celebre nel ruolo del protagonista. Eppure nulla. Denis, da parte sua, ha fatto sapere che Cannes non le interessa affatto, che non desidera essere assimilata al rango delle “registi donne” e che lei, a quel festival in particolare, non dev’essere comunque mai piaciuta molto se la sua ultima pellicola in concorso, Chocolat, risale al 1988.



Chiamato a rispondere delle sue decisioni, il direttore del festival Thierry Fremaux ha dichiarato a Variety di non credere affatto alle quote rosa e ha aggiunto che il passaggio a Cannes può addirittura danneggiare una donna non abbastanza matura: “Ricordate cos’è successo a Valerie Donzelli nel 2015?”. Fremaux si dimentica però di dire che Donzelli era, ed è, un’attrice e regista molto nota in patria grazie all’enorme successo critico e commerciale di un film precedente, La guerra è dichiarata, scelto dalla Francia per gareggiare agli Oscar nella categoria “miglior film straniero”: è ovvio che il suo produttore, nel momento in cui Donzelli aveva pronto un nuovo film molto ambizioso, Marguerite et Julien, le abbia tentate tutte pur di piazzarlo nel calendario di un festival importante. E sì, Marguerite a Cannes ha subito un linciaggio degno di miglior causa, ma al limite la colpa andrebbe data al festival che l’ha messo in concorso, non alla regista che non ha forse saputo presentare il proprio materiale in modo da renderlo inattaccabile.

Il che ci porta dritti al cuore del problema.
Da un lato, la causa delle “registi donne” non interessa assolutamente a nessuno, fatte salve le dirette interessate. Fate pace con questa cosa. Il sesso di nascita in questo settore è totalmente irrilevante, fatte salve le rare occasioni in cui si fa spazio a una “regista donna” per baloccarsi con la diversità. Come se il 50% della popolazione mondiale rappresentasse uno 0,01% risalente a una minoranza etnica quasi debellata da un virus letale. Dall’altro, però, la selezione dei grandi festival obbedisce a regole che con il cinema o la qualità non hanno nulla a che spartire.
Ho lavorato per un anno nel comitato di selezione di quello che allora era uno dei tre più grandi festival europei. Me ne sono andata dopo una stagione, disgustata dalle manovre a cui avevo assistito e dall’aria spesso da caserma che si respirava.
Il concorso di un festival, in teoria, rappresenta il meglio del cinema disponibile in tutto il mondo nell’anno in cui si svolge. In concreto, a un festival vengono sottoposti tra i 200 e i 500 titoli e la scelta ubbidisce a logiche molto diverse.
Tra le persone chiamate a decidere cosa sia il grande cinema c’è, in primo luogo, il direttore artistico, colui che firma il programma, lo presenta ai giornalisti e poi introduce con qualche parola il film alla proiezione ufficiale per il pubblico. Il direttore è di solito assistito da una squadra di selezionatori, o programmer, critici più o meno di vaglia che danno la propria opinione sui film, a cui spesso si aggiungono i consulenti esterni responsabili di una specifica parte del mondo: Venezia aveva un esperto assegnato alla macro-area “Sud-Est asiatico” e uno ai Paesi Bassi. In teoria, questi “specialisti” dovrebbero avere un’ottima visione d’insieme rispetto alle produzioni di certi Stati, e magari tenere vivi i rapporti personali con registi e produttori locali. In pratica, nei festival poco democratici, come quello per cui lavoravo io, tutte le decisioni vengono prese dal direttore, e i consulenti vengono usati come semplici parafulmini a cui viene addossata la responsabilità di eventuali rifiuti (“Alla commissione il film non è piaciuto”). Nei festival più sani, come pare sia Torino, ci si divide il lavoro in parti uguali, e soltanto le pellicole molto importanti vengono viste dal gruppo di lavoro al completo; una prima selezione viene operata dai singoli, che segnalano ai colleghi soltanto i titoli secondo loro meritevoli di una seconda occhiata.

Le pellicole, prima dei festival, vengono visionate nelle maniere più diverse: si organizzano proiezioni su grande schermo in sale grandi e piccole riservate apposta. Queste giornate di lavoro partono intorno alle nove di mattina, terminando verso sera o a notte inoltrata. Se il film non risulta abbastanza convincente, i comitati hanno facoltà di dire “basta” dopo dieci, quindici minuti di visione. Spesso, però, molti film vengono inviati ai festival su DVD, e allora tocca riunirsi intorno a una TV o allo schermo di un portatile, o farsi proiettare tutto su un piccolo schermo da campeggio in ufficio.
Al di là della qualità e delle singole dinamiche, i registi hanno poca o nessuna voce in capitolo quando si tratta di decidere a quali festival partecipare. Sono i produttori, e sempre più spesso gli international sales agents, insomma, le aziende che si occupano di vendere i diritti dei film ai singoli Stati, a decidere per loro. È compito loro stabilire la destinazione ideale di un’opera e farsi valere con i festival. Quando un film “forte” viene proposto a Cannes si chiederà non soltanto l’obbligatoria collocazione in concorso, ma anche un posizionamento “alto”, con la proiezione per il pubblico il venerdì o il sabato sera, giorni in cui l’attenzione dei media è molto più forte, oppure, per la stessa ragione, si chiederà l’apertura o la chiusura del concorso. Se il festival non è disposto a soddisfare tali richieste, il film verrà tolto dalla kermesse e collocato in un programma concorrente. Questo meccanismo riguarda regolarmente la triade Berlino-Cannes-Venezia. Lo stesso film viene fatto vedere a più gruppi di lavoro per tastare la situazione, e se Venezia, per dire, offre il concorso, mentre Cannes è incerta, produttore e sales agent faranno subito sapere a Cannes della contro-offerta. Di solito funziona e il film finisce a Cannes, lieta di sottrarre un titolo alla concorrenza, non importa se non è adatto al festival. Anni fa ho visto un affermato autore francese, paladino dei cinephiles di tutto il mondo, piangere lacrime vere e ripetere “Sono sotto sequestro!” perché il suo allora produttore, che gli avrebbe finanziato il progetto successivo, insisteva per portarlo a Cannes. Andò così, e il film venne accolto malissimo. Non importava a nessuno.
In alcuni casi particolari, come la Francia, un certo spazio di manovra ce l’hanno i distributori locali, per cui un passaggio a un festival nazionale può rappresentare un’occasione di forte lancio in vista della futura uscita in sala, allora saranno loro, magari, a fare pressioni sui produttori per indirizzarli verso Cannes, ma anche verso festival minori, come Deauville. La recente polemica nata intorno alla presenza-assenza di Netflix si deve alle tempistiche distributive di Netflix France, non a una battaglia per stabilire “cos’è il cinema oggi”.
Altro dato da tenere sempre presente è l’accollo economico rappresentato dai costi vivi della presenza di un film in un certo contesto. Girano sempre meno soldi, almeno in Europa, per cui se un festival vuole invitare un titolo con una o più grandi star si deve preparare a discussioni estenuanti su chi debba pagare la trasferta. Per avere ospite, che ne so, Samuel L. Jackson è necessario pagare viaggio, alloggio e spese varie a sei o sette persone (l’attore, l’assistente, il manager, la moglie, il figlio, lo stylist): se il festival non può pagare tutto, e il produttore si tira indietro, lo stesso film, a parità di qualità, lo vedrete spuntare in un contesto minore che può farsi forte di maggiori sponsor privati e sostegno di enti locali. Se vi siete mai chiesti cosa ci facessero Naomi Watts e Liev Schreiber in trasferta a Giffoni, ecco la risposta. A suo tempo, la Festa del Cinema di Roma offriva ospitalità principesca anche ai giornalisti, grandi e piccoli, aumentando la copertura garantita. Ricordo proiezioni semi-deserte all’Auditorium, ma intanto la bella figura era stata fatta e via.
Tenendo presente il quadro generale della situazione, ecco alcuni elementi per valutare con maggiore lucidità le scelte dei festival e la reazione di chi, ai festival, ci va spesso.

Berlino ha il gioco facile perché chiede, di solito, l’anteprima europea dei titoli in programma, non quella mondiale; un film americano grande o piccolo può essere appena passato al Sundance e rimbalzare un mese dopo in un altro cartellone quasi irrilevante, raddoppiando la fase di promozione. Cannes e Venezia tendono a chiedere l’anteprima mondiale, salvo rare eccezioni, e quindi non possono raccogliere titoli anche ottimi che sono già stati al Sundance, al South by Southwest eccetera. L’unico festival non americano che per gli spettatori statunitensi conti qualcosa è Cannes. Il marchio della palma è l’unico che sappiano riconoscere, anche perché l’offerta negli USA è diventata gigantesca, e per gli organizzatori è molto più economico offrire ospitalità alla stampa se devono spostarla di qualche centinaio di chilometri, non farle solcare l’Oceano Atlantico due volte.
Se nel programma ufficiale un film “non c’è”, come è accaduto a Claire Denis quest’anno, è possibile che quel film non sia piaciuto affatto al direttore, o che non fosse pronto davvero (magari è stato visionato un primo montaggio troppo lontano dalla completezza reale), o che sia saltato un accordo sui soldi. O che, magari, pensando alla promozione, si sia puntato tutto subito su festival più piccoli e meno affollati, come San Sebastian, Sitges (entrambi in Spagna, o il Fantastic Fest (in Texas) per i titoli di genere che piacciono ai giovani.
Gli addetti ai lavori sono a conoscenza di alcuni meccanismi, uno su tutti: il penultimo film in concorso a Cannes è tipicamente lo slot-pacco del festival, il posto in cui si relega un titolo molto brutto che è stato piazzato per disperazione o per compiacere qualcuno. La cosa è talmente risaputa che un paio d’anni fa Elle di Paul Verhoeven era già stato bollato come “l’inguardabile della stagione” in base alla pura collocazione. Le recensioni molto positive riservate a Elle, che ha poi sbancato ovunque, tradiscono la profonda sorpresa dei critici, che avevano tirato le somme in base al retro del bus dov’era stato sbattuto il film.
Situazioni surreali a parte, Nicolas Winding Refn è stato tanto abbracciato dal giro Cannes come “uno dei loro” che domani potrebbe girare una Instagram story dedicata al suo cane e un posto nel programma come evento speciale glielo troverebbero al volo, e lo difenderebbero come “il futuro del cinema”, così come una regista solida come Alice Rohrwacher verrà certamente tenuta sempre in considerazione, ma il suo essere donna non sposterà nulla. Il suo primo film, Corpo celeste, è passato alla Quinzaine des Realisateurs, una sezione parallela e indipendente di Cannes che viene vissuta come l’anticamera del concorso ufficiale; con Le meraviglie ha fatto il salto tra i grandi. Rohrwacher verrà sempre proposta a Cannes con largo anticipo dai suoi produttori. Ma si può anche perdere il proprio privilegio senza che vengano poi offerte motivazioni plausibili al pubblico. Bertrand Bonello nel 2016 si è visto rifiutare Nocturama, anche se era il cocco di Cannes, che aveva messo nella sezione minore Un Certain Regard anche film goffi e non riusciti come Tiresia, pur di non interrompere il rapporto con il regista. Nocturama si beccò un “no” secco, a cui vennero poi affibbiate confuse “ragioni politiche”, mai peraltro diffuse ufficialmente dal direttore, quindi forse riportate dal realizzatore e dai produttori per generare ancora più controversia intorno a un film difficile e non particolarmente gradevole. Bellissimo, per inciso. Recuperatelo.
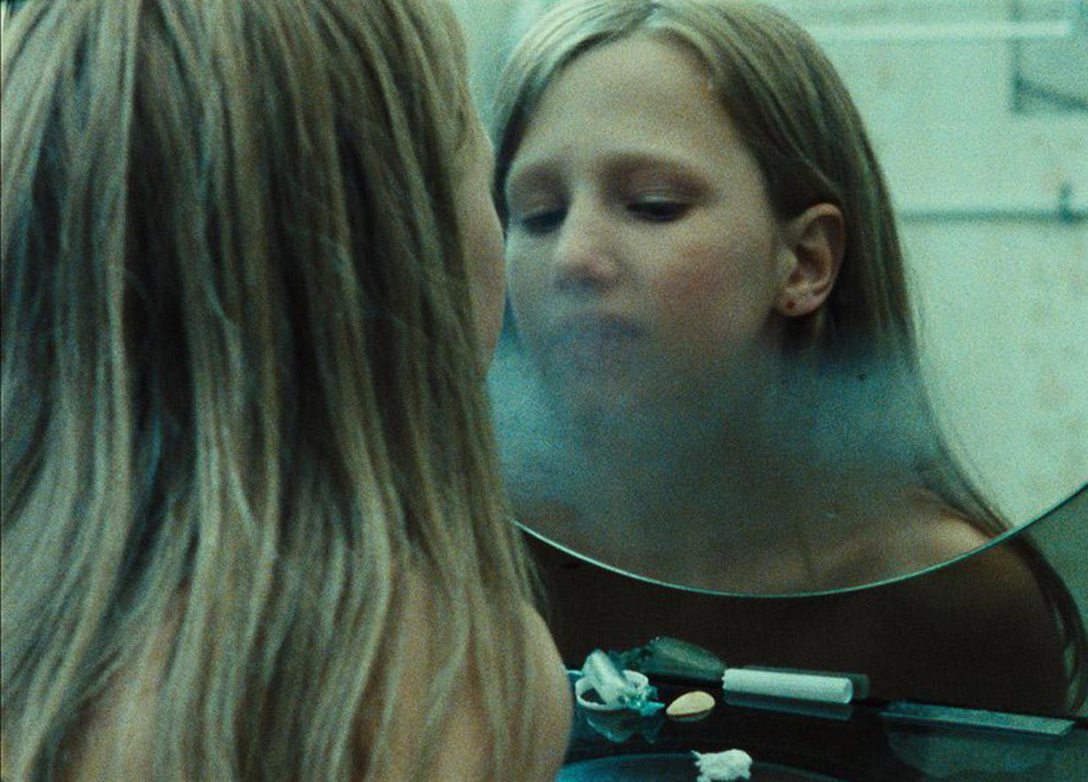



In conclusione, se volete guardarvi qualche film senza poi stare tre ore al bar a chiedervi “Ma perché questo è in concorso?”, non andate ai grandi festival: passate dritti a quelli “minori” solo sulla carta, come il Torino Film Festival, il Lovers, sempre a Torino, il Bergamo Film Meeting e il Far East di Udine. Almeno lì i programmi vengono assemblati in base al gusto personale di chi li fa e a un vago senso di rispetto nei confronti di quelli – appassionati, studenti, semplici curiosi – che si accollano accrediti e posti letto sperando di intravedere un po’ di cinema. E forse, en passant, qualche “regista donna” in più là dentro la trovate sul serio.
