
A Londra, tra Westminster e la periferica Canning Town, a sei fermate di metro sulla Jubilee Line, è segnato un confine per certi aspetti più netto dell’equatore. Come dimostra uno studio condotto tra il 2002 e il 2006 dal London Health Observatory, infatti, per ogni stop l’aspettativa di vita media cala di un anno, passando da 79 anni nell’elegante zona centrale a 73 per la più svantaggiata East End (i dati sono calcolati sulla popolazione maschile). Come fare un viaggio dall’altra parte del mondo, se pensiamo che tra la Gran Bretagna e lo Sri Lanka esiste la stessa differenza in termini di life expectancy. Com’è possibile? Michael Marmot, medico e professore di Epidemiologia e Salute Pubblica alla University College of London, ha dedicato la sua vita a cercare di dare una risposta a questa domanda, studiando già nei lontani anni Settanta e Ottanta le diverse condizioni patologiche di circa 30.000 dipendenti pubblici dei ministeri britannici ed evidenziato una proporzionalità diretta tra il loro stato di salute e posto occupato sulla scala gerarchica lavorativa. Una ricerca che tra dati, osservazioni e tabelle si avvicina alla politica, anche se politica non è.
Questi studi – Whitehall I e II, dal nome della zona di Londra che ospita le sedi dei principali Ministeri – hanno segnato la storia dell’epidemiologia legata all’analisi delle cause di malattia. Se un tempo si pensava che le patologie cardiovascolari fossero prevalenti tra le persone con maggiori responsabilità, grazie ai risultati di Marmot è stato possibile mettere in luce una realtà più complessa e differente. Alla base della piramide (si pensi al portiere, alla donna delle pulizie o alla segretaria) il rischio di morte per infarto è stato stimato essere di quattro volte superiore rispetto alla punta dirigenziale, con una differenza sull’aspettativa di vita che poteva raggiungere i dieci anni. Curioso il fatto che non si stia parlando di categorie “a rischio”, come disoccupati con reddito minimo e altre frange povere della popolazione. Marmot nelle sue ricerche non ha preso in considerazione categorie estreme, come nullatenenti o top manager, ma si è concentrato su un set di occupazioni confinate in uno spazio preciso, quello la pubblica amministrazione, in cui le persone tendono a essere simili sotto un profilo sociale. Stiamo parlando di gente con un lavoro, una casa e un certo grado di istruzione. È proprio questo il punto.

Il dualismo ricco-povero e le sue relative ripercussioni sullo stato di benessere non sono sufficienti a spiegare che cosa stia alla base dell’insorgenza di patologie. Certo, il reddito medio influisce sulla salute delle persone, ma non è tutto qui. Sono altri i fattori responsabili delle così dette “cause delle cause” delle malattie. Anche all’interno dello stesso mondo Occidentale esiste un gradiente sociale che determina una maggiore o minore possibilità di godere di un buono stato di salute. Ancora una volta, è un gioco di relazioni, di connessioni e di reti. Maggiori sono i punti di contatto tra l’individuo e l’esterno (inteso come possibilità lavorative, soddisfazione personale, grado di istruzione, reddito e senso di autocontrollo della propria vita, giusto per citarne alcune) migliori saranno gli indicatori del suo stato di benessere. Alias, sarà più felice e realizzato e quindi si ammalerà meno.

È stato dimostrato come lo status sociale sia alla base delle disuguaglianze di salute e come influenzi attivamente i fattori che condizionano lo sviluppo di patologie, che se da una parte sono legati a elementi immodificabili e individuali (come il sesso, l’età o la predisposizione genetica), dall’altra intersecano aspetti apparentemente distanti ma altrettanto incisivi. In che senso? I medici clinici, quelli di corsia e delle visite al capezzale del paziente, lo sanno bene. Le persone arrivano in ospedale per una determinata patologia – che sia un’insufficienza cardiaca o respiratoria non fa differenza – vengono stabilizzati, possibilmente curati, e dimessi. Capita però, più spesso del previsto, che ritornino per lo stesso problema nell’arco di poco tempo. Il fenomeno è stato scientificamente descritto come “sindrome della porta girevole”. D’altronde i ricercatori inglesi sono cresciuti col Benny Hill Show. Quando il pattern sociale che circonda l’individuo nel suo quotidiano è lo stesso responsabile del suo cattivo stato di salute ecco che l’ospedale diventa luogo di cura transitoria, insufficiente a colmare un gap che appartiene a una sfera più ampia della medicina e che abbraccia a tutto tondo l’economia, la politica, il contesto ambientale e socio-culturale.
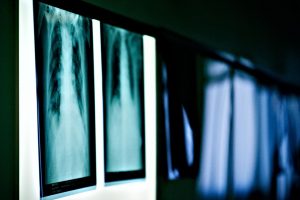
Tutto ciò richiama un altro grande fenomeno che sta investendo su larga scala molte nazioni, Italia inclusa. Eppure, gli esperti dicono che in questo caso il nostro Sistema Sanitario Nazionale meriti un plauso fragoroso per essersi guadagnato il secondo posto sia nella classifica mondiale dell’aspettativa di vita che in quella di miglior sistema assoluto, a detta della World Health Organizating (WHO), e il terzo come sistema più efficiente del 2014, secondo il Bloomberg (subito dopo Singapore e Hong Kong). Non ve lo aspettavate, vero? Finora c’è andata bene. Ma la salute è disuguale anche a causa di un accesso più o meno universale alle cure. La privatizzazione che sta investendo Paesi cardine della universal health care (come la Gran Bretagna, da cui ha avuto origine il sistema Beveridge, stampo su cui si basa anche il nostro sistema sanitario) sta, per quanto lentamente, travolgendo anche l’Italia. Non a caso il 7 aprile 2017 in tutta Europa è stata indetta una manifestazione contro la commercializzazione della salute e la sua privatizzazione. In Italia, il definanziamento va avanti dal 2010 e il bilancio Welfare del CENSIS 2015 parla di milioni di persone costrette a ritardare o a rinunciare del tutto alle cure a causa della mancata copertura dei livelli di assistenza. Un terreno fertile per le compagnie assicurative private.

In un mondo in cui la complessità è parte del tutto e dove le condizioni che ci fanno ammalare non possono essere inquadrate in un contesto prettamente e unicamente medico, la relatività della situazione individuale è un elemento da contestualizzare in un panorama politico più ampio, dove la salute pubblica gioco forza è protagonista. Durante la presentazione romana del suo ultimo libro uscito a fine 2016, Michael Marmot riassume forse meglio di chiunque altro il messaggio chiave per quel croupier chiamato Sistema Sanitario Nazionale: “Fate qualcosa, fate di più, fatelo meglio”.
