
In tutto l’Occidente, ogni nuova elezione politica porta con sé l’idea di una “svolta populista”. I partiti dell’establishment di centro-sinistra e di centro-destra perdono forza, lasciando spazio a nuove correnti che promettono di rappresentare chi è stato ignorato e chi stato messo a tacere. Non solo i relativamente nuovi Forza Italia e Partito Democratico, ma anche l’SPD tedesco e i socialisti francesi hanno perso il contatto con le proprie basi elettorali. Un termine polivalente come “populismo” offre tuttavia una descrizione insoddisfacente degli ultimi sconvolgimenti del panorama politico. I cosiddetti populisti dell’estrema destra e sinistra non hanno soltanto programmi opposti, ma anche basi popolari molto diverse, che si tratti della gioventù urbana disoccupata o della classe media frustrata. Nei Paesi anglofoni i vecchi partiti hanno retto, ma solo perché guidati da leadership trasformate in modo radicale. Quello che possiamo affermare per ora è che le nuove forze politiche sono tutte il sintomo di una crisi della democrazia rappresentativa. Se volessimo essere ottimisti, potremmo dire che gli elettori stanno sostituendo gli antiquati partiti “analogici” del XX secolo con altri creati per l’era digitale. Eppure ciò che colpisce di più è la sorprendente facilità con cui il desiderio di un nuovo tipo di rappresentanza conduca a una forma inedita di culto del leader.


Questa idealizzazione del leader riflette il declino delle strutture intermedie che un tempo caratterizzavano le democrazie dell’Europa occidentale: le sezioni, le associazioni e i sindacati che si frapponevano tra la politica a livello statale e gli individui. La frammentazione della vita lavorativa, l’ascesa del cittadino-consumatore e il declino dei sogni di progresso hanno minato questo coinvolgimento politico quotidiano, alimentando la fede in un deus ex machina. Persino negli anni passati, l’idea che il declino dei vecchi partiti potesse produrre questo nuovo “leaderismo” era tutt’altro che chiara. I movimenti sociali dal 2010 in poi, partendo dagli indignados spagnoli per arrivare fino a Occupy, erano caratterizzati proprio dalla richiesta di una democrazia più orizzontale. Dopo la guerra in Iraq e le politiche di austerity che hanno seguito la crisi economica, sono stati soprattutto gli elettori più giovani a perdere fiducia nei partiti consolidati e negli esperti che avevano proclamato la fine della Storia. Mossi da un senso di esclusione sia dal mercato del lavoro che dalle strutture partitiche, le proteste di piazza hanno cercato di riprendere controllo della rappresentanza politica. Particolarmente rilevante nei movimenti fioriti a partire dal 2011 è stata la richiesta di un processo decisionale collettivo e senza intermediari, una dissoluzione delle gerarchie agevolata dai social media, dalla democrazia online, e dalle più convenzionali assemblee territoriali. In Spagna e in Grecia, perlomeno, questi movimenti hanno avuto impatto sulla scena politica. Ma altrettanto chiaro è che non sono stati capaci di imporre un cambiamento politico dal basso. I laureati che non riuscivano a trovare lavoro e i giovani marginalizzati delle città erano sempre stati ignorati, e le cose non sono cambiate per le loro proteste. Erano riusciti a esprimere un senso di risentimento collettivo, ma non erano riusciti a spingere lo Stato a prendere iniziative. I movimenti orizzontali, strutturati in reti, non potevano replicare il potere strategico che i movimenti operai un tempo avevano: l’adunata dei precari non è stata una rivisitazione postmoderna delle occupazioni di fabbriche e porti. Nelle economie frammentate di oggi, i precari e i freelance non possono mettere in stallo i processi produttivi come i loro precursori del XX secolo. La vita lavorativa non è più così legata alla lotta politica.  Rimasti senza potere politico, questi cittadini afflitti hanno presto rivolto le proprie speranze verso ciò che avrebbe potuto avere una qualche influenza – le politiche di partito. Podemos di Pablo Iglesias ha sostenuto di aver preso spunto da queste proteste di piazza, mentre politici come Alexis Tsipras o Jean-Luc Mélenchon hanno attinto dalle speranze deluse di quelle stesse dimostrazioni. Persino i supporter di Bernie Sanders hanno detto di incarnare lo spirito di Occupy. Questi leader politici, dunque, non hanno semplicemente catturato le energie dei manifestanti. Piuttosto, le loro campagne elettorali hanno portato avanti alcuni elementi di quelle stesse rimostranze per la disoccupazione, la precarietà e l’esclusione dalle vecchie strutture di partito, dopo che la forza di questi movimenti si era esaurita. Di certo non si sposavano con lo spirito iniziale di queste proteste, ma rispondevano semmai alla mancanza di rappresentanza con un culto del leader outsider, il sostituto postmoderno dei vecchi partiti politici.
Rimasti senza potere politico, questi cittadini afflitti hanno presto rivolto le proprie speranze verso ciò che avrebbe potuto avere una qualche influenza – le politiche di partito. Podemos di Pablo Iglesias ha sostenuto di aver preso spunto da queste proteste di piazza, mentre politici come Alexis Tsipras o Jean-Luc Mélenchon hanno attinto dalle speranze deluse di quelle stesse dimostrazioni. Persino i supporter di Bernie Sanders hanno detto di incarnare lo spirito di Occupy. Questi leader politici, dunque, non hanno semplicemente catturato le energie dei manifestanti. Piuttosto, le loro campagne elettorali hanno portato avanti alcuni elementi di quelle stesse rimostranze per la disoccupazione, la precarietà e l’esclusione dalle vecchie strutture di partito, dopo che la forza di questi movimenti si era esaurita. Di certo non si sposavano con lo spirito iniziale di queste proteste, ma rispondevano semmai alla mancanza di rappresentanza con un culto del leader outsider, il sostituto postmoderno dei vecchi partiti politici.


Questo modo di personalizzare la politica riflette l’assottigliamento della Sinistra parlamentare tradizionale, la vecchia modalità che cercava di collegare le riforme a livello centrale a una rete di istituzioni intermediarie. Per decenni, le connessioni tra sindacati, cooperative, sezioni di partito e lo Stato hanno legato la politica rappresentativa a una più ricca rete di coinvolgimento, che faceva sentire partecipi milioni di cittadini. C’erano leader, certo, ma erano solo dei tribuni del popolo per movimenti sociali ben radicati, con ambizioni politiche collettive.
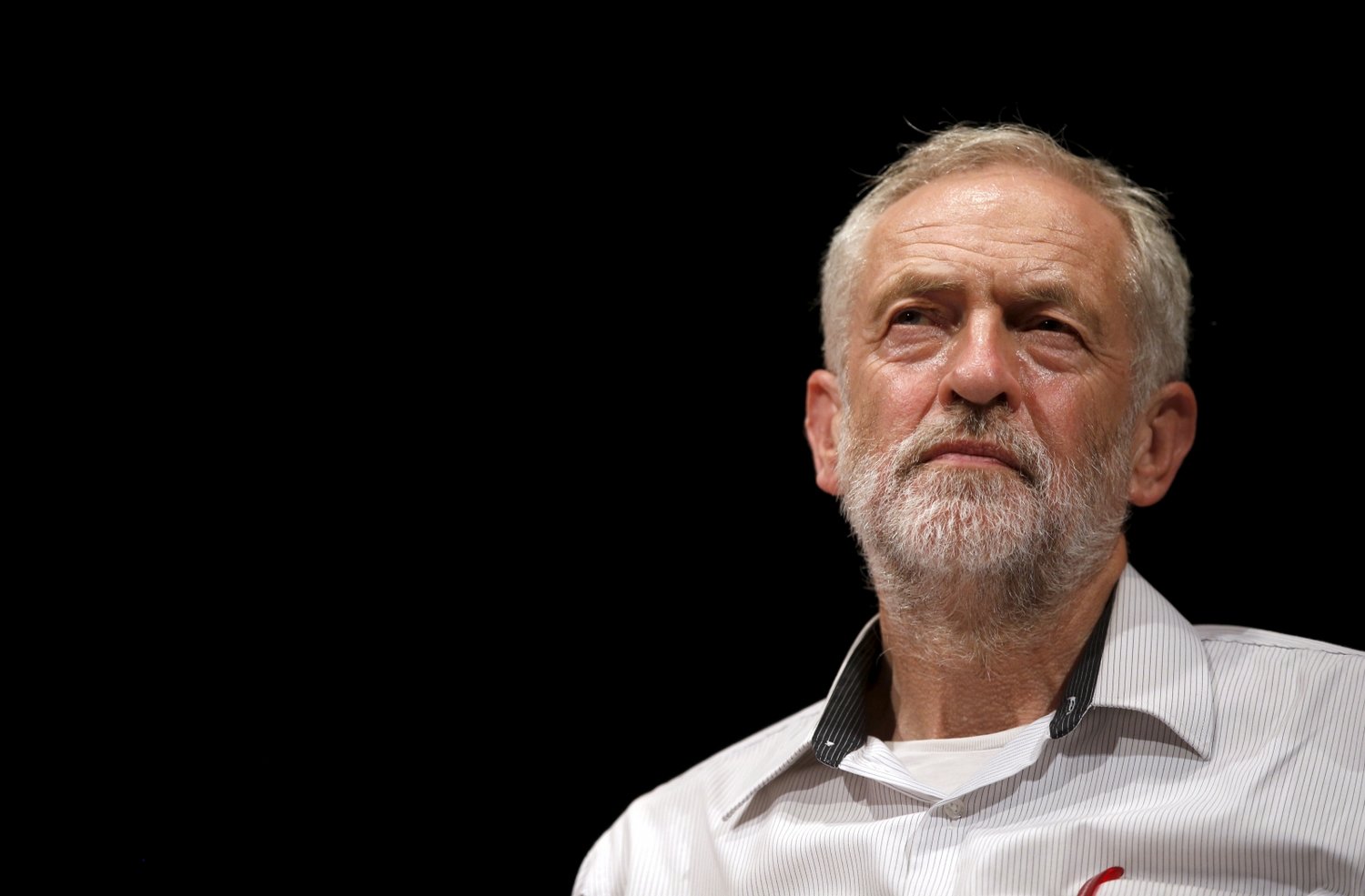

 La venerazione della figura di una guida, dunque, si accompagna al più ampio svuotamento di significato della politica occidentale. Le lotte per istanze politiche specifiche, dalla disoccupazione alla politica estera, sono rimpiazzate da una partita interamente giocata sui media. Fan di uno o dell’altro capo branco, si danno battaglia nelle sezioni dei commenti o in post sui social per la rappresentazione mediatica del “loro uomo”, difendendone a spada tratta l’onestà. Negli Stati Uniti la stagione delle primarie si è sempre svolta in modo così superficiale: la logica di costruire l’interprete iconico della volontà popolare si è ora diffusa nel resto del mondo occidentale. Distruggendo le antiche alleanze del centro-destra e del centro-sinistra, la venerazione dell’”eroe popolare” finisce quindi per riflettere e allo stesso tempo dare spinta al declino della partecipazione democratica. L’affiliazione ben radicata a un partito e alla sua visione sociale è sostituita dalla fedeltà online a un leader. Se questo è davvero populismo, non dà forma a un popolo quanto piuttosto a una massa di fan, diventando un po’ come il voto per un concorrente di Italia’s Got Talent piuttosto che il coinvolgimento in un progetto collettivo. Tutto ciò ovviamente non deve essere visto come un invito a difendere gli zombie dei vecchi partiti, e i laburisti britannici offrono un motivo di speranza parziale in questo senso. Anche se solo una minima parte dei loro nuovi iscritti sono attivi nella politica quotidiana, la lotta per dominare le strutture di partito ha mobilitato migliaia di giovani, spingendoli a un’azione articolata. Si stanno ponendo le basi per un nuovo e più profondo coinvolgimento, che sia in grado di portare a una soggettività politica capace di sopravvivere al fenomeno Corbyn. Sono sempre esistiti leader idolatrati, anche nella Sinistra. Per gran parte della storia ciò è stato giustificato con la loro capacità di aiutare masse di individui a interessarsi alla vita politica, non limitandosi a essere il loro eroe o il loro interprete. Ora che l’azione collettiva non è più al centro della nostra quotidianità, e i vecchi partiti sembrano distanti e antiquati, è diventato difficile ristabilire questa modalità più profonda di coinvolgimento. Ma senza di esso, rischiamo di collassare in un mondo in cui la politica è governata solo dal culto dell’uomo solo al comando.
La venerazione della figura di una guida, dunque, si accompagna al più ampio svuotamento di significato della politica occidentale. Le lotte per istanze politiche specifiche, dalla disoccupazione alla politica estera, sono rimpiazzate da una partita interamente giocata sui media. Fan di uno o dell’altro capo branco, si danno battaglia nelle sezioni dei commenti o in post sui social per la rappresentazione mediatica del “loro uomo”, difendendone a spada tratta l’onestà. Negli Stati Uniti la stagione delle primarie si è sempre svolta in modo così superficiale: la logica di costruire l’interprete iconico della volontà popolare si è ora diffusa nel resto del mondo occidentale. Distruggendo le antiche alleanze del centro-destra e del centro-sinistra, la venerazione dell’”eroe popolare” finisce quindi per riflettere e allo stesso tempo dare spinta al declino della partecipazione democratica. L’affiliazione ben radicata a un partito e alla sua visione sociale è sostituita dalla fedeltà online a un leader. Se questo è davvero populismo, non dà forma a un popolo quanto piuttosto a una massa di fan, diventando un po’ come il voto per un concorrente di Italia’s Got Talent piuttosto che il coinvolgimento in un progetto collettivo. Tutto ciò ovviamente non deve essere visto come un invito a difendere gli zombie dei vecchi partiti, e i laburisti britannici offrono un motivo di speranza parziale in questo senso. Anche se solo una minima parte dei loro nuovi iscritti sono attivi nella politica quotidiana, la lotta per dominare le strutture di partito ha mobilitato migliaia di giovani, spingendoli a un’azione articolata. Si stanno ponendo le basi per un nuovo e più profondo coinvolgimento, che sia in grado di portare a una soggettività politica capace di sopravvivere al fenomeno Corbyn. Sono sempre esistiti leader idolatrati, anche nella Sinistra. Per gran parte della storia ciò è stato giustificato con la loro capacità di aiutare masse di individui a interessarsi alla vita politica, non limitandosi a essere il loro eroe o il loro interprete. Ora che l’azione collettiva non è più al centro della nostra quotidianità, e i vecchi partiti sembrano distanti e antiquati, è diventato difficile ristabilire questa modalità più profonda di coinvolgimento. Ma senza di esso, rischiamo di collassare in un mondo in cui la politica è governata solo dal culto dell’uomo solo al comando.