
Da un’indagine scientifica che si chiede da dove arrivi la volontà ossessiva dell’essere umano di vivere per sempre e perché non ci basti il tempo mortale a un dialogo tra biologia e meditazione che ci invita a immedesimarci nella mente di altri esseri viventi per scoprire di più su noi stessi, passando per romanzi sull’identità, sulla scoperta di sé e su un mondo che sembra svanire con l’avanzare dell’alta velocità, ecco cosa abbiamo letto questo mese.
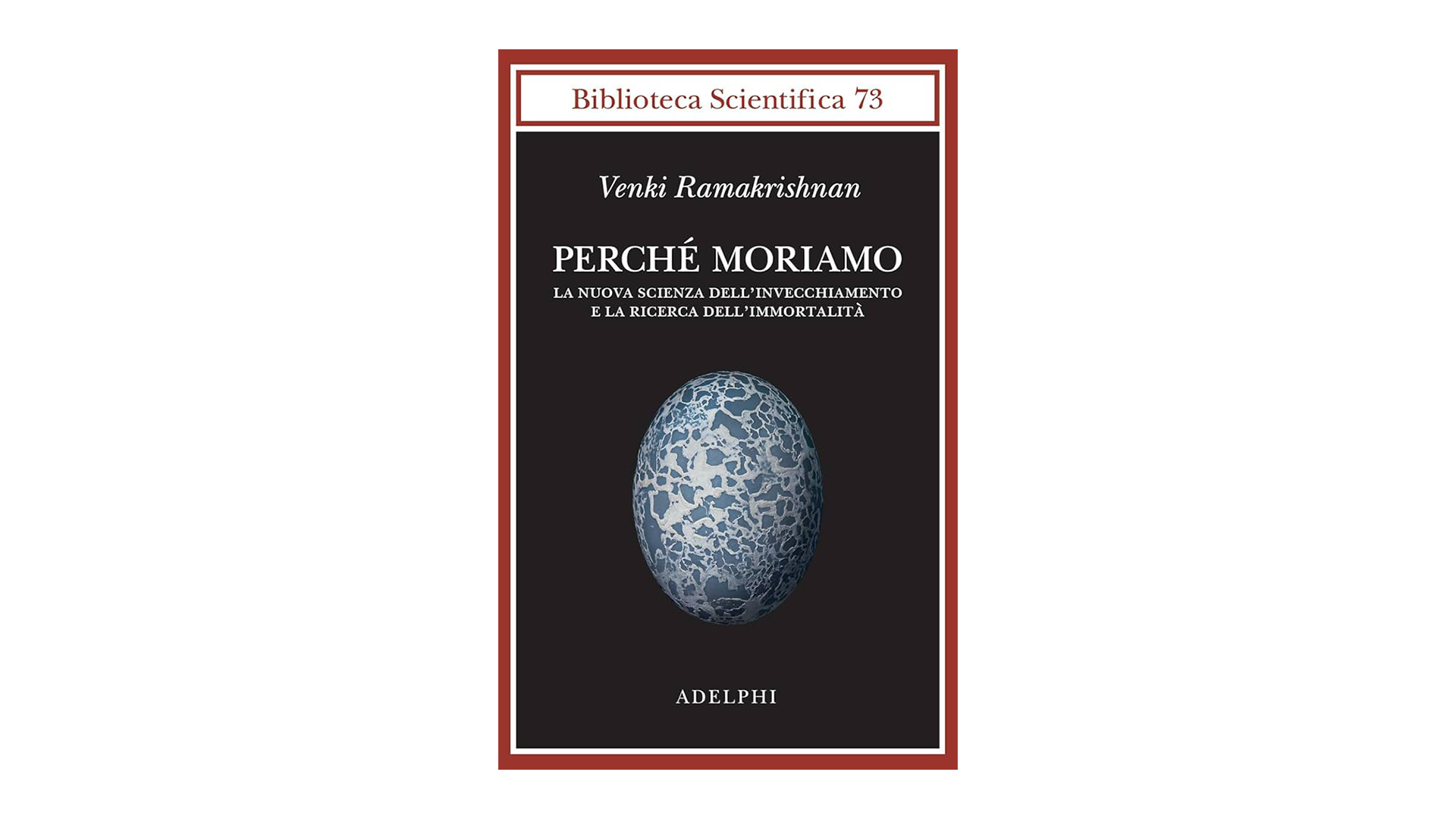
Perché moriamo. La nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità, di Venki Ramakrishnan (Adelphi)
Da dove arriva la volontà ossessiva dell’essere umano di vivere per sempre? Perché non basta la vita mortale? In parte, sembra basarsi sul desiderio di annichilire lo scorrere del tempo e detrarne il potere per averlo nelle proprie mani, con la credenza che quel potere non sfugga di mano e ognuno personalmente ne possa giovare. È un’aspirazione che accompagna da sempre l’umanità e che nella storia ha assunto e assume diverse forme: dai ritratti alle guerre, dal mecenatismo alla modalità più naturale – o forse meglio dire biologica –, la procreazione. Oggi che questa ambizione si interseca a un progresso tecnologico e a un’innovazione della medicina mai avanzati come ora, sono soprattutto i miliardari a sperimentare le tecniche più eccentriche e bizzarre per ripensare i nostri concetti di vita, di morte e di essere umano, nel tentativo non solo di vivere mille anni, ma di essere giovani il più a lungo possibile. Solo nell’ultimo decennio sono apparsi più di trecentomila articoli sull’invecchiamento e l’estensione della vita, e oltre settecento aziende emergenti hanno investito complessivamente decine di miliardi di dollari nell’impresa. È da questo contesto che parte il biologo molecolare Venki Ramakrishnan, vincitore di un premio Nobel per la chimica nel 2009 ed ex presidente della Royal Society, una delle più antiche associazioni accademiche esistenti, per esplorare la biologia dell’invecchiamento e della morte, non solo a livello scientifico ma anche nelle sue conseguenze etiche e sociali.
In Perché moriamo. La nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità Ramakrishnan parte da ciò che conosce meglio, cioè la cellula e il suo funzionamento, per costruire un racconto che evolve verso temi come l’invecchiamento, l’uso degli animali modello, la restrizione calorica, le trasfusioni di sangue “giovane”, la criogenia e i movimenti transumanisti, portandone in superficie limiti e progressi per smontare le illusioni post-umane ed evidenziare la frequente assenza di prove credibili a sostegno. Il saggio, pur accessibile, non rinuncia alla precisione scientifica, con un linguaggio tecnico che in alcuni passaggi può risultare un po’ impegnativo, ma Ramakrishnan ci aiuta sempre a orientarci tra i vari concetti trattati, inserendo anche curiosità e aneddoti storici sugli scienziati che hanno contribuito alle scoperte più rivoluzionarie della scienza. Il biologo molecolare, però, affronta anche questioni etiche e sociali, avvertendo che una società dove gli individui vivono secoli rischierebbe di stagnare, con poco ricambio generazionale e gravi squilibri economici ed ecologici. Per lui, infatti, la vera sfida non è inseguire l’immortalità, ma migliorare la qualità della vita affrontando le malattie legate all’età e rendendo più dignitoso il tempo che abbiamo. Una riflessione profonda non solo su come viviamo, ma sulla trappola del desiderio di poterlo fare per sempre.
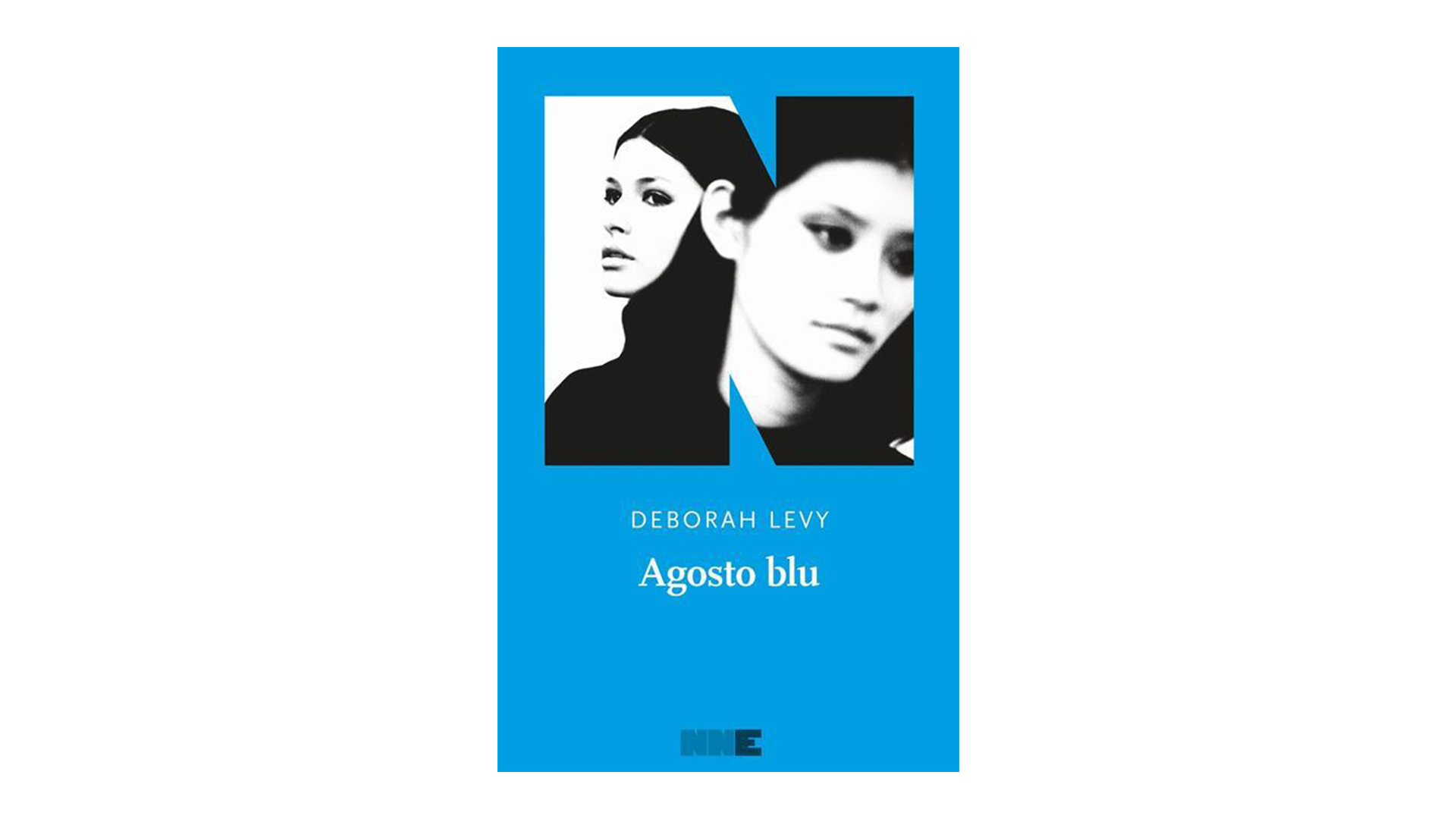
Agosto blu, di Deborah Levy (NN Editore)
L’incontro con il doppio, che ci appare come un’ombra, un riflesso, qualcosa che ci appartiene eppure non possiamo controllare, ci accompagna da secoli. Da Dostoevskij a Borges, il doppelgänger non è mai solo una figura narrativa ma l’emersione di una frattura: un incontro che ciò che abbiamo rimosso, che non ricordiamo o non accettiamo, con ciò che sfugge alla nostra coscienza. Non è un nemico esterno ma una parte che la nostra identità non riesce a integrare e che, come in una fiaba, si stacca, prende forma, diventa altro da noi e ci cammina accanto. Vederlo è sperimentare uno spaesamento radicale: riconoscersi completamente nell’Altro, perdere il proprio senso di unicità. In questo solco si muove anche Elsa M. Anderson, protagonista del nuovo romanzo della scrittrice inglese Deborah Levy: una pianista di fama internazionale che, durante l’esecuzione del Concerto per pianoforte n. 2 di Sergej Rachmaninov a Vienna, lascia il palco in un gesto tanto enigmatico quanto devastante. È il punto di rottura che la costringe a interrogarsi sulla sua identità, sulla natura del talento, sulle radici di una vita segnata dall’adozione da parte del severo Arthur Goldstein, il mentore che l’ha trasformata in prodigio musicale e, nello stesso tempo, l’ha privata della possibilità di conoscere se stessa nella sua origine più intima. Da questo evento nasce un viaggio inquieto e disseminato di immagini simboliche, che porta Elsa da Atene a Parigi, da Londra fino alle coste della Sardegna, sempre accompagnata dalla presenza perturbante di una donna che sembra la sua copia speculare, un doppelgänger che la osserva, la precede, la riflette. È la concretizzazione di un conflitto interiore, la figura che incarna il desiderio di diventare altro da sé e di liberarsi dalla forma imposta dagli altri.
“Sono due pensieri contraddittori la possibilità di porre fine alla mia vita e il desiderio di averne di più”, dice a un certo punto la protagonista. “Quindi? Ecco altre due contraddizioni: non credo in Dio, ma parlo con qualcosa che gli somiglia. Chiedo a questa presenza di sentire al posto mio quando recido i miei stessi sentimenti”. Essere contraddittori è l’essenza stessa di questo nostro muoverci nel mondo, scegliere chi siamo e poi cambiarlo, riscoprirlo. In questo senso, Agosto blu affronta temi profondi e stratificati: il rapporto con l’arte e con l’idea di perfezione, la perdita e la ricerca delle origini, il peso del passato e la possibilità di reinventarsi. È una meditazione letteraria sulla metamorfosi del sé, anche fragile, anche incerta. Levy scrive un romanzo enigmatico e sensuale, che somiglia a un sogno lucido: non offre risposte, non chiude il cerchio, ma apre un varco attraverso cui guardare chi potremmo diventare.
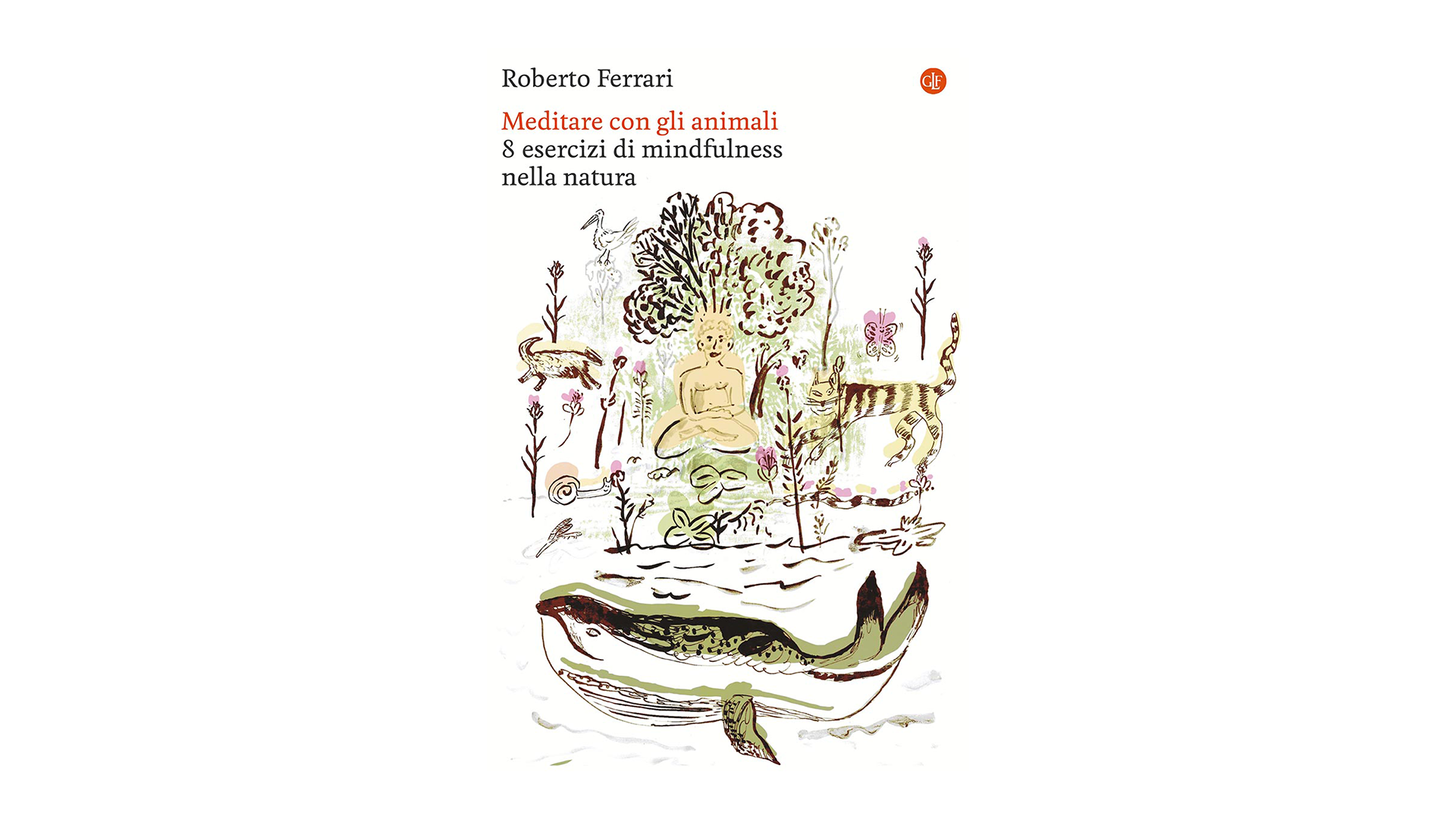
Meditare con gli animali. 8 esercizi di mindfulness nella natura, di Roberto Ferrari (Laterza)
Con Meditare con gli animali, Roberto Ferrari ci conduce in un viaggio straordinario e indimenticabile: otto esercizi di mindfulness realmente radicati nella natura, che non si limitano a osservarla, o a sfruttarla come spunto o ispirazione, ma invitano il lettore a incarnarne l’esperienza, a calarsi effettivamente nei panni di creature molto diverse da noi, per guardare il mondo con occhi nuovi. Biologo ed esperto di meditazione, Ferrari combina con rara maestria rigore scientifico e sensibilità contemplativa, proponendo un dialogo ricco tra scienza, filosofia orientale e una pratica meditativa capace di liberarci dai nostri pregiudizi. Il nucleo del libro ruota intorno all’idea che, se potessimo “sbirciare dentro le menti silenziose degli animali”, potremmo imparare molte cose su noi stessi e sul senso più profondo della vita. Immedesimarsi in balene, lumache, tartarughe, fenicotteri, tassi e lombrichi è un esperimento immaginativo e radicale. Ogni immersione è allo stesso tempo un percorso dentro noi stessi e un gesto rivoluzionario, perché ci invita a sospendere le categorie e abitudini mentali consolidate, per ritrovare un nuovo modo di sentirci e sentire che suscita meraviglia, come tutte le cose nuove.
La combinazione di percorso scientifico e meditativo dà spessore all’approccio del libro, che mescola discorso teorico a proposte concrete, esperienziali. Il libro si presenta così con una prosa che sa essere al contempo evocativa ed esatta, capace di descrivere con precisione lo stupore del contatto con il mondo animale senza sentimentalismi e retorica, ma anche con una vena quasi ipnotica che accompagna il lettore nella scoperta di nuove prospettive. Il valore di Meditare con gli animali risiede nella sua capacità di compiere un doppio movimento: verso l’esterno, ovvero verso gli animali e la loro esperienza; e verso l’interno, verso una forma rinnovata di comprendere noi stessi e riaccendere nel lettore il desiderio di prendersi cura dell’esistente. In un momento in cui la frammentazione e l’alienazione spesso dominano la nostra vita quotidiano, questa proposta ci invita a una presenza aperta, curiosa, capace di ascolto e connessione effettiva. Il dialogo tra biologia e meditazione assume qui un significato nuovo: non si tratta solo di illustrare fenomeni animali, ma di lasciarsene trasformare. Coniugando rigore e fantasia, Ferrari invita a una pratica che è contemporaneamente etica, filosofica e spirituale. Un invito, attraverso creature diverse da noi, a ritrovare uno sguardo più vasto, più attento, più curioso verso gli altri, verso noi stessi e verso il mondo.
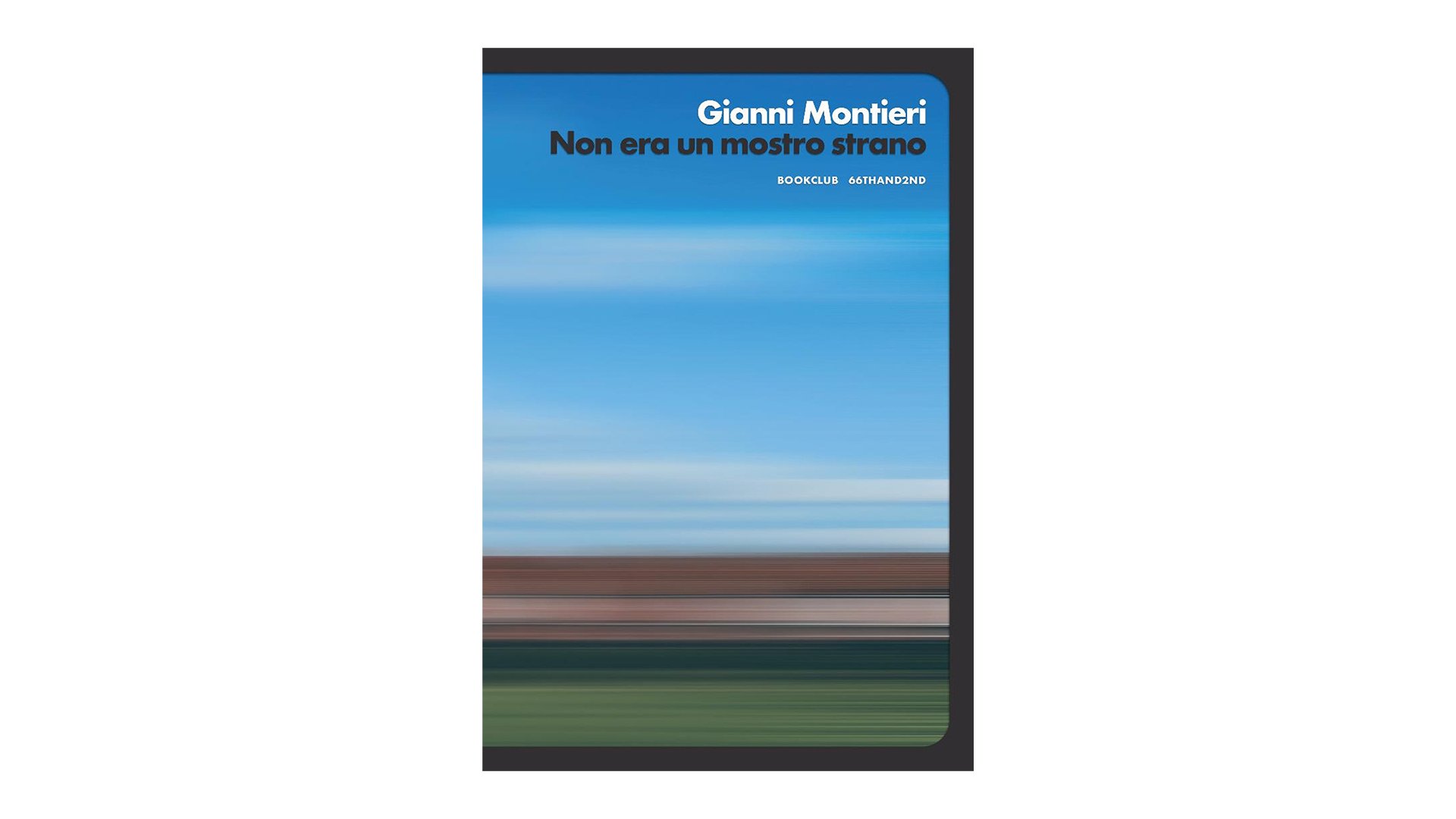
Non era un mostro strano, Gianni Montieri (66thand2nd)
Stare seduti accanto a un finestrino appannato, con il ritmo ipnotico delle rotaie che scandisce i pensieri, mentre fuori sfrecciano paesaggi che lentamente si dissolvono: è l’atmosfera che permea Non era un mostro strano, il nuovo libro di Gianni Montieri pubblicato da 66thand2nd. Con sole 144 pagine, questo itinerario sentimentale non è un romanzo tradizionale, ma un mosaico di ricordi, riflessioni e aneddoti che eleva il treno – quel “mostro strano” del passato – a protagonista assoluto. Montieri, poeta e scrittore napoletano con una passione per i viaggi lenti e le storie umane, ci guida attraverso un mondo che sembra svanire con l’avanzare dell’alta velocità: dai vagoni scassati dei regionali ai lussuosi elettrotreni come il Settebello, icona degli anni ’60 che collegava Roma e Milano in un’eleganza ormai perduta.
Il libro si apre con una confessione intima: “Sono andato con il treno da una casa all’altra, da una vita all’altra”. Da qui, Montieri dipana un filo di episodi personali intrecciati a fatti storici. Parla dell’inaugurazione della Napoli-Portici nel 1839, la prima ferrovia italiana, un evento che simboleggia l’inizio di un’era di progresso e meraviglia. Ma non manca il lato oscuro: la tragedia di Balvano del 1944, dove un treno affollato di poveri migranti rimase bloccato in una galleria, causando oltre 500 morti per asfissia e caldo; o il sabotaggio partigiano del ponte di Ivrea durante la Seconda Guerra Mondiale, un atto di resistenza che fermò un convoglio tedesco carico di munizioni.
Questi momenti non sono fredde lezioni di storia, ma frammenti che evocano il treno come testimone muto di gioie e orrori collettivi, che Montieri rende vivi, quasi tangibili, con un linguaggio poetico che affonda le radici nella sua produzione lirica. L’autore ci descrive il mare visto dal finestrino, con quel sapore di “ruggine, umido, nebbia, muffa e sale”; le stazioni abbandonate, custodi di silenzi e ricordi; i passeggeri anonimi, con le loro vite segrete che si intrecciano per un istante. Montieri non idealizza: ammette la scomodità dei notturni, il ritardo cronico degli interregionali, ma trova poesia in quel disagio. Il treno diventa metafora del viaggio interiore, un mezzo che rallenta il tempo e invita all’osservazione, contrapposto all’anonimato dell’aereo o dell’auto.
