
Una delle categorie professionali più stereotipate è sicuramente quella degli artisti: bohémiens travolti dal turbine delle emozioni, eccentrici in contrasto con le convezioni sociali e il potere costituito, misteriosi animi tormentati. Questa visione, tanto cinematografica quanto poco aderente alla realtà, può apparire romantica e ammaliante, ma ha il grande difetto di danneggiare una categoria, quella dei lavoratori del settore artistico e culturale, che ogni giorno deve fare i conti con precarietà e sfruttamento. Il prodotto artistico, al pari di tutti gli altri prodotti sul mercato, infatti, è frutto di studio e lavoro costanti. Se negare l’origine creativa di un prodotto artistico ne sminuirebbe l’unicità – nessuno vuole paragonare una pièce teatrale ad un elettrodomestico – negare all’artista lo status di lavoratore ne compromette la dignità. Infatti, questa visione romantica del mondo dell’arte e della cultura non si limita a influenzare l’immaginario comune, ma ha forti ripercussioni sull’importanza attribuita a tali settori dalle istituzioni che hanno il compito di regolamentare i compensi e le condizioni lavorative degli artisti.
Il luogo comune ci dice che con la cultura non si mangia e allo stesso tempo l’arte è assurta a simbolo della grandezza culturale italiana, Paese d’arte e d’artisti. O l’una o l’altra, eppure pare che la retorica che vuole l’arte come un aspetto fondamentale della nostra vita non comporti come naturale conseguenza la tutela di chi l’arte la fa. Questo atteggiamento ha origine da un fraintendimento di fondo, anche piuttosto ingenuo: la fruizione dell’arte, negli ultimi tempi sempre più democratica e socialmente trasversale, è nella maggioranza dei casi relegata al cosiddetto tempo libero. Andare a vedere una mostra, godere di un concerto o assistere a uno spettacolo teatrale sono attività che vengono svolte per svagarsi e liberare la mente dalle incombenze della vita quotidiana. Dedicarsi a qualcosa di sublime permette di distogliere per un attimo il flusso di pensieri dagli obblighi, aprendo finestre, tanto emotive quanto mentali, su un mondo altro.

Che l’arte sia un’interruzione della regolarità – lavoro, scadenze, tasse da pagare, spesa da fare, casa da pulire – porta all’ingannevole credenza per cui chi se ne occupa stia costantemente eludendo la vita vera – quella di chi si alza ogni giorno per andare a lavorare – in nome di qualcosa di più elevato, che tramite il lume dell’ispirazione si trasforma in prodotto artistico fruibile. Il fraintendimento sta proprio qui: nel non capire che ciò che per i fruitori è svago e interruzione della normalità, per l’artista è lavoro e normalità, scadenze e dichiarazione dei redditi comprese. Riconoscere il lavoro dietro all’opera d’arte significa riconoscere all’artista il diritto di svolgere una vita dignitosa, al pari di quella di un impiegato di un qualsiasi altro settore. Al contrario, la mancata riconoscenza dello status di lavoratore nei riguardi dell’artista porta a una legislazione lacunosa e approssimativa.
Questa situazione, già delicata prima della pandemia, appare oggi addirittura tragica. In Italia, il lockdown nazionale è stato preceduto dalla chiusura di musei, cinema e teatri e dall’annullamento di concerti ed eventi culturali e artistici. Nessuno vuole mettere in dubbio la sensatezza di questa misura, varata in un momento in cui era necessario ridurre al minimo indispensabile i contatti sociali e gli assembramenti: ciò che però va questionato è il grado di attenzione che il settore della cultura ha ricevuto da parte del governo e dai suoi piani di ripresa. Non ci sono infatti ancora risposte chiare sulla direzione che il settore culturale dovrà e potrà intraprendere, eppure, essendo molto probabilmente l’ultimo a poter riaprire i battenti, diverse categorie si ritrovano a rischio.

Il Decreto Cura Italia prevedeva che artisti e operatori del settore dell’arte, al pari di tutti i lavoratori autonomi con un reddito inferiore ai 50.000 euro, potessero richiedere un’indennità mensile di 600 euro. La misura, certamente d’aiuto, rimane tuttavia circostanziale, un rammendo d’emergenza che non ripara a lungo termine il tessuto lacero, ma ne posticipa un potenziale tracollo definitivo. Proprio per far fronte a questa situazione sono nate negli ultimi mesi molte iniziative che puntano ad accendere i riflettori sulla figura dell’artista e il suo riconoscimento professionale, esigendo che vengano ripensate le tutele fiscali e giuridiche di chi lavora in questo ambito. Il vaso di Pandora è stato aperto ed è emersa una situazione, oggi certamente aggravata, che si protrae da molti anni.
Uno studio dell’università Sapienza di Roma intitolato “La situazione economica e sociale dell’artista in Italia” metteva in luce già nel 2009 problematiche che persistono anche oggi. Dalla ricerca è emersa la difficoltà di definire una figura, quella dell’artista, che risulta “sfaccettata e multiforme, a metà fra estro e mercato” e che si scontra ogni giorno con “le difficoltà economiche date da una committenza intermittente e dalla sensazione diffusa di non essere tutelati, come avviene in buona parte d’Europa, da una legislazione ad hoc, in campo previdenziale ed assistenziale ad esempio, e da politiche volte a promuovere nel territorio l’arte tout court”. Inoltre, dall’indagine compiuta sul campione di artisti oggetto dello studio, risulta che il 41,5% per poter vivere svolge un’attività parallela oltre a quella artistica.

Proprio il tema della precarietà contrattuale ed economica emerge dalla testimonianza di Laura Serena, attrice teatrale attiva presso “Attrici e Attori Uniti”, una comunità di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che si sta confrontando sulle problematiche del settore. “Abbiamo bisogno di riforme generali,” afferma Serena, “non di trattamenti speciali una tantum. Il sistema va rivisto e riformato una volta per tutte. Vogliamo uno statuto delle professioniste e dei professionisti dello spettacolo, vogliamo che venga riconosciuta la specificità del nostro lavoro, vogliamo avere voce in capitolo nel ripensamento delle normative attuali. In Italia è diffusa una certa diffidenza nei confronti del nostro mestiere. Si fa moltissima fatica a farsi riconoscere in una società che crede che fare l’attrice o l’attore assomigli molto di più a un gioco o a un passatempo che a un vero e proprio lavoro”.
“La paga minima sindacale prevista per una giornata lavorativa di un attore teatrale professionista scritturato,” continua, “è di circa 50 euro netti e comunque sulla durata di un contratto a lungo termine non si può contare.” La precarietà economica non caratterizza tuttavia solo il mondo del teatro; alcuni ricorderanno la bufera sollevata dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, il quale, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, denunciò la misera paga dei musicisti dell’orchestra sinfonica stabile di Sanremo. Il fatto che un evento Rai, sovvenzionato da soldi pubblici, offra compensi al limite dello sfruttamento agli artisti che impiega, è l’ennesima dimostrazione di come l’arte possa essere retoricamente osannata senza che ne consegua una valorizzazione reale di chi la esercita. Infatti, il messaggio implicito che le istituzioni veicolano, è ancora una volta quello per cui la possibilità di recitare o suonare in un ambiente prestigioso debba avere un valore in sé, quasi fosse gentile concessione di un ente benefico all’artista affamato, il quale, se osa lamentarsi, viene tacciato di ingratitudine e avanti il prossimo.
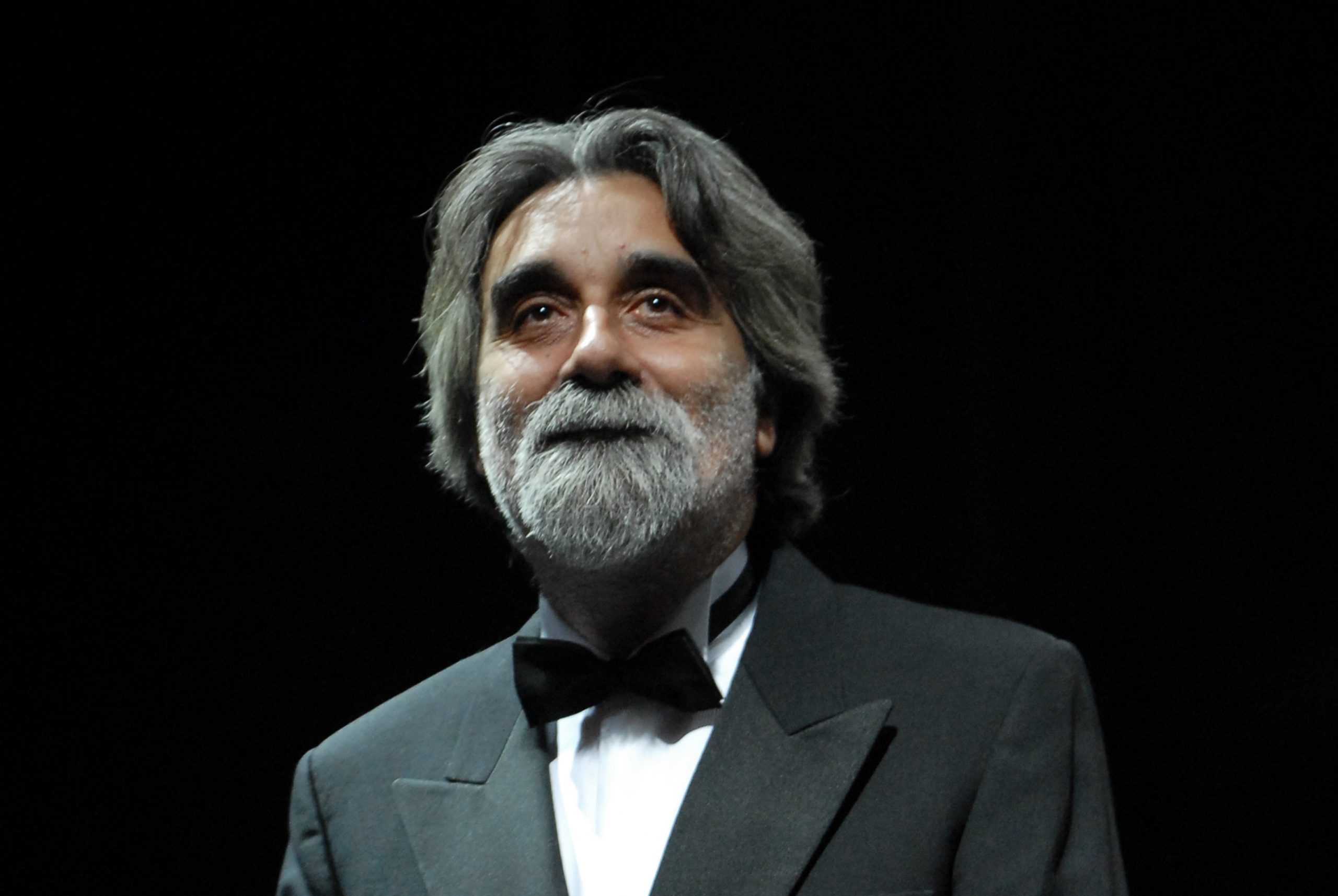
Se questa è la normalità in tempi pre-COVID, durante la quarantena il paradigma è continuato a essere lo stesso: si è dichiarato, retoricamente, che l’arte sia fondamentale, e quindi, come recita lo slogan del Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali, #laculturanonsiferma. Si è chiesto agli artisti di produrre contenuti e performance da casa per intrattenere la popolazione in quarantena e si è chiesto loro di farlo gratuitamente. Nel frattempo però non ci si è preoccupati di fornire risposte serie a domande legittime sul futuro. Intanto si continui ad arte, senza garanzie, per il gusto di farlo, il fatto che anche gli artisti debbano anche pagare l’affitto sembra secondario.
Per spezzare la catena dell’incertezza lavorativa è necessario comprendere che lo stereotipo romantico dell’artista bohémien e la condizione di precarietà e sfruttamento in cui spesso è costretto a lavorare sono due facce della stessa medaglia. Finché continueremo a parlare dell’artista come di un affascinante scapestrato che dipinge, suona, recita o danza per passione, perché non può fare altro, come un moderno saltimbanco, e non gli riconosceremo la dignità di lavoratore, staremo contribuendo alla lenta deriva di un settore già fin troppo compromesso. Gli artisti non vogliono incarnare gli stereotipi degli altri: vogliono invece avere i loro stessi diritti.
In copertina: Keith Haring nel suo studio a New York City, 1983.
