In un’epoca in cui il conflitto generazionale è particolarmente marcato, è facile convincersi che la propria vita non abbia nulla a che vedere con quella dei propri genitori. Non scegliamo discutibili grafiche da mandare al buongiorno, viviamo nella precarietà e non crediamo più nel dedicare tutta la vita al lavoro, abbiamo una sensibilità sociale diversa: ogni cosa concorre a consolidare questa percezione. Come ogni generazione ci convinciamo di essere migliori della precedente, ma al di là dei macro sistemi c’è un passaggio più intimo e quotidiano che ci porta a confrontarci con la possibilità che, in fondo, i punti in comune siano molti di più di quelli che siamo disposti ad ammettere, ed è il confronto con il timore di essere diventati esattamente come loro. Se esistesse una gerarchia dei dubbi esistenziali più gravosi, questo sarebbe sicuramente tra i primi, al pari di chiedersi quanti universi ci sono. La prima volta che mi è capitato di accorgermi di star facendo qualcosa come i miei genitori è stato in un momento insignificante, mentre mi guardavo le mani. La sovrapposizione delle immagini di me e mio padre si è poi replicata nei gesti con cui sbucciamo la frutta o nel tono di quando ci incazziamo. L’ennesima volta non la ricordo con precisione, so solo di aver pensato: “Cazzo, sembro mia madre”.

Per alcune persone, il momento di riconoscersi uguali ai propri genitori può essere confortante; per altre totalmente desolante. Secondo uno studio, in base alla loro percezione le donne finiscono per assomigliare ai propri genitori all’età di 33 anni, mentre gli uomini lo diventano quando ne hanno 34. Una soglia così precisa che non lascia scampo: il giorno prima cerchi un after, il giorno dopo un corso di bricolage per sistemare finalmente il cassetto della cucina. Facendo un po’ di conti approssimativi, a me mancherebbero millenovecentododici giorni, 165.193.200 secondi, praticamente lo stesso tempo percepito guardando La La Land. I miei non sono cattivi genitori, tutt’altro: ma se per alcuni aspetti non mi dispiacerebbe assomigliare a loro, per altri – forse molti – lo eviterei volentieri. La mia sensazione è che questa sia una consapevolezza tanto comune quanto taciuta, perché ogni critica fa subito passare dalla parte degli “ingrati” e poi a causa di una sorta di buoncostume di cui ancora non siamo riusciti a liberarci, perché della famiglia si parla solo tra le mura di casa.
In una scena del film The Breakfast Club del 1985, Andrew, uno dei ragazzi riuniti in biblioteca per punizione, chiede sgomento se siamo destinati a diventare come i nostri genitori, mentre Claire, sull’orlo delle lacrime, si rifiuta di accettare quell’idea. “È inevitabile”, risponde serafica Allison. “È inevitabile”. Anche mia madre lo ripete sempre. Da adolescente uno pensa di potersi ribellare, di essere capace di creare un sé completamente diverso, ma più diventiamo adulti più la possibilità che sia davvero inevitabile sembra farsi concreta. Non serve essere cresciuti con una madre che urla istericamente “Niente grucce di ferro” per voler cambiare le cose. Anche nelle migliori famiglie, infatti, sin da bambini abbiamo familiarità con i difetti dei nostri genitori, con ciò che ci ha fatto male o ci è mancato, e quindi vorremmo poterlo non ripetere. L’intenzione che ci impegna gran parte della vita, allora, è essere diversi. Percorriamo strade opposte, cerchiamo di fare il contrario, fino a che, un giorno, non ci accorgiamo di ricalcare proprio gli aspetti del carattere che avremmo voluto evitare e non ci capacitiamo di come sia potuto succedere. “Cazzo, sembro mia madre”. Il punto nel riconoscere come i loro tratti influenzino il nostro comportamento non è per biasimarli o rimanere invischiati nel passato. Piuttosto, è per acquisire una migliore consapevolezza di sé, dare un senso più autentico alle nostre azioni e rivalutare cosa significhi essere figli prima ancora che genitori.

Che la relazione con i nostri genitori abbia un impatto su chi siamo è inesorabile. Dall’idea freudiana per cui la personalità adulta si sviluppi a partire dalle prime esperienze d’infanzia alla teoria dell’attaccamento e alla psicologia dello sviluppo, le modalità con cui la famiglia – biologica o meno – condiziona il nostro modo di stare al mondo sono a lungo state approfondite dal secolo scorso a oggi, e hanno a che fare principalmente con due elementi: la genetica e l’ambiente. Circa il 40% dei tratti della personalità di una persona deriverebbero infatti da geni ereditati – alcuni studi stimano dal 30% al 60%, anche se ne sono stati identificati pochi finora –, dalle loro combinazioni e variazioni. Ciò lascia però spazio a una notevole influenza da parte dei fattori ambientali, come il luogo dove si vive, le prime esperienze, l’esposizione a determinati modelli. Le neuroscienze suggeriscono infatti come ciò che viviamo nei primi anni di vita possa modellare il modo in cui pensano i bambini (e gli adulti che diventeranno), contribuendo allo sviluppo dei meccanismi biologici utili all’elaborazione e all’interpretazione della realtà, arrivando a influenzare i circuiti cerebrali. D’altronde, la maggior parte dell’apprendimento da bambini avviene per imitazione di ciò che fanno i nostri genitori: a lungo, il più delle volte, loro sono l’unico modello disponibile di cosa significhi essere adulti e il primo filtro attraverso cui facciamo esperienza del mondo.
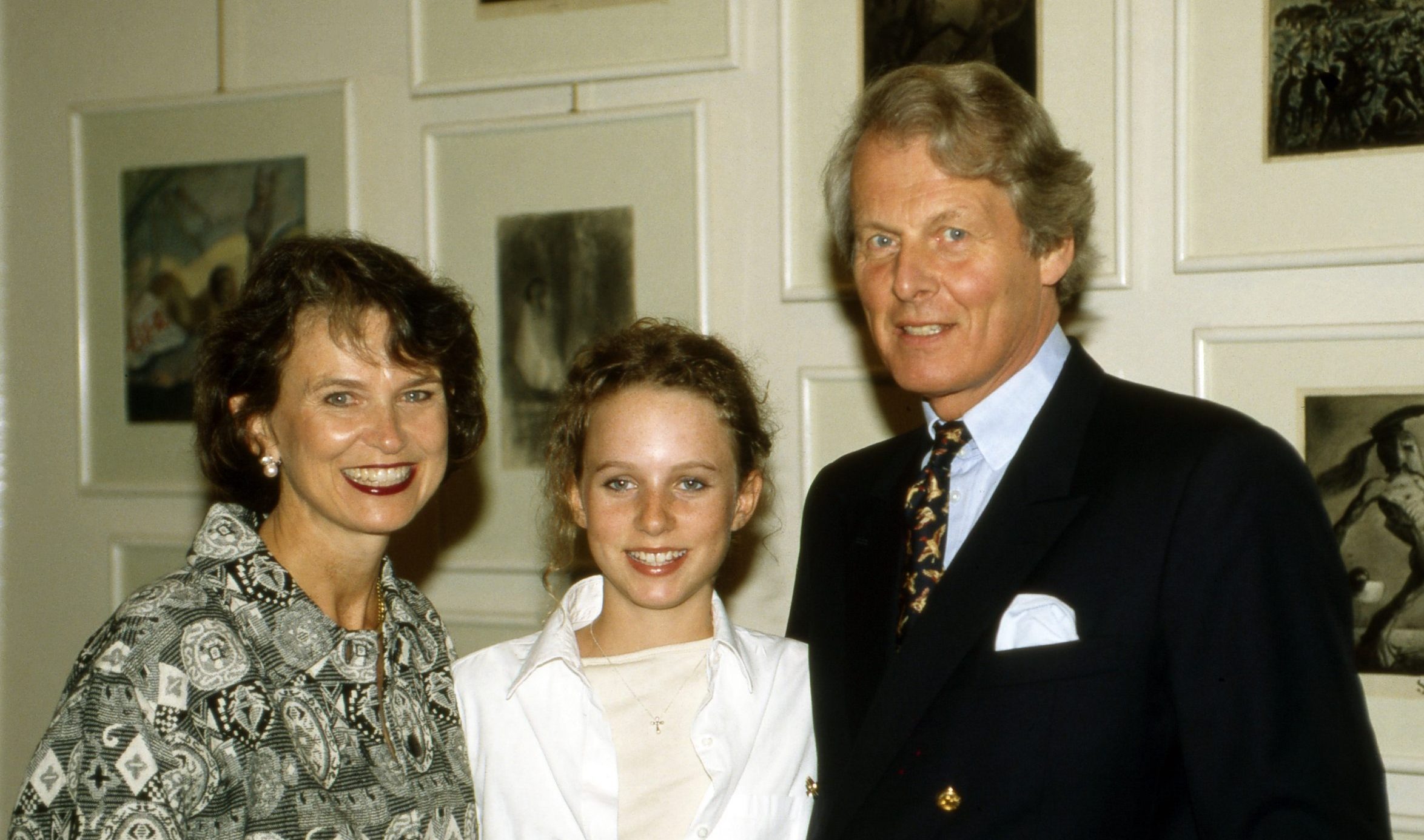
I modi in cui replichiamo o meno le maniere considerate accettabili di comportarsi, parlare e persino pensare, così come l’aspettativa di cosa dovrebbe essere la vita, trasmessi dalla nostra famiglia sono principalmente tre: replicativi, quando li ripetiamo consciamente o meno; correttivi, se scegliamo consapevolmente di fare le cose in modo diverso od opposto ai copioni che conosciamo; improvvisati, nascono con la necessità di affrontare nuovi contesti, come può avvenire con un’innovazione tecnologica. Pur rendendoci conto, in precisi momenti, di star diventando esattamente come nostra madre o nostro padre, la maggior parte dei comportamenti avviene a livello inconscio o quando siamo stressati e in difficoltà, perché replichiamo, come una scorciatoia, ciò che più ci è familiare. Accade così che spesso, non bastandoci ritrovarli allo specchio, ci portiamo i nostri genitori anche a letto, quando frequentiamo qualcuno che ne incarna il ruolo o nei reitera degli schemi relazionali che abbiamo imparato a scambiare per amore. Strana sensazione uscire con una persona conosciuta su Tinder che, a un certo punto, mentre state per spogliarvi, ti ricorda improvvisamente tuo padre. Oppure, diventando a nostra volta genitori. Nervosi e affaticati dal lavoro, dalle bollette, dal tempo, dal rumore, dalla cena incappiamo in quegli errori che ci eravamo ripromessi non avremmo mai ripetuto con i nostri figli, mentre leggiamo nello sguardo delle nostre compagne o dei nostri mariti una cosa soltanto: “Cazzo, sei diventato proprio come tua madre”.
Come chiunque abbia svolto almeno due sessioni di psicoterapia sa, l’esplorazione del conflitto con i propri genitori è una delle tensioni più importanti per la ricerca di un equilibrio. Madri e padri vengono fatti a pezzi, sezionati, studiati, a volte pure nascosti. Solo metaforicamente, non come nei migliori film di Von Trier. Credo ci sia un punto di svolta per ognuno nella vita in cui si può decidere o meno di venire a patti con quello che sono i nostri genitori, accettandoli anche per tutto ciò che hanno – o non hanno – fatto per noi. Si tratta di capire quanto né essere genitori né essere figli sia un lavoro facile – è una banalità, che spesso però perdiamo nel coinvolgimento emotivo che i rapporti familiari richiedono. Soprattutto, dimentichiamo che magari loro stessi stanno cercando di non essere come i propri genitori – che magari a loro volto hanno fatto lo stesso tentativo, e via indietro in un loop infinito in cui scopriamo che, crescendo, per paradosso la paura più grande alla fine diventa essere come i figli. Ci sono tratti che, di generazione in generazione, finiscono per diventare quasi distintivi di un nucleo familiare, portando con sé preconcetti, paure, risposte ad ansie e imprevisti, ossessioni. Spesso ossessioni: adottare ogni gatto randagio, rubare un asciugamano negli hotel, coprire gli specchi quando si esce.

A volte mi sorprendo a pensare, consapevolmente, come se mi guardassi da fuori: sto facendo questo come mio padre, sto dicendo questo come mia madre. È un misto di soddisfazione e ribellione. Soddisfazione, perché è naturale assomigliare ai propri genitori e sentire un legame, trovare una similitudine, sapere che c’è qualcuno che in mezzo a tutti potrebbe sempre riconoscerci, è confortante. Ribellione, per tutte le ragioni più ovvie e perché la spinta a non voler assomigliare ai nostri genitori, prima che nel tentativo presuntuoso di compensarne gli errori, si risolve nel bisogno di trovare un posto nel mondo, di essere altro da ciò che già conosciamo. Oggi, in cui è ancora più difficile intuire il momento esatto in cui si smette di essere figli – probabilmente mai, davvero –, questa tensione può diventare drammatica. I greci parlavano di charmolypi (χαρμολύπη), un termine che esprimeva una sensazione mista di gioia e tristezza. Forse non diventeremo mai come i nostri genitori o forse siamo davvero destinati a esserlo appena superati i trent’anni. Di certo, se accadrà, potremo sempre dire che era inevitabile. Proprio come fa mia madre.