
Non è certo una novità che, da qualche anno a questa parte, i neolaureati preferiscano cercare un impiego all’estero piuttosto che restare in Italia ad affrontare un mondo del lavoro sempre più difficile e precario. Secondo un rapporto della Commissione Europea, l’Italia, insieme alla Romania e alla Polonia, è tra le nazioni europee che mandano più lavoratori all’estero e, nel caso dell’Italia, più della metà di questi sono laureati. Le cause sono molteplici: le difficoltà di inserimento, dopo la laurea, nel mercato del lavoro, che colpiscono soprattutto i giovani e le donne; la bassa retribuzione, gli scarsi investimenti e la troppa burocrazia. Secondo un report di Confindustria, il nostro Paese continua a pagare un prezzo altissimo per la fuga di cervelli all’estero, stimato intorno ai 14 miliardi di euro l’anno. Nonostante le agevolazioni fiscali previste dal governo, per chi decide di tornare in patria la situazione non sembra cambiare, anche se nell’ultimo anno, sotto la spinta della pandemia e dello smart working, molti italiani residenti all’estero sono rientrati, pur continuando a lavorare per aziende straniere. Inoltre, il danno economico provocato dalla pandemia continuerà a lungo, e questo porterà, inevitabilmente, a nuove ondate di emigrazione nei prossimi anni, a meno che non si decida di invertire la rotta, attuando una profonda riforma strutturale e culturale che semplifichi gli aspetti burocratici e garantisca la trasparenza. Una riforma di cui si sente il bisogno da tempo.
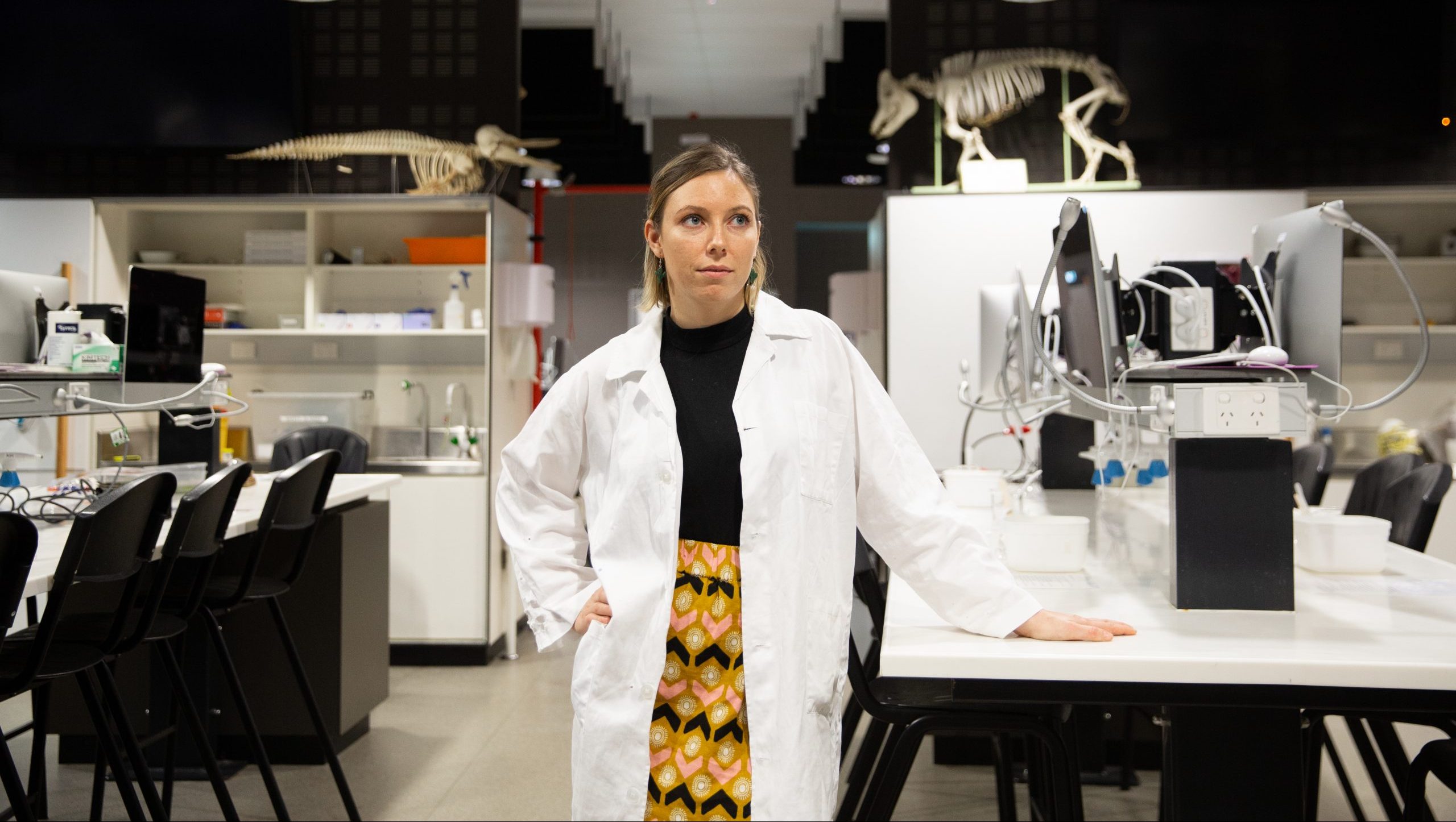
Oltre al danno economico, la perdita di giovani lavoratori è ovviamente anche un danno culturale per il Paese, che non riesce a progredire, e questo è ancora più vero per il mondo della ricerca e dell’innovazione, che resta tra i più penalizzati. Mai come ora sarebbe fondamentale per il nostro Paese, condannato da sempre a fanalino di coda mondiale a causa della scarsità di fondi stanziati, investire in modo cospicuo nella ricerca. Secondo l’ultimo rapporto Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), i fondi destinati alla ricerca in Italia nel 2018 sono stati pari all’1,32% del Pil, al di sotto della media dei Paesi Ocse e dei Paesi europei, rispettivamente al 2,36% e al 1,95%. Nel 2018 i fondi complessivi destinati alla ricerca ammontavano a circa 2,3 miliardi di euro, circa 406 euro per abitante, contro la media europea di 656 euro, e di queste risorse solo il 20% è destinato alla ricerca medica. In più, secondo l’Annuario scienza, tecnologia e società 2020, pubblicato ogni anno da Observa – Science in Society, sui 561 progetti finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020, nessuna istituzione italiana compare tra le prime dieci che beneficiano dei finanziamenti.

Secondo il Libro bianco sulla ricerca clinica indipendente, realizzato da Fondazione Fadoi e Fondazione Roche, i governi italiani hanno sempre investito percentuali di Pil significativamente inferiori rispetto al resto dei Paesi economicamente sviluppati. Tuttavia, i ricercatori italiani appaiono produttivi e in grado di competere con comunità scientifiche che hanno accesso a più fondi sia pubblici che privati: questo si è verificato soprattutto lo scorso anno, quando l’Italia, epicentro iniziale dell’epidemia in Europa, ha prodotto numerosi e importanti studi sul Covid-19, le sue caratteristiche e i suoi effetti. Gli scienziati italiani compaiono infatti in un articolo su dieci riguardanti le procedure di sicurezza per il personale sanitario, le implicazioni della malattia e i suoi legami con le malattie cardiovascolari e il diabete, diventando anche un esempio per i network di ricerca internazionali, come è stato per lo studio condotto a Vo’ sulla percentuale di asintomatici, pubblicato su Nature.
Nonostante questo, il sistema italiano della ricerca clinica ancora non suscita l’interesse di sponsor privati. L’Italia, infatti, non gode di una percezione favorevole, stante un indice di “desiderabilità” come sede di sperimentazioni cliniche, che la vede dietro a Germania, Olanda, Regno Unito, Belgio, Francia e Spagna. In Italia arriva a malapena la ventesima parte del budget investito dalle imprese farmaceutiche per diversi motivi, il primo dei quali è l’eccessiva burocrazia. Secondo uno studio di European House Ambrosetti, infatti, in Italia ci sono ancora troppi limiti di natura burocratica: per avviare uno studio clinico sono necessarie diciassette settimane, contro le cinque del Regno Unito e le nove della Germania. Inoltre, i progetti devono passare una lunghissima fase di approvazione e gli ospedali e i comitati etici operano sulla base di modelli di valutazione non standardizzati. Ci sono poi le numerose incertezze normative e organizzative, ma soprattutto la mancanza di investimenti pubblici per potenziare e valorizzare la costruzione di infrastrutture dedicate alla ricerca clinica.
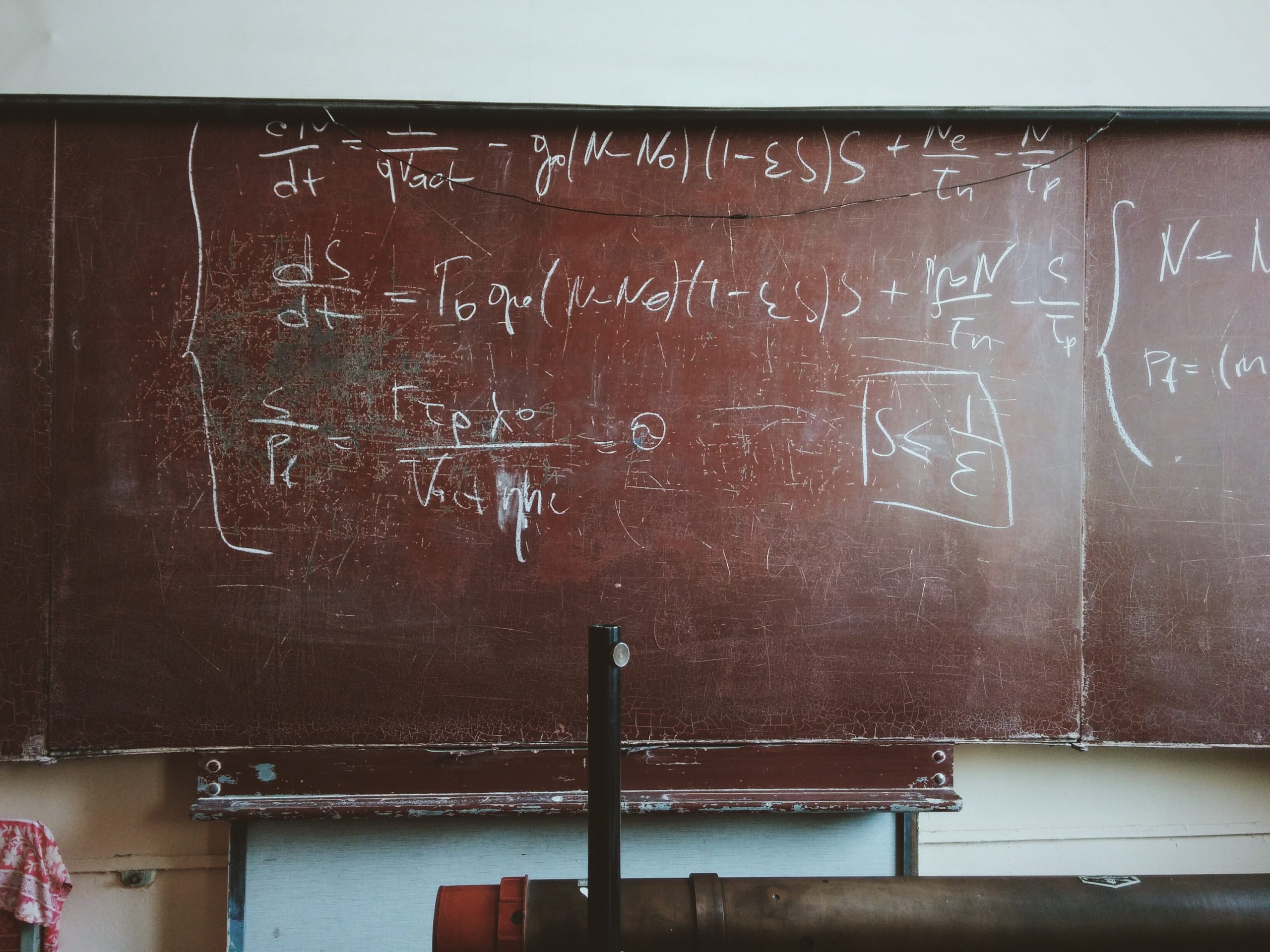
Quello delle infrastrutture è un altro grave problema, che sta emergendo proprio durante questa campagna vaccinale. Rispetto ad altri Paesi europei, infatti, l’Italia è ancora piuttosto indietro con le somministrazioni, principalmente a causa della mancata consegna di numerose dosi promesse dai produttori. Sarebbe tutto più semplice se, a produrre i vaccini, fossero aziende italiane, ma non è facile come sembra: mancano infatti i bioreattori, dispositivi in grado di fornire un ambiente ideale per la crescita di microrganismi e gli impianti di alcune case farmaceutiche dovrebbero essere riconvertiti, ma ci vogliono tempi troppo lunghi per risultare utili. Secondo Piero di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di Irbm, tra la riconversione degli impianti, l’acquisto e la messa in opera dei bioreattori e l’addestramento del personale potrebbe volerci quasi un anno. Troppo, vista la situazione. In Italia, inoltre, il tanto pubblicizzato vaccino ReiThera, che nelle previsioni iniziali avrebbe dovuto accelerare la campagna di vaccinazione di massa, è invece ancora alle prese con la seconda fase di sperimentazione sui volontari. Il capitale umano è un fattore importantissimo, e l’emigrazione dei giovani ricercatori può, nel lungo periodo, danneggiare l’industria farmaceutica, soprattutto in un periodo come questo, nel quale invece questa dovrebbe funzionare al meglio.
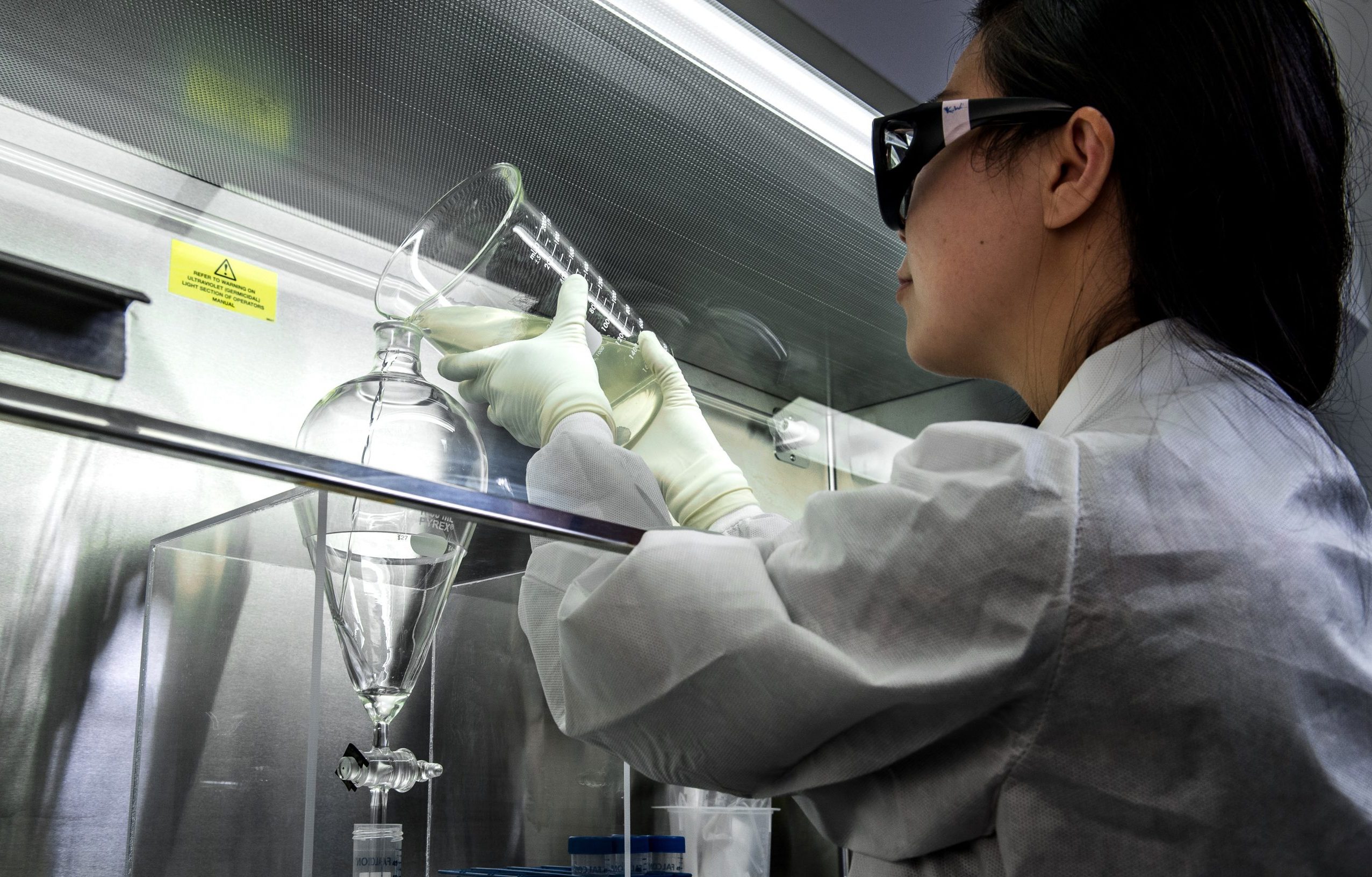
“L’industria farmaceutica è un valore economico, sociale e scientifico del Paese. E in questi mesi lo ha dimostrato ancor di più, collaborando in una logica di partnership con le istituzioni e gli altri attori del sistema salute. E ha quindi confermato, sul campo, di costituire un asset strategico per la crescita dell’Italia”, ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. “In un quadro favorevole di regole e con una burocrazia più snella, le imprese del farmaco sono infatti pronte a investire oltre 4 miliardi di euro nel periodo 2021-2024, ossia circa 2,5 miliardi in ricerca e innovazione e oltre 1,5 in produzione. Investimenti in partnership-pubblico privato, che sono rapidamente cantierabili e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E che possono portare a un aumento dell’occupazione: 8mila addetti diretti in più che arrivano a 25 mila considerando l’indotto”.

La ricerca clinica, oltre a essere un’importante occasione di crescita culturale, rappresenta un volano per lo sviluppo e la crescita economica di un Paese. Per questi motivi è importante che il valore della ricerca sia adeguatamente percepito sia dalle Istituzioni, sia dalla cittadinanza. Investire in ricerca significa investire sul futuro e nei giovani, nelle loro competenze e capacità. La ricerca medica in Italia è uno dei vanti del nostro sistema sanitario, ma i dati sono chiari: gli investimenti sono insufficienti e gli strumenti troppo complessi. Bisognerebbe quindi che il governo stanziasse più fondi, che questi fondi venissero spesi meglio e che gli strumenti venissero resi più semplici ed efficienti. Purtroppo la strada da fare è ancora lunga.
