Il cinema del nostro Paese ha a lungo descritto la Prima guerra mondiale come il momento storico in cui l’Italia si trasformò in una Nazione unita, anche se usare il racconto romanzato di questa guerra per costruire un sentimento di identità nazionale è pericoloso e poco onesto intellettualmente. Uno degli ultimi tentativi in questa direzione fu I cinque dell’Adamello, un film retorico e invecchiato male, uscito nelle sale nel 1954 che vede come protagonisti cinque alpini che dovrebbero rappresentare le diverse anime del Paese, finalmente unite. Il loro sacrificio viene esaltato nel finale, quando un giovane si rende conto di quanto quell’impresa sia servita a “fare gli italiani”.
I cinque era solo l’ennesimo tentativo di dare respiro epico a un conflitto che di epico non aveva avuto nulla, ma per fortuna il cinema italiano iniziava a dare i primi segni di quella sua grande abilità di smitizzare gli eventi. Se il cinema americano aveva la capacità di rendere tutti eroi per un giorno, quello italiano si dimostrava bravissimo a fare il contrario, mettendo in evidenza la dimensione umana e più vulnerabile di chiunque. Il primo che ebbe il coraggio di congedare l’idea del primo conflitto mondiale come mito fondativo italiano fu Mario Monicelli, con La grande guerra. Il film uscì nei cinema nel 1959, solo cinque anni dopo I cinque dell’Adamello, e raccontò la tragica realtà di quel conflitto: la Grande guerra non aveva avvicinato gli italiani ma piuttosto li aveva fatti prendere coscienza delle loro differenze. Durante la prima guerra mondiale si erano acuiti i campanilismi ed erano nati gli stereotipi che per anni hanno impedito un dialogo proficuo tra nord e sud. E dopo neanche cinque minuti di film, ci troviamo di fronte a un personaggio che non si fa problemi ad affermare: “Da Parma in giù, tutti romani e camorristi”. Come ricordava Monicelli, era d’altronde impossibile che da una simile guerra potesse emergere un’identità culturale comune: “L’Italia all’epoca del primo conflitto era un Paese del quarto mondo, popolato da un 70% di analfabeti che non sapeva né dove stesse combattendo, né il motivo”.
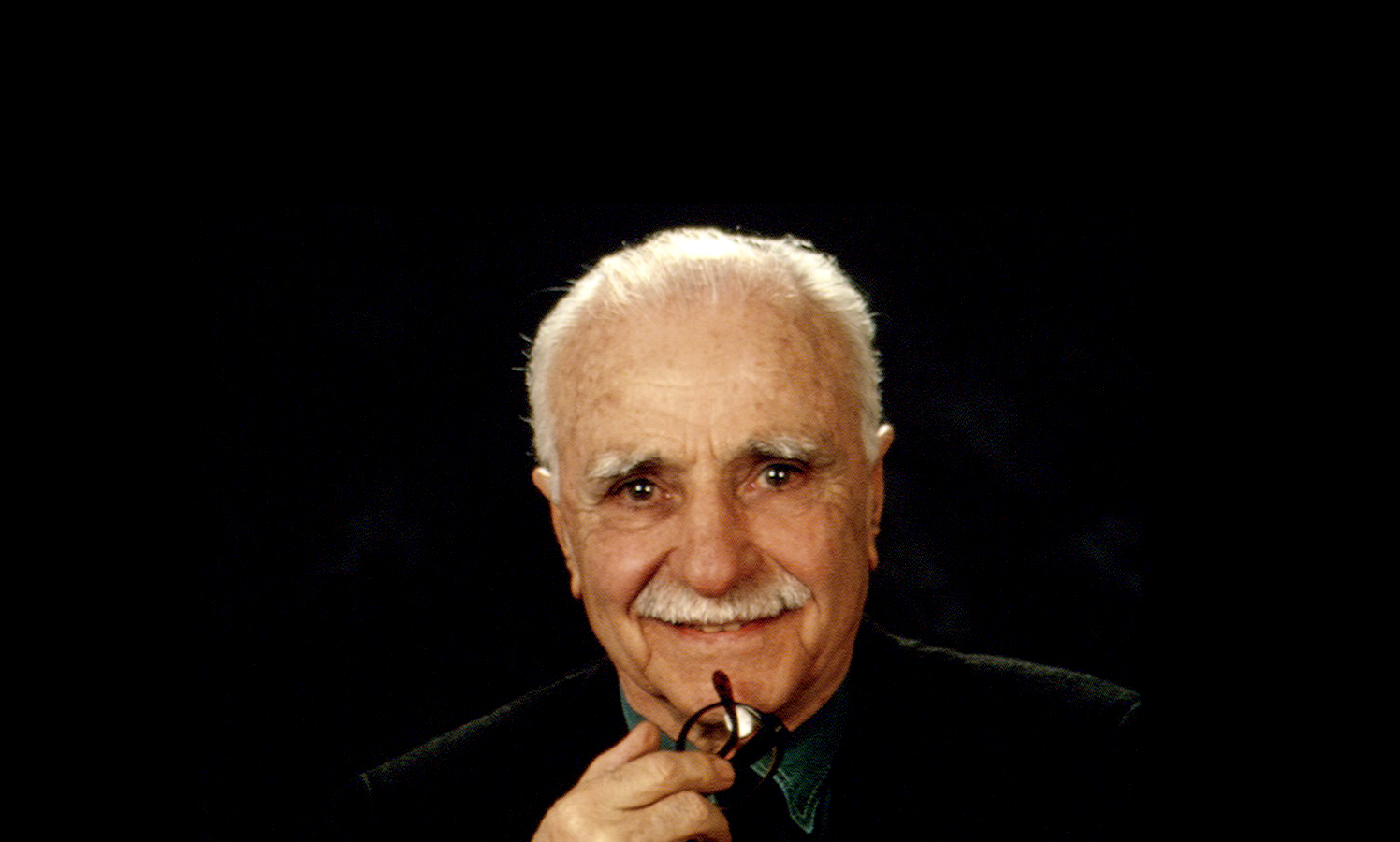
In un simile contesto, al massimo poteva conservarsi la saggezza popolare, espressa a colpi di proverbi e luoghi comuni: “Il milanese in fanteria e il romano in fureria”, dice Giovanni (interpreatato da Vittorio Gassman) a Oreste (interpretato da Alberto Sordi) durante il loro primo incontro. Giovanni prima mette in dubbio la moralità dell’altro con questa battuta, ma poi è lui stesso a provare a corromperlo per evitare la leva. I due protagonisti, si capisce subito, sono antieroi interessati solo a sopravvivere a qualsiasi costo e con ogni mezzo a disposizione. Monicelli cancella immediatamente la dimensione eroica degli italiani in guerra. Giovanni Busacca e Oreste Jacovacci diventano simboli di una generazione che non è mossa da alcun amor di patria o ideale: sono semplicemente due imbroglioni fregati da potenti ancora più furbi di loro. Il primo, appena uscito di galera, non ha di fatto nessuna alternativa all’arruolarsi mentre il secondo, che pure è un imbroglione, si è fatto però a sua volta abbindolare dalla propaganda, che prometteva una guerra breve ed eroica.
Lo sceneggiatore Luciano Vincenzoni adattò il racconto di Guy de Maupassant “Due amici”, spostando la storia dalla guerra franco-prussiana del 1870-1871 alla prima guerra mondiale. Vincenzoni aveva preso dallo scrittore francese lo spunto iniziale: due uomini diventano soldati loro malgrado, vengono catturati dal nemico e si rifiutano di fare le spie, morendo per la loro eroica scelta. Vincenzoni però cambiò profondamente il significato della storia, facendo sì che i due diventassero amici solo una volta diventati soldati, ma soprattutto, a differenza dei due personaggi di Maupassant, negando loro qualsiasi viaggio di trasformazione interiore (tipica del cinema hollywoodiano). Pur condividendo apparentemente la stessa fine, infatti, nel film di Moncielli non c’è catarsi, la morte dei due soldati prova fino alla fine la loro misera condizione umana, con Oreste che viene fucilato urlando: “Io sono un vigliacco”.



Una volta al fronte, Jacovacci e Busacca cercano semplicemente un modo di esorcizzare l’incubo che stanno vivendo e lo trovano concentrandosi sulle piccole necessità quotidiane: Monicelli suggerisce già questo tema, soffermandosi già nei titoli di testa sui piccoli dettagli, e poi decide di far trasparire i loro sentimenti attraverso gesti apparentemente insignificanti. I personaggi de La grande guerra non si comportano in fondo troppo diversamente dai protagonisti di un altro capolavoro di Monicelli, Amici miei. L’ultima compagna del regista, Chiara Rapaccini, descriveva infatti questi ultimi come: “vitelloni che cercano di non pensare alla vecchiaia e alla morte, rimuovendo la realtà delle loro vite a volte miserabili e giocando come bambini”. È forse per questo che i personaggi di Monicelli sembrano mantenersi tanto attuali: gli italiani di oggi non sono poi tanto cambiati. Come i loro contemporanei del 2019, anche loro sembrano bloccati da una perenne paura di maturare e si allontanano sistematicamente dalle grandi questioni: cercano interpretazioni semplici e infantili, tenendosi così a distanza da una pericolosa realtà che non saprebbero gestire.
Il problema è che comportandosi così si anestetizza la propria umanità e si diventa insensibili a qualunque bruttura. Ne La grande guerra, Monicelli piazza assieme al parterre di sceneggiatori (oltre a Vincenzoni ci sono Age e Scarpelli) alcune scene che servono proprio a evidenziare questo rischio: già all’inizio del film, un piano-sequenza mostra un gruppo di soldati che marcia impassibile mentre sullo sfondo si assiste alla fucilazione di un nemico e in questa scena è già racchiuso il tema che ritornerà per tutto il film. La scelta del regista è quella di rinunciare a rappresentare liricamente la morte: tutto scivola via velocemente, quasi come se il trapasso fosse un incidente di percorso. Come fa notare Giuseppe Ghigi: “L’orrore diventa normalità, la compassione svanisce, il soldato si disumanizza”.


In un’altra scena, i due fanti italiani si accapigliano per decidere se ammazzare subito l’ignaro nemico austriaco o fargli finire il caffè. Lo straniero è visto come una preda, non è più importante della gallina che gli stessi soldati si sono contesi in un altro episodio inizialmente tagliato. I personaggi non si confrontano mai col dramma della guerra, non guardano mai in faccia la morte. E Oreste, scioccato dalla morte dell’amico e dalla tangibile possibilità di seguire la stessa sorte a breve, alla fine dirà: “Ma che siete matti? Ma che si ammazza così la gente?”. Queste situazioni, in bilico tra la tragedia e la farsa, spesso vengono prese tali e quali dalle memorie di chi il ‘15-’18 l’ha vissuto davvero. Una delle fonti da cui si attinse per La grande guerra fu Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu. E se il nome di Lussu non appare nei titoli di coda è solo per scelta della moglie dello scrittore, che stando alla ricostruzione di Monicelli si oppose all’ipotesi di un coinvolgimento diretto del marito. A spaventare i Lussu erano state soprattutto le polemiche che avevano investito il progetto di Monicelli, prima ancora che si tramutasse in un’opera cinematografica fatta e finita: Paolo Monelli, su La Stampa del 10 gennaio 1959 infatti “accusò la produzione di progettare un film anti-italiano animato dai più retrivi antimiti nazionali”, ma fu soprattutto l’opposizione degli ambienti politici più conservatori e reazionari a mettere a rischio la realizzazione della pellicola.
Per chi era cresciuto con la leggenda degli eroici soldati, pronti a battersi per amore di una patria creata il giorno prima, il film avrebbe rappresentato uno choc, perché mostrava tutte quelle scene che i reduci di guerra si raccontavano da anni di nascosto. Ma ciò che dava forse a molti più fastidio de La grande guerra era il fatto che mettesse al centro della storia un’Armata Brancaleone di personaggi tutt’altro che esemplari. Conteneva battute come: “Va ben, se la patria la dovessero difendere solo le persone perbene, te saludi patria” e nessun interprete di questa commedia veniva alla fine davvero assolto dalle sue colpe. Sta qui forse la maggior differenza col cinema italiano di oggi. Come ha scritto anche il critico Paolo Mereghetti: “Oggi sono tutti buoni o lì lì per diventarlo. Ci si innamora dei personaggi e non li si fa più essere i primi sconfitti”.



Il personaggio di Gassman è lontano dall’essere un uomo da emulare. Ha conosciuto la galera e rappresenta il prototipo dell’italiano furbo e megalomane: parla per slogan, millanta una cultura che chiaramente non ha, cita a sproposito Bakunin e usa le sue poche conoscenze per sbandierare una supposta superiorità. Dice che la sua guerra è contro quei potenti e “imboscati” che in fondo invidia e con cui in realtà ha molto in comune, soprattutto nel modo di pensare. Un prototipo che sembra ripetersi ancora oggi. Sordi ha invece i difetti di un altro tipo di connazionale. Pur di “sfangarla”, Jacovacci è disposto a piegarsi a chiunque: non ha alcun amor proprio, viene giustamente definito “ruffiano” dai compagni ed è ostaggio di mille paure. Resta un codardo fino alla fine e nemmeno il tragico epilogo lo riscatta. Nonostante non riveli le informazioni che gli salverebbero la vita, è lui stesso a supplicare: “Non voglio morire, sono un vigliacco!” Sperando di farla franca. I due protagonisti quindi muoiono, ma non diventano eroi, nessuno conosce il loro sacrificio e se ne vanno da soli, dopo un’esistenza in cui hanno amato poco: l’unica vera storia d’amore del film è quella tra Gassman e la prostituta Mangano, anche lei una sconfitta dalla vita..
Il film sembra dirci che se l’identità nazionale nasce in trincea, tra le sofferenze, non bisogna vantarsene ma al contrario capire che è proprio quella l’origine dei problemi: lì nascono le diffidenze, lì si impara a guardare con sospetto chi parla anche solo con un accento diverso. In trincea, si sta insieme ma si pensa sempre in primis alla propria sopravvivenza e forse è per colpa di certi retaggi che l’italiano fa ancora tanta fatica a capire l’importanza di un concetto come quello di “bene comune”.
La grande guerra è un capolavoro che racconta molto di quanto terribile sia la guerra e quanto sia stupido utilizzarla come mito positivo. È anche e soprattutto un importante film sull’Italia, riscattata sempre da grandi imprese individuali ma al contempo incapace di produrre rimarcabili sforzi collettivi.