
Si è già detto tutto sulla serie Netflix BoJack Horseman. Il cavallo umanizzato star di una tv fatta di sit-com che non esiste più, fotografato in una parabola declinante di rimpianti, rimorsi e cattive abitudini. Figlio ripudiato di una madre anaffettiva e castrante, rimasto solo con la sua patologica necessità di affetto e con l’ombra della fama passata. Si è già detto tutto, tranne una realtà drammatica e intuitiva: Bojack Horseman non doveva sopravvivere all’ultimo episodio della serie. Bojack Horseman doveva morire.
Dove è passato Bojack non cresce più niente: nel migliore dei casi la sua presenza è sufficiente a rovinare la vita di una cerbiatta, disturbandola al punto da causarle attacchi di panico e strappandola a un’adolescenza serena in una famiglia che ricorda lo stereotipo del Mulino Bianco. Nel peggiore dei casi invece, il cavallo stronca ciò che non è mai cresciuto davvero, come l’ex collega attrice e popstar affermata Sara Lynn, uccisa dalla droga quanto dal suo spacciatore equino, diavolo tentatore e galeotto consigliere. Bojack è la cattiva compagnia che si ha la sfortuna di conoscere a scuola, a lavoro, in chiesa. La sua ricchezza in apparenza lo esonera dalla ricerca di rapporti di convenienza e quindi risulta meno spaventoso di un povero bisognoso: tuttavia si insinua nella vita dei suoi conoscenti e ne assorbe la linfa vitale, portandoli in un ripido vortice di autodistruzione.


Commovente e dilaniante, è impossibile non affezionarcisi, perché ne siamo troppo coinvolti. C’è del BoJack in tutti noi, nelle nostre scelte coscienti fatte sapendo di sbagliare, nei nostri fallimenti, nella nostra incostanza. La sua sprezzante ironia non è altro che un palliativo poco efficace contro il sabotaggio di ogni tipo di relazione, interazione e condivisione autentica. L’avventura di BoJack è un manifesto ben riuscito della solitudine dei nostri tempi, senza più antidoti e quindi curata con soluzioni a buon mercato, tanto facili quanto inutili.
La sesta e ultima stagione sembra partire in sordina, quasi a volersi disimpegnare dai temi delle serie precedenti. Sembra ammantata di una strana calma, quasi insignificante. Gli anni sulle spalle del protagonista sembrano appiattire tutta la sua esistenza e la superficiale saggezza guadagnata non sembra essere altro che la prudenza stagnante di un cavallo di mezza età, conscio di non avere più troppe occasioni da buttare e di essere seduto sul confine tra una vita più morigerata e una fine terribile. Quindi si tiene impegnato in una routine di disintossicazione, ridimensionamento delle prospettive e buoni, tranquilli propositi che ci portano a guardare un nuovo-vecchio BoJack sperando di vederlo fallire. Sapendo che fallirà. Tifando per il massacro di una marionetta schiava dei suoi sbagli, di un equilibrista che cattura l’attenzione non per abilità o destrezza ma per la speranza di vedere le sue rovinose cadute.

Nel frattempo, Princess Carolyn adotta una figlia, trova un equilibrio tra vita privata e lavoro e persino l’amore. Diane combatte contro la depressione, prende 20 chili e scrive romanzetti, ma riesce a essere felice insieme a un nuovo compagno. Todd recupera il rapporto con la madre e diventa un adulto, cambiando casa, con un lavoro diverso e una nuova compagna. Queste tre esistenze, tutte a loro modo tormentate, hanno un punto in comune: l’allontanamento da BoJack da un’aria avvelenata, sempre uguale a se stessa, che si cela dietro una cortina di fama e successo.
Perché BoJack è la dieta senza sgarri che inizierà domani. La sveglia alle sei per andare a correre tutte le mattine, ma con l’arrivo dell’anno nuovo. È la litigata con tua madre che avresti potuto evitare. È la mancanza di metodo e impegno che casualmente riesce a combinare qualcosa per poi raccontarsi e raccontare che è stato “talento”, quando invece sa di essere solo frutto della fortuna, destinata a morire rapidamente senza il carburante della perseveranza.

Il futuro non è di BoJack Horseman ma è di Mr. Peanutbutter, del suo sorriso superficiale, dell’instancabilità, dell’ottimismo insensato, degli errori fatti alla leggera senza conseguenze. La gente vuole un lieto fine, dove anche nella durezza della separazione tutti vivranno felici e contenti, dove ognuno avrà ricevuto la sua lezione da imparare e tramite una dura ma giusta redenzione troverà nuova linfa. Un domani in cui i rapporti saranno semplici e nessuno si farà male davvero, mai in maniera definitiva. L’inquietante felicità che il cane possiede senza mai riuscire davvero a trasmetterla è il definitivo salvataggio delle apparenze, in un mondo formale e freddo che conserva come unico valore il lucidare i pomelli di una nave che affonda. Tutto ciò che è tormento, introspezione e ricerca non sfiora mai Mr. Peanutbutter. Il cucciolo cresciuto di Labrador ha una gioia intrinseca, incomprensibile e fastidiosa, ma che regala anche serenità e un barlume di ottimismo. È il prodotto glitterato della saggezza da social, dell’edonismo delle storie su Instagram e dei balletti su Tik Tok. Il futuro è di Mr. Peanutbutter e per questo Bojack Horseman doveva morire solo, povero e irrisolto.

Non c’è redenzione in un mondo che inchioda al passato chiunque non sia rapido a reinventarsi ancora e ancora. Non c’è assoluzione per un cavallo incapace di perdonarsi e di evolversi, troppo attaccato e affezionato ai suoi difetti per apprezzare veramente i tentativi di affetto di cui diventa oggetto. Non è più in grado neanche di produrre dei buoni propositi, ma è solo un derelitto incapace di affrontare le più semplici sfide in cui inciampa. Diventa ridicolo persino nel cercare l’affetto di una sorella ben disposta anche se mai presa in considerazione. È patetico, moscio e appiattito, ma, colpa ancora più grave in un mondo-vetrina, è ridicolo ed esteticamente obsoleto. BoJack è sull’orlo dell’abisso, sapendo che non c’è niente dall’altra parte. Fugge e si dispera, ma poi si rassegna al suo destino grazie a una telefonata con Diane. Questa è la vera fine di tutto ciò che mr. Horseman rappresenta, della sua vita infelice coronata di un successo effimero e inutile. Questa era la fine che i personaggi del cartone animato e il pubblico si meritavano. Perché in questa serie l’epilogo non poteva che essere drammatico, ineluttabile ed eterno. L’angoscia e la paura del nichilismo accumulati episodio per episodio, stagione per stagione, non potevano che portare a un’ultima riflessione: non c’è risposta al nulla di cui BoJack è interprete e verso cui si proietta.
Alla fine, sotto il canone della sit-com, tutto si risolve per il meglio, anche se non del tutto. Todd si è evoluto e ha risolto i suoi problemi relazionali. Diane è serena al prezzo di una sedazione farmacologica che le le permette di mantenere l’equilibrio, ma la svuota del tutto. Princess Carolyn è felice con un uomo ai limiti della perfezione e sua figlia adottiva, nella cornice di un lavoro di successo. Mr. Peanutbutter è il solito ottimista indistruttibile, capace di incassare divorzi e fallimenti come fossero medaglie al merito. Per BoJack le cose forse andranno meglio, ma siamo tutti sicuri, cavallo compreso, che tutto per lui sarà solo una copia di una copia, un pallido ricordo del passato. E che ogni giorno non sarà altro che un tentativo di distrarsi nella speranza di allontanare il pensiero della fine già vissuta. Reale, inesorabile e inevitabile.
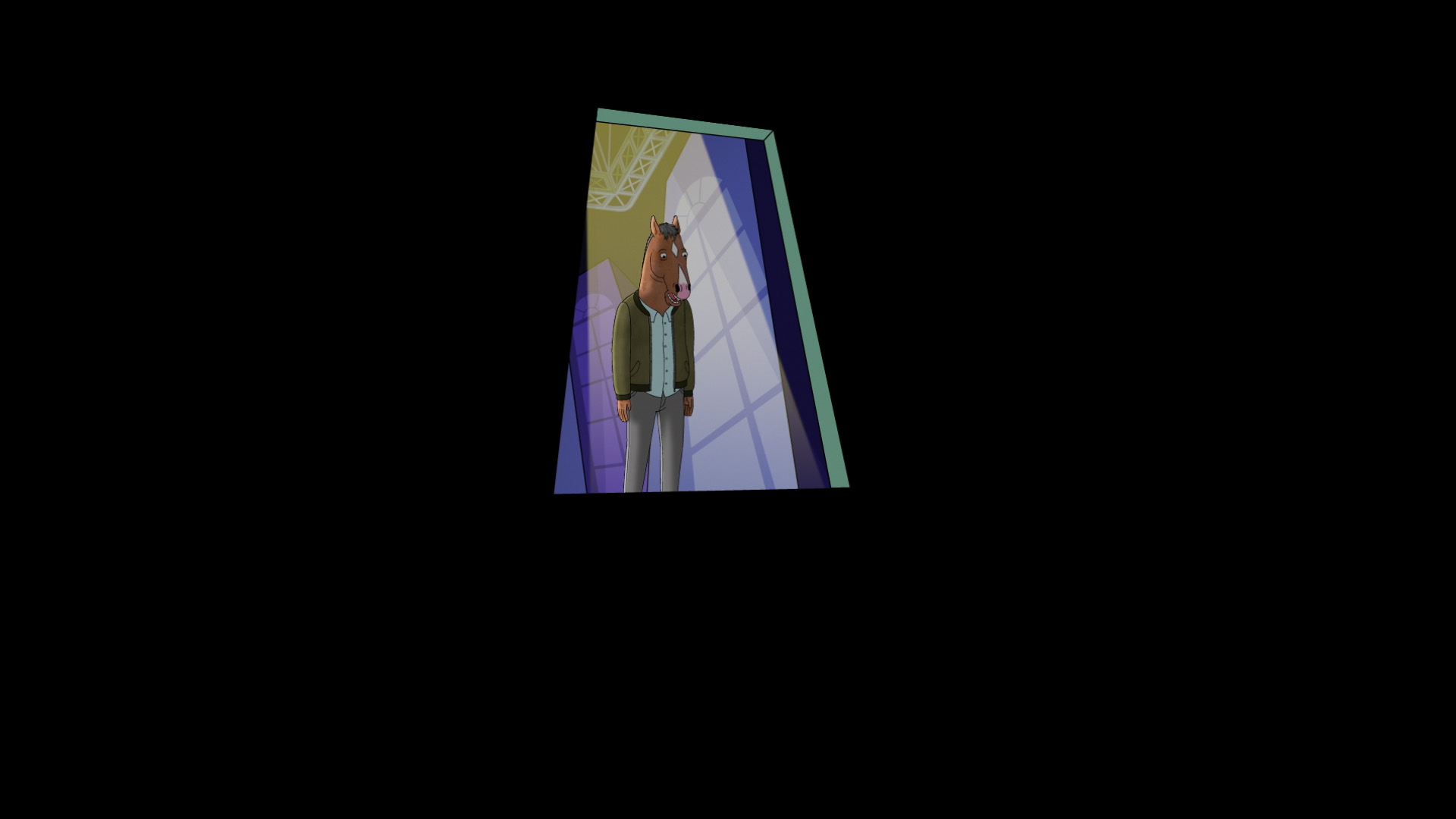
BoJack doveva morire perché era già morto, dalla prima puntata della prima serie. Le sei stagioni non sono altro che un lento tirare avanti di una bocca che non ha più nulla da dire, una testa che non ha più nulla da pensare, alla ricerca di risposte a domande sbagliate. Sorrideremo pensando alla serie, a un lieto fine che sa di dolcificante più che di zucchero: efficace sicuramente, ma con un retrogusto fastidioso e artefatto, feticcio incompleto di un sapore troppo ostico da proporre in una serie animata. Tra gli applausi per l’opera, rimane di BoJack una vaga angoscia che tutti i suoi amici stretti hanno imparato a lasciarsi scivolare addosso. Ma noi decisamente no.
