La sindrome di Fonzie, ovvero non riuscire a pronunciare la frase “ho sbagliato”, è più comune di quanto si possa immaginare. C’è chi però ne ha fatto un tratto distintivo, abbeverandosi nei recipienti dell’egotismo. Il suo nome è Matteo Renzi.
Dopo sonore batoste come il referendum costituzionale e le elezioni del 4 marzo, molti politici si sarebbero affidati all’antica arte del cospargersi il capo di cenere, analizzando gli errori e cercando eventuali soluzioni; altri avrebbero optato per la partenza in direzione Honolulu, per non fare più ritorno. Renzi si è invece arroccato nella sua Fortezza Bastiani, prendendo il ostaggio l’intero partito.

Quello che l’ex-premier rivendica da mesi, spesso con ingiustificata tracotanza, è un lavoro politico che non è stato capito né dai suoi colleghi, né dagli avversari, né dai cittadini. Analizzando i dati del suo governo, compresa la parentesi di Gentiloni, in effetti viene fuori uno scenario tutt’altro che catastrofico. Paradossalmente è stata l’esperienza politica migliore – o la “meno peggio” – dell’ultimo ventennio. Nonostante alcuni errori evidenti (l’articolo 18, la vicinanza a un certo liberismo distorto, qualche falla nella Buona scuola, il ruolo della Boschi e le presenze nefaste di Alfano e Verdini) sono stati raggiunti dei risultati tangibili. Il Paese veniva dall’ultimo governo Berlusconi-Lega, ovvero dal collasso, dall’austerity lacrime e sangue di Monti e dalla brevissima comparsata di Letta. Servivano le riforme, invertire la rotta, rialzarsi. Seppur senza raggiungere numeri tali da far gridare al miracolo, il Pil è cresciuto, la disoccupazione è scesa e lo spread è calato notevolmente. Si è lavorato molto sui diritti, con leggi che l’Italia aspettava da decenni: unioni civili, biotestamento e divorzio breve su tutte. Ma la comunicazione è stata disastrosa. Il Pd è stato fatto passare come il colpevole di tutti i mali, nonostante la crescita rispetto ai governi Berlusconi e Monti. E questo non è dipeso soltanto dalla martellante propaganda di Lega e Cinque Stelle, ma dall’incapacità del precedente governo di informare i cittadini. D’altronde non era facile ascoltare un presidente del Consiglio come Renzi, che un giorno si credeva un demiurgo e quello dopo il salvatore della Patria.



La boria dietro ogni gesto ha corroborato le opposizioni ed esacerbato gli animi del popolo. Animi ondivaghi, facilmente mutabili, come il Pd ha provato sulla sua pelle. Una volta detronizzato il nemico, il nuovo governo si sta aggrappando a tutto quello su cui un tempo piovevano gli scaracchi della protesta: l’Ilva non si chiude, gli 80 euro non si toccano, la legge Fornero è ancora intatta, Matteo Salvini fa il gallo sui risultati ottenuti dal predecessore Minniti in ambito immigrazione, la Tav chissà. E ancora il decreto Dignità non ha rimpiazzato il Jobs Act, né ha ripristinato l’articolo 18, le unioni civili restano un punto fermo nonostante i grugniti di tutti i Fontana del governo e sui vaccini permangono le direttive della Lorenzin. Insomma: se Renzi ha fallito non è per ciò che ha fatto, ma per ciò che ha rappresentato. Ovvero il rottamatore di se stesso.

Renzi adesso torna all’attacco. Si presenta tra le macerie della fu Festa dell’Unità e irride gli avversari attraverso le slide, storpia i cognomi dei ministri (“Toninulla” l’avrà riciclato da qualche tweet), parla al futuro senza aver mai metabolizzato il passato, in un presente che non esiste. Il fatto che ci sia un governo raccapricciante non lo giustifica per la mancata espiazione delle sue colpe. È un Raskol’nikov al contrario: ha ammazzato la vecchia (il Pd), ma non si infligge il castigo, semmai costringe tutte le Sonja d’Italia alla visione forzata del suo documentario da novello Alberto Angela. Come in passato, a fregarlo è la narrazione che diventa percezione. La stessa che ha portato il Pd a essere l’espediente di un insulto e i suoi elettori a sentirsi dei “pidioti”.
Se un operaio ha votato Lega al Nord e M5S al Sud, forse era il caso di fare un giretto nelle fabbriche italiane invece di organizzare un tour di conferenze tra i tycoon americani. Se il quadretto di Berlinguer nella sede del Pd è caduto per la disperazione, forse non era necessario calcare la mano candidando Casini a Bologna. Ma per Renzi, ormai, il modus operandi è segnato: per elaborare il trauma ha deciso di rimuoverlo dalla memoria, come se non fosse mai avvenuto. Dunque, non ha mai preso una batosta al referendum, non ha mai portato il Pd al minimo storico alle elezioni e non ha anestetizzato il partito in questi mesi. Negare, negare sempre. Ciò che non lo uccide lo fortifica, senza rendersi conto di essere morto politicamente almeno due volte.

Il 4 marzo è stato l’epicentro di un terremoto le cui scosse si sono avvertite in tutta Italia. Tranne al Nazareno. Nessuno ha staccato la spina; chi invocava l’eutanasia per un partito ormai moribondo, non è stato ascoltato. Gli eventi si sono susseguiti per inerzia, senza uno straccio di progetto: l’arrivo del reggente Martina, politico con tutti i crismi della vittima sacrificale, Renzi che improvvisa tra Senato e Facebook, Gentiloni ibernato, l’impotenza di fronte all’ondata giallo-verde e la conseguente opposizione fiacca, poco credibile. Hanno tutti la faccia delle mucche che guardano i treni passare; nessuno di loro si è fermato ad analizzare i motivi della trasformazione da capotreni a ruminanti.

In fin dei conti Renzi pensa di poter trascendere un limite morale, o quanto meno l’iperbole di un partitocidio, tenendo tutti in naftalina. Ci sarà un congresso, ma chissà cosa ne verrà fuori. Forse il Pd si presenterà alle Europee con un altro nome, o sarà sciolto e poi rifondato (come propone Orfini), ma probabilmente con le solite facce. C’è chi organizza cene tra pochi intimi e poi le annulla il giorno dopo. Lo stesso Renzi ricorre alla strategia dell’accerchiamento: la frase “Pensano di essersi liberati di me, ma si sbagliano,” non è riferita agli italiani o agli avversari politici, bensì a Zingaretti e a tutti coloro i quali auspicano un nuovo nome per il partito – tra questi Cacciari, che senza giri di parole chiede all’ex-segretario di smammare. Nella visione politica di Renzi, i nemici continuano a essere quelli interni: se il Pd è crollato lui addita come colpevoli gli scissionisti, i franchi tiratori, le voci fuori dal coro. Mai se stesso.

Se continua a fare le sue dirette sui social, cambiando la location ma non l’atteggiamento da capo boyscout, è perché la sua mente non ha elaborato la duplice perdita. La perdita del potere: di una leadership sudata alle primarie, confermata sul campo col 40% alle europee e poi smarrita nel giro di pochi anni. E poi la perdita di aderenza su un Paese che gli è scivolato tra le dita con la velocità di un insulto leghista e di una promessa grillina. Eppure il linguaggio e i modi sono gli stessi: ammicca alla telecamera, alterna discorsi da fratello guascone e filippiche da JFK di Rignano; mescola sorrisi per rassicurare le mamme e le nonne e occhiate degne di una televendita. Senza essersi accorto di non aver più nulla da vendere.
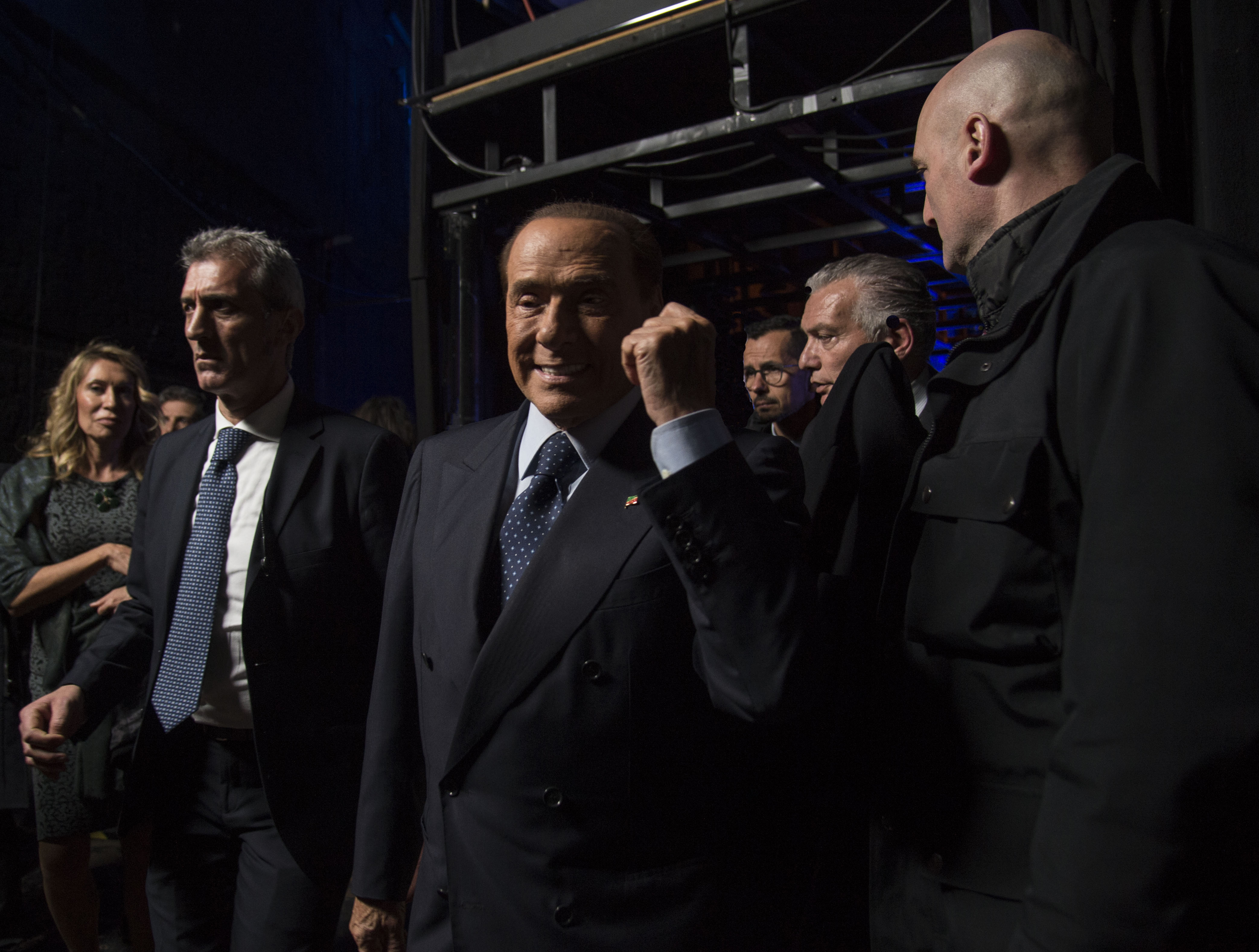
I militanti del Pd non gli hanno mai perdonato la metamorfosi del partito in una succursale progressista (e neanche tanto) di Forza Italia. Se il berlusconismo può considerarsi ormai superato, i suoi tentacoli derivativi appaiono obsoleti e destinati a morire già nella culla. Renzi non l’ha capito, e prosegue nella sua opera di emulazione, nella genesi di un Berlusconi di centrosinistra capace di riunire i fantomatici “moderati”. Intanto il mondo va avanti, Lega e M5S costituiscono – secondo i sondaggi – il 60% dell’elettorato italiano, e i moderati stanno diventando una specie in via d’estinzione come il dodo o il grifone del Bengala. Se Renzi prendesse una conchiglia sulla spiaggia e l’avvicinasse all’orecchio, sentirebbe la voce di un ottantenne emiliano che urla: “Col cazzo che muoio democristiano!”