Nei film di Almodóvar niente è come sembra. C’è tantissima trama, eppure sembra uno di quei film d’essai dove non succede quasi nulla. La trama viene infatti portata avanti dalle immagini e dal montaggio, più che dalle parole. La parola, sollevata da questo compito meccanico, può allora farsi esclusivo significato poetico, così i pochi dialoghi acquistano la forza della rivelazione. Come nelle opere liriche, la parola si fa aria, canto, il progredire della storia è affidato al destino e al direttore d’orchestra, che garantisce che la vicenda venga portata avanti.

In Parla con lei – film del 2002 che vinse l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale e il Golden Globe come miglior film straniero – Almodóvar tratta di temi estremamente complessi (l’identità sessuale, la malattia, l’abuso) con una stralunata lievità, e con un’ironia che non risparmia nessuno, capace di far sorridere anche nei momenti più tetri. L’inquietudine e lo straniamento restano a lato del fluire della storia, presenti ma molto distanti. Il regista mette in scena un cinema solo in apparenza realistico, invitandoci invece a una maestosa sospensione di incredulità – che sempre meno in questa epoca di fatti siamo disposti a concedere ai narratori. Almodóvar pone in maniera chiara e indubitabile la pellicola come artificio (non a caso il film inizia con il sipario che si solleva sulla vita dei personaggi), in cui ogni tanto la realtà fa il suo ingresso e appare quasi grottesca, fuori luogo, perché interrompe in modo gretto un fluire degli eventi altro, l’unico che sembra ammettere la dimensione dell’ascolto e dell’affetto che si istituisce tra due persone sole.

A partire dal titolo la parola si fa strada a mano a mano dando forma alla relazione di due coppie: quella composta dal giornalista Marco (Darío Grandinetti) e Lydia (Rosario Flores), torera che finirà in coma a causa dell’attacco di un toro; dall’altra l’infermiere Benigno e l’ex ballerina Alicia, anch’essa in coma a causa di un incidente. Per la prima coppia la parola sembra un filo rosso che punto dopo punto li lega per poi dividerli: dall’intervista che Lydia subisce in televisione e a cui si ribella andandosene; passando per quella che le chiede di rilasciare Marco e che lei rifiuta, perché intuisce che anche a lui interessa solo il suo modo di essere donna e non il suo modo di uccidere tori; arrivando poi al fiume di parole che lui – non a caso scrittore – le riversa addosso impedendole di esprimere in tempo la sua verità: l’amore ancora vivo per il suo ex; e chiudendosi infine con il silenzio.


Per l’altra coppia, invece, la parola è fin dall’inizio a senso unico: Benigno parla ad Alicia, che non può rispondere, ma che secondo Benigno può sentire eccome. La parola diventa relazione e cura, in primis per chi la rivolge, ma non solo. Benigno è un personaggio borderline, che ci mostra quanto può essere sottile il confine tra una peculiare normalità e la psicosi, e come lo stesso amore possa assumere queste sfumature. Ha passato infatti quindici anni ad accudire la madre malata, finché non è morta, con un amore e un’abnegazione tali da apparire quasi perversi, per poi sviluppare un amore platonico e ossessivo per Alicia, che dopo essere stata investita in un giorno di pioggia viene ricoverata proprio nella clinica dove Benigno lavora e dove è molto stimato e amato da alcuni colleghi ma guardato con sospetto dagli altri.
Si direbbe che queste due coppie entrino in contatto per caso, ma evidentemente Almodóvar fa di tutto per farci credere che il caso, in certe situazioni, non esiste. Benigno e Marco si incontrano per la prima volta durante uno spettacolo di Pina Bausch, Café Müller. Marco non si accorge di Benigno, ma quest’ultimo rimane molto colpito da lui, che senza nessuna vergogna si commuove più volte durante la performance.

Spesso ci sono cose che dovrebbero apparirci ovvie ma che non riusciamo a vedere, di noi stessi e degli altri. L’arte – la musica e il teatro in particolare – appaiono come momento di incontro silenzioso con l’inconscio collettivo e al tempo stesso di intimo e irrimediabile disvelamento. Le melodie e i movimenti sembrano richiamare una coscienza sopita che tutti condividiamo. In una delle scene più belle del film, una sorta di tuffo nella memoria di Marco subito dopo l’incidente che porta Lydia al coma, Caetano Veloso canta accompagnato da un contrabbasso, un violoncello e una chitarra che appena si sente. La sua voce di passero nella mente di Marco si intreccia alle scene di Café Müller di Pina Bausch. Grazie alla musica Marco mette insieme il tempo, i ricordi e le emozioni e inizia a intuire che Lydia, nonostante il suo grande amore, non era per lui. È come se da quel momento il personaggio di Marco sapesse che dovrà andare incontro alla separazione totale: inizia così il suo distacco dopo la grave ferita che il toro ha inferto a Lydia all’inizio della sua corrida, dal profondo. Di questo prendere distanze negato si accorge subito Benigno, grazie alla sua immensa sensibilità e capacità di osservazione, così come riconosce Marco appena lo rivede, nonostante sia passato diverso tempo dalla prima volta.
Almodóvar mette in scena due esempi di mascolinità alternativi, apparentemente distanti ma con molti più punti di contatto di quanto si potrebbe immaginare, che infatti gli permettono di incontrarsi, capirsi, instaurare una profonda relazione di affetto. Marco e Benigno sembrano quasi due facce di una stessa medaglia. Marco in Benigno vede un sé più fragile, quasi bambino, ancora avviluppato nella profonda, commovente e straziante relazione col materno, che incarna una sola e unica idea di donna e di amore. Benigno, allo stesso modo, vede in Marco ciò che sarebbe potuto essere se le cose fossero andate diversamente, un uomo capace di agire e di vivere a pieno la vita e i sentimenti, pur portando una ferita lacerante. Per questo l’amicizia tra questi due personaggi è tanto toccante, perché nel loro affezionarsi l’un l’altro la persona maschile risulta ricomposta in tutta la sua forza e la sua fragilità.

Per tutto il film, oltre che in numerose recensioni, sembra serpeggiare l’idea che il male che queste due donne hanno subito sia – in qualche modo in questo caso impossibile da spiegare – causato dagli uomini; eppure non è così, questi due uomini non sono colpevoli, sarebbe troppo facile, e questa fosca innocenza non appare mai come una giustificazione buonista. Colpevole è il caso. Alicia è in coma, la sua corteccia cerebrale, come spiega il medico anche a Marco in riferimento a Lydia, non risponde più, è in stato vegetativo e nulla la farà tornare come prima. Ma Benigno non si rassegna e vorrebbe che nemmeno Marco lo facesse. Marco non è però più in grado di dire nulla (da qui entrano in gioco i corpi, il canto e il movimento, la danza, quando la parola zoppica) e lascia la parola a Benigno, che cerca di smuoverlo, di risvegliarlo, quasi fosse in un una sorta di coma anche lui, e in qualche modo ci riesce. Con Benigno il regista porta in scena una maschilità infantile, fluida, malinconica, vinta, che si sente messa in dubbio, che invece di rispondere con violenza e aggressività a questo non riuscire a far parte del mondo, si annienta definitivamente, cosa che di rado siamo abituati a vedere raccontata. Se all’inizio a piangere era Marco, alla fine a piangere è Benigno, e in questo atto sembra ritornare ad appartenere al mondo.

In Parla con me si piange tanto e il pianto si fa messaggio e pioggia dal cielo che placa l’animo, consola, rassicura, libera. “De pasión mortal” si muore, come canta Veloso, ma si rinasce anche. Lo suggerisce Katerina, la direttrice della scuola di danza di Alicia (interpretata da Geraldine Chaplin), raccontando sul balcone la sua nuova coreografia ambientata nelle trincee della prima guerra mondiale. Quando i soldati muoiono, infatti, dal loro corpo emerge l’anima, il fantasma, e quest’anima sarà una ballerina, con il tutù insanguinato. Dalla morte emerge la vita, dal maschile il femminile, da ciò che è terreno l’effimero. Benigno fa fatica a seguire, per non dire che non capisce proprio niente, ma la segue rapito, così come Marco dall’altro lato dell’edificio. Per trasfigurarsi sembra essere necessario affrontare una battaglia in cui in gioco è la vita. Almodóvar mette così in scena un melodramma che riprende le regole della tragedia antica. Il destino dei personaggi, infatti, è già segnato e non possiamo che accompagnarli mentre maestosamente lo percorrono, con tutto il loro dolore. E in fondo quello per cui piangono non è altro che la loro anima.


Al tema della parola si interseca poi quello dell’attesa e della fede. Ancora una volta Almodóvar ci prende in giro, smascherando la meschinità dei nostri pregiudizi. Benigno, infatti, dopo l’accusato di aver abusato di Alicia viene internato in carcere e quando Marco lo va a trovare gli dice che lo pensa spesso, soprattutto di notte; Marco è perplesso, gli chiede come mai, e Benigno gli risponde che è perché di notte studia e legge le guide turistiche che lui stesso gli ha regalato. Gli dice che la sua preferita è quella su Cuba, perché lì le persone non hanno niente e si inventano tutto. Benigno ammette di sentirsi come quella ragazza di cui scrive Marco, che aspetta inutilmente alla finestra, guardando il mare, e intanto il tempo passa senza che succeda nulla. Sostiene anzi di essere proprio quella donna, di averla dentro di sé.

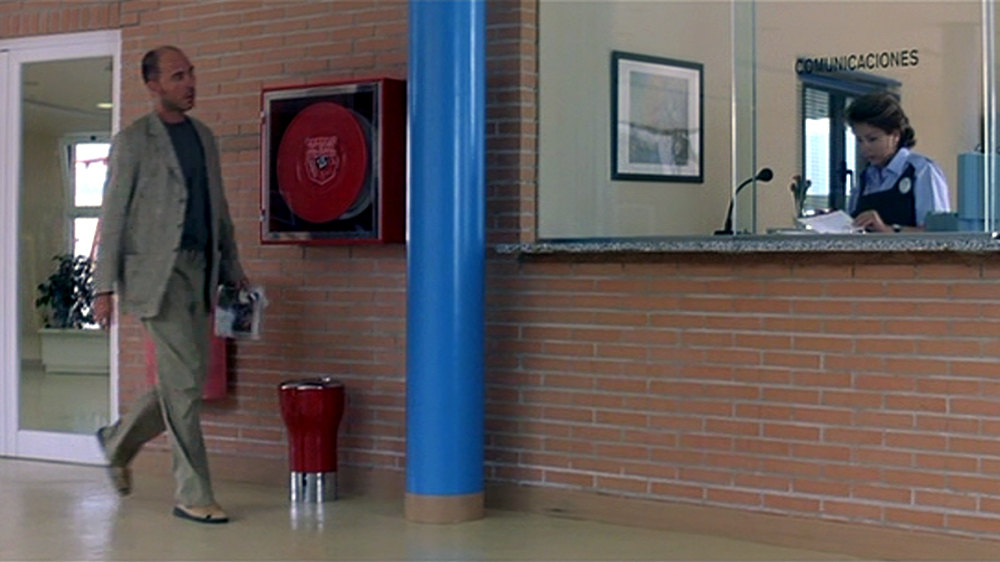

Almodóvar ci suggerisce che si può credere ai miracoli e non solo alle leggi degli uomini, perché nonostante tutto, per fortuna, resta qualcosa che non ci possiamo spiegare. Alicia, infatti, dopo la gravidanza e l’aver dato alla luce un bambino morto si risveglia, e per caso, durante la rappresentazione di un altro spettacolo di Pina Bausch, Mazurca Fogo, a cui è andata insieme a Keterina, incontra Marco. Alicia ovviamente non può riconoscerlo, ma Katerina, visibilmente scossa, quando lo vede gli dice che prima o poi dovranno parlare. Marco le dice di non preoccuparsi, che probabilmente sarà molto più semplice di quanto crede. E lei risponde: “Niente è semplice. Sono una maestra di danza classica e niente è semplice”. E da lì ricomincia il secondo tempo della coreografia – una lunga fila di coppie che avanza con uno strano ritmo – e il possibile terzo capitolo del film “ALICIA E MARCO”. Almodóvar, con le parole di Katerina, sembra augurare a noi e ai suoi personaggi un mondo in cui tutti danzano, perché la vita è così, molto più semplice o molto più complessa di quanto ci si aspetti di volta in volta. Non possiamo fare altro che attraversarla, come se stessimo ballando, pur rischiando di apparire burattini rotti, che ripetono gesti meccanici, proprio come nelle coreografie di Pina Bausch.