Sempre più società, agenzie governative, istituzioni per l’istruzione e organizzazioni filantropiche si trovano oggi prigioniere di un nuovo fenomeno a cui ho dato il nome di “fissazione per le rilevazioni”. Uno dei suoi aspetti chiave è l’idea che sia possibile, oltre che desiderabile, sostituire il giudizio professionale, acquisito attraverso il talento e l’esperienza personale, con indicatori numerici della performance relativa, basati su una serie di dati standardizzati. O che il modo migliore per motivare il personale di queste società sia di assegnare ricompense e punizioni alla performance rilevata.
Queste ricompense possono essere monetarie, come nel caso degli incentivi pecuniari offerti per una buona prestazione lavorativa, o legate alla reputazione, come i ranking di università e ospedali, o le pagelle proposte per i chirurghi. Uno degli effetti più negativi di questa ossessione, però, è di rendere tutto un gioco: si incoraggiano infatti i professionisti a massimizzare gli indicatori di performance secondo modalità che sono spesso in contrasto con lo scopo più ampio di una società o di un’istituzione. Se, ad esempio, il tasso di reati gravi è l’indicatore in base al quale vengono promossi gli ufficiali di polizia, alcuni di questi finiranno per non riportare gli atti criminali a cui assistono, o per declassarli da reati gravi a semplici infrazioni. Pensate ancora al caso dei chirurghi: se vengono resi pubblici i dati relativi alle loro performance, che possono andare a intaccare la loro reputazione e le loro entrate, alcuni di loro cercheranno di migliorare la propria posizione rifiutandosi di operare sui casi più complessi e di evitare così possibili risultati negativi. A perderci, però, sono i pazienti che non ricevono gli interventi necessari.

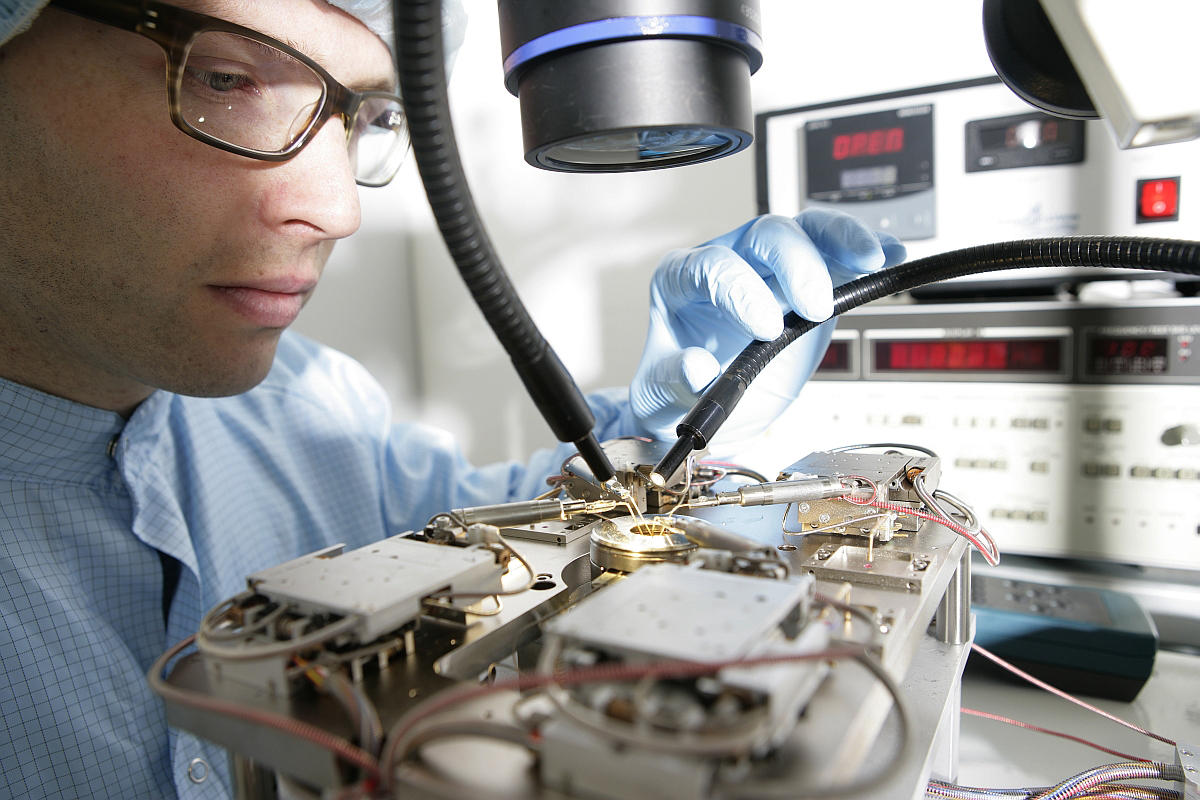
Quando si lega una ricompensa a una particolare prestazione professionale, l’ossessione per la misurazione porta facilmente a questo genere di gioco. Oltre a ciò, però, c’è anche tutta un’altra serie di conseguenze negative più subdole. Una società o un’organizzazione possono infatti perdere di vista il proprio obiettivo principale, e ciò può avvenire in diversi modi. Quando una prestazione viene giudicata secondo determinati parametri e la posta in gioco è alta – il mantenimento del posto di lavoro, un possibile aumento dello stipendio o del valore dei titoli di una società quotata in Borsa – è proprio su quei parametri che ci si concentra. L’esempio più conosciuto è quello dell’insegnamento esclusivamente funzionale al raggiungimento di buoni punteggi nei test standardizzati, una tendenza che ha stravolto l’istruzione primaria e secondaria statunitense fin dal momento dell’entrata in vigore del No Child Left Behind Act del 2001.
Un’altra conseguenza negativa è che si finisce per pensare solo a breve termine. La misurazione delle prestazioni incoraggia quello che il sociologo statunitense Robert K Merton nel 1936 definì “La prepotenza degli interessi immediati, per cui la preoccupazione principale di un soggetto per le conseguenze previste e immediate finisce per escludere qualsiasi tipo di considerazione in merito a quelle alternative e più distanti”. In parole povere, significa promuovere gli obiettivi a breve termine a scapito di qualsiasi tipo di considerazione più lungimirante. Questo è un problema endemico tra le società quotate in Borsa, che sacrificano le iniziative di ricerca e sviluppo di più ampio respiro, o la crescita del proprio personale, per sottostare ai presunti imperativi delle relazioni trimestrali.
Al lato più scuro della medaglia bisogna anche aggiungere i costi economici di queste misurazioni: prima di tutto, in termini di tempo impiegato dai dipendenti incaricati di raccogliere e processare tutte queste informazioni, per non parlare di quello richiesto per esaminarle. Come notano i consulenti di management Yves Morieux e Peter Tollman, in Smart simplicity. Sei regole per gestire la complessità senza diventare complicati, questi finiscono per lavorare più a lungo e con maggiore impegno ad attività che contribuiscono poco alla produttività dell’azienda, perdendo via via il proprio entusiasmo. Spesso, poi, nel tentativo di evitare rilevazioni errate le società istituiscono una lunga serie di regole, sebbene lo stesso sforzo per rispettarle comporti un rallentamento delle funzioni e una diminuzione dell’efficienza di tutta la macchina organizzativa.

Al contrario di quanto potrebbe suggerire il buon senso, gli sforzi per misurare la produttività attraverso indicizzazioni della performance disincentivano lo spirito d’iniziativa, d’innovazione e la propensione ad assumersi rischi. Gli analisti dei servizi di intelligence che si sono occupati della cattura di Osama bin Laden hanno impiegato un anno prima di riuscire a localizzarlo. Se la loro performance fosse stata misurata in un qualsiasi momento prima dello storico Zero Dark Thirty, la loro produttività sarebbe stata nulla. Mese dopo mese, il loro tasso di fallimento è rimasto stabile al 100%, fino al momento in cui hanno avuto successo. Se guardiamo il tutto dall’ottica dei loro superiori, lasciare che questi professionisti lavorassero al progetto per anni ha comportato un’alta percentuale di rischio: l’investimento avrebbe potuto non ripagare col tempo. In realtà, tutti i grandi risultati spesso dipendono da simili azzardi.
La base del problema è che le persone, quando vengono giudicate sulla base di parametri di performance, sono incentivate a fare proprio ciò che questi rilevano, che solitamente consiste in qualche obiettivo prestabilito. Questo però frena l’innovazione, impedisce di fare tutto ciò che non è stato ancora testato. Perché ci sia innovazione deve prima esserci la sperimentazione, che per definizione include la possibilità, o la probabilità, del fallimento. Allo stesso tempo, offrire ricompense individuali per le prestazioni rilevate intacca il senso di sforzo collettivo, così come le relazioni sociali che motivano la cooperazione e l’efficenza finiscono invece per promuovere la competizione.

Riunire le persone in un’organizzazione per concentrare i loro sforzi su una gamma ristretta di compiti snatura l’esperienza stessa del lavoro. Vincolati dalle rilevazioni, ci si trova costretti a focalizzarsi su una serie limitata di obiettivi imposti da persone che possono anche non capire davvero la natura delle nostre mansioni. A pagarne le conseguenze è la stimolazione mentale, che diminuisce nel momento in cui non si ha il potere di decidere che problemi risolvere o in che modo farlo. Non esiste più il brivido dell’inesplorato, visto che non c’è modo di misurarlo. I lati più intraprendenti della natura umana finiscono per essere soffocati da questa fissazione per le misurazioni.
Le società e le istituzioni schiave delle rilevazioni finiscono per allontanare i membri del loro staff con maggiore spirito di iniziativa, portandoli a cercare posti di lavoro fuori dal mainstream e a evitare quella cultura della performance costantemente monitorata. Gli insegnanti lasciano le scuole pubbliche, spostandosi in quelle private o paritarie. Gli ingegneri si licenziano dai grandi gruppi per cercare un posto in studi più contenuti. Gli impiegati pubblici più intraprendenti si convertono in consulenti. Certo, non si tratta per forza di un fenomeno totalmente negativo. Ma di sicuro questa fuga dei dipendenti più innovativi ha contribuito a impoverire le maggiori organizzazioni della nostra società. Più il lavoro diventa una questione di compilazione e registrazione, meno attirerà chi pensa fuori dal gregge. Economisti come Dale Jorgenson, dell’università di Harvard, che si specializzano nella misurazione della produttività, hanno osservato che negli ultimi anni l’unico aumento della produttività totale dei fattori negli Stati Uniti si è verificato nel settore dell’informatica. La domanda che va posta a questo punto, quindi, è questa: fino a che punto il culto delle misurazioni – con tutti i suoi costi a livello di tempo, spirito d’iniziativa e morale dei dipendenti – ha contribuito alla stagnazione economica di oggi?
Questo articolo è stato tradotto da Aeon
Jerry Z Muller è professore di storia alla Catholic University of America di Washington. Il suo libro più recente è The Tyranny of Metrics (2018).